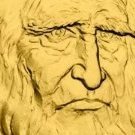Classifica
Contenuti più popolari
Elenco dei contenuti che hanno ricevuto i maggiori apprezzamenti il 08/07/23 in tutte le aree
-
Complimenti @Ptr79, davvero una splendida cartolina . Più che una cartolina "umoristica", questa fa parte di quelle cartoline "satiriche" propagandistiche, prodotte durante la guerra (ma anche prima che l'Italia entrasse ufficialmente in guerra), che miravano a ridicolizzare il nemico e farlo vedere alla popolazione come "facile da sconfiggere". La produzione non si limitava alle cartoline ma anche ai manifesti e alle testate giornalistiche. Oltre a quelle satiriche, sono state prodotte anche quelle "terroristiche", in cui il nemico, incarnazione del male, è sempre rappresentato come un essere privo di umanità, un sadico assassino, ridicolo ma estremamente crudele. In entrambi i casi, il nemico che viene sconfitto, viene descritto visivamente in modo tale da suscitare, a seconda dei casi, ilarità, disprezzo, odio e indignazione. In quella postata è evidente il fatto che il pilota non sia altri che l'Imperatore Francesco Giuseppe (identificabile dall'alta uniforme bianca che era solito usare), mentre siede sul trono e porta con se un paniere carico di vettovaglie, tra cui spicca la forca ... sistema di repressione prediletto degli austriaci per eseguire le sentenze di morte contro gli irredentisti... e non solo. Quindi una sorta di gita turistica su un velivolo ridicolo, che è destinata a fallire grazie al proietto di artiglieria (i missili non esistevano ancora) che gli sta per arrivare nel deretano (mai frontalmente ... sarebbe meno offensivo). Ogni nazione ne ha prodotte (sia cartoline che manifesti) davvero una quantità incredibile. Posto alcuni esempi tratti da "I Manifesti" e "Il piccolo Re"... Libri a cui tengo moltissimo e che fanno parte della mia collezione personale. 1) Cartolina austriaca in cui il soldato austriaco giganteggia su un ridicolo sovrano italiano. 2) Vignetta inglese (prima utilizzata come manifesto e poi trasformata in cartolina propagandistica) in cui l'infermiera tedesca getta a terra le medicine destinate ad un fante inglese sotto l'occhio compiaciuto del Kaiser Guglielmo e dell'Imperatore Francesco Giuseppe 3) Vignetta anteguerra, in cui un Vittorio Emanuele III viene tirato da una parte dal Kaiser Guglielmo e dell'Imperatore Francesco Giuseppe e dall'altra dallo Zar Nicola II, dal presidente francese Raymond Poincaré e dal Re Giorgio V. 4) Vignetta tedesca in cui i serpente inglese minaccia un infante tedesco ... la scritta vuol dire "Pensate ai vostri figli". Andrea P.S. Mi scuso con i puristi della nobile arte della fotografia per le immagini fatte di fretta e senza una adeguata esposizione e cura.4 punti
-
Salve chiedo maggiori informazioni sulla cartolina in foto, rientrante in una raccolta molto carina di cartoline avente ad oggetto “Umorismo”. ringrazio in anticipo2 punti
-
Salve chiedo maggiori informazioni sulla cartolina in foto, rientrante in una raccolta molto carina di cartoline avente ad oggetto “Umorismo”. ringrazio in anticipo2 punti
-
Salve chiedo maggiori informazioni sulla cartolina in oggetto, rientrante in una raccolta molto carina di cartoline avente ad oggetto “Umorismo”. ringrazio in anticipo2 punti
-
Salve chiedo maggiori informazioni sulla cartolina in oggetto, rientrante in una raccolta molto carina di cartoline avente ad oggetto “Umorismo”. ringrazio in anticipo2 punti
-
Salve chiedo maggiori informazioni sulla cartolina in oggetto, rientrante in una raccolta molto carina di cartoline avente ad oggetto “Umorismo”. ringrazio in anticipo2 punti
-
Mentre i solidi e i tremissi di Benevento ricalcano quelli bizantini, il tremisse del regno d'Italia ha un elemento di rilevante novità. Sul rovescio, infatti, compare per la prima volta un santo, in questo caso San Michele Arcangelo, protettore dei Longobardi. La raffigurazione dei santi sulle monete ebbe in seguito un enorme successo. Arka Diligite iustitiam2 punti
-
Sicuramente saranno esistite statue di quel tipo. L'iconografia di Vittoria era, nel mondo Romano, proprio quella della didracma repubblicana e del successivo vittoriato: andante, girata di tre quarti, con le ali spiegate e le braccia alzate (due braccia, a differenza di quella siracusana, che ne alza solo uno) a porgere il pegno della vittoria. Lo dimostra la sua unica (per quanto io sappia) statua enea pervenutaci, la Vittoria del capitolium di Brescia. Probabilmente aveva queste sembianze anche la Vittoria contenuta nella curia del Senato sino a che l'iconoclastia cristiana ne ha preteso la distruzione. Il tema dei trofei d'armi, per parte sua, era diffusissimo nella scultura romana. Basta citare quelli marmorei oggi esposti al Campidoglio, cosiddetti "trofei di Mario".2 punti
-
La forma triangolareggiante può essere scomposta in quattro forme principali, senza che vi sia una netta divisione tra l'una e l'altra. Forme triangolareggianti: a) tondello equilatero con i tre lati curvilinei; b), c) e d) con angoli al vertice rispettivamente di 45, 60 e 90°. Una moneta può essere spezzata agevolmente in due o in quattro parti: ogni altra spezzatura appare di difficile realizzazione e quindi improbabile. La spezzatura in quattro parti da origine a quattro tondelli triangolareggianti con un angolo di 60° ed il lato opposto curvilineo, che è quanto si osserva con maggiore frequenza. Tuttavia, la spezzatura non è agevole e spesso darebbe origine a tondelli con un angolo maggiore di 60°, sino a 90°, o minore di 60°, sino a 45°, che è quanto si osserva. Inoltre, poiché buona parte di queste monete triangolareggianti può inscriversi in un cerchio di circa 15 mm di diametro, ne consegue che se fossero originate dalla spezzatura di una vecchia moneta, questa dovrebbe avere un diametro di circa 30 mm con uno spessore simile a quello dei nummi del V secolo: un diametro incompatibile con i numerali del IV secolo, i maggiori dei quali – maiorine e decargiri – hanno un diametro di circa 20 mm, e anche quello dei follis nati dalla riforma diocleziana, circa 25 mm, non appare coerente con la dimensione delle monete triangolareggianti battute i nome di Valentiniano III e, inoltre, hanno uno spessore forse eccessivo. Invece, la forma equilatera con i tre lati tondeggiante e i tre vertici approssimativamente di 60°, sembra essere il risultato di un tondello al quale si è voluto dare questa forma, e non il risultato di una spezzatura di una vecchia moneta. Quale spiegazione dare a questa particolare forma di queste emissioni controverse in nome di Valentiniano III? Sono il risultato della spezzatura di vecchie monete (con successiva ricottura in forno sin quasi al punto di fusione), o sono il risultato di un tondello volutamente con questa forma?2 punti
-
Salve chiedo maggiori informazioni sulla cartolina in oggetto, rientrante in una raccolta molto carina di cartoline avente ad oggetto “Umorismo”. ringrazio in anticipo1 punto
-
Non si può acquistare per il semplice motivo che non è in vendita. Viene distribuito gratuitamente in determinati incontri, il primo sarà a "Milano Numismatica" l'11 novembre prossimo. Il formato digitale, solitamente viene pubblicato dopo sei mesi dalla prima consegna del cartaceo. Per ulteriori informazioni: Per partecipare è necessario prenotarsi presso @dabbene dato il numero limitato di posti.1 punto
-
1 punto
-
Si , la statua della Vittoria nella Curia del Senato aveva (forse) questo atteggiamento scultoreo con la sola differenza che era in oro ; statua probabilmente presa a Taranto come bottino di guerra . Nella Curia del Senato romano , dall' anno 29 a. C. , Ottaviano , in ricordo della sconfitta e morte di Marco Antonio , pose nella Curia un altare posto come base per la statua d' oro della Vittoria presa ai Tarantini . La statua ritraeva (forse) una donna alata che portava una palma e una corona di lauro , questi attributi sono quelli che si suppone portasse nelle mani , ma non e' certo che la statua della Vittoria posta nella Curia del Senato avesse queste movenze scultoree , forse ritraeva una donna alata con un piede posto su un globo e una corona di alloro in mano come compare in alcune monete del tempo di Augusto . Quale realmente fosse la Vittoria che tante discordie provoco' tra Cristiani e Pagani gia' sul finire del IV secolo , non e' certo . La Vittoria comunque venne rimossa per la prima volta nel 357 dall'imperatore Costanzo II , fervente ariano , ma fu ricollocata in Senato durante il regno di Giuliano . Nel 382 Graziano , accogliendo le richieste di Ambrogio di Milano , Vescovo dell' allora capitale della Parte Occidentale dell' Impero , la fece nuovamente rimuovere dall' aula del Senato . Seguì nel 384 , sotto il regno di Valentiniano II , la famosa disputa tra Ambrogio di Milano e Quinto Aurelio Simmaco , Senatore pagano e fiero oppositore del cristianesimo che , da Prefetto di Roma , si prodigò per la reintegrazione dell' Ara e della statua in Senato . Alla morte di Valentiniano II l' altare fu nuovamente ricollocato nella sede del Senato da Eugenio nel 393/4 , per essere definitivamente rimosso nel 394 da Teodosio dopo la vittoria al Frigido su Eugenio . Un solido emesso da Costantino II ne riproduce le sembianze con entrambe le braccia alzate che tengono in mano una corona di alloro e una palma , simboli di Vittoria e Pace (Pax Romana) Un interessante vecchio articolo su questa statua : https://www.bing.com/ck/a?!&&p=f51d262107af756bJmltdHM9MTY5MTM2NjQwMCZpZ3VpZD0xZTk5MDAzMi1hNTdiLTYyZjUtMjZmYS0xMjU0YTQ0YzYzNTkmaW5zaWQ9NTIzNQ&ptn=3&hsh=3&fclid=1e990032-a57b-62f5-26fa-1254a44c6359&psq=la+statua+della+vittoria+di+Taranto&u=a1aHR0cHM6Ly93d3cubGFtb25ldGEuaXQvdG9waWMvMTM2MTU0LWxhLXZpdHRvcmlhLw&ntb=11 punto
-
Ciao. Ritorno su questa questione. Bisognerebbe capire cosa si intenda esattamente per manomissione. Anche la "manomissione" fa parte del processo evolutivo di un sito essendo costituito da una o tutte le azioni di asporto. apporto e trasformazione https://people.uniud.it/sites/default/files/Manuali I. Scavo.pdf1 punto
-
1 punto
-
Salve. Volevo condividere questo esemplare con la cifra 1 del millesimo completamente abrasa, lasciando una leggerissima traccia che si vede molto poco. L’abrasione ha interessato anche la prima X dell’anno XX, che però è ancora ben visibile. apollonia.1 punto
-
1 punto
-
Salve chiedo maggiori informazioni sulla cartolina in oggetto, rientrante in una raccolta molto carina di cartoline avente ad oggetto “Umorismo”. ringrazio in anticipo1 punto
-
1 punto
-
1 punto
-
Leu Numismatik AG > Web Auction 26 Auction date: 8 July 2023 Lot number: 2335 Price realized: 160 CHF (Approx. 180 USD / 164 EUR) Note: Prices do not include buyer's fees. Lot description: CILICIA. Tarsus. Hadrian, 117-138. Tridrachm (Silver, 22 mm, 10.59 g, 1 h). ΑΥΤ ΚΑΙ ΘΕ ΤΡA ΠΑΡ ΥΙ ΘΕ ΝΕΡ ΥΙ ΤΡΑI ΑΔΡΙΑΝΟϹ ϹEB Laureate head of Hadrian to right. Rev. TΑΡϹΕΩΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩϹ City-goddess, turreted and veiled, seated left, holding palm in her right hand and cornucopiae in her left; at feet to left, river-god Kydnos, crowned with wreath of sedge, swimming left. Prieur 761. RPC III 3262. Graffito of 'AXI' on the obverse and with a scratch on the reverse, otherwise, good very fine. Starting price: 50 CHF ILLUSTRAZIONE: LA TICHE DI ANTIOCHIA, COPIA MARMOREA DI UN ORIGINALE GRECO IN BRONZO DEL III SECOLO A.C. OPERA TI EUTICHIDE, MUSEI VATICANI1 punto
-
Non ho mai visto una bolla insieme al documento che conteneva. Ho cercato anche in internete, ma foto di bolle ancora sigillate non ho viste nemmeno una. Possiamo solo immaginarla?1 punto
-
Per un esemplare di tipologia Commodo (giovane) con corazza e paludamento/Cavallo al pascolo, zecca di Alessandria (Troade), la data è ca. 177-179. https://rpc.ashmus.ox.ac.uk/coins/4/148 apollonia1 punto
-
DE GREGE EPICURI Sembra una delle emissioni anonime, per le quali è difficile risalire al periodo preciso. C'è uno studio di Tomaso Lucchelli uscito anni fa sulla RIN, non ricordo l'anno preciso.1 punto
-
Ungheria re Coloman 1095 - 1116 denaro. Riguardo all' autenticita' non mi esprimo.1 punto
-
Interessante discussione, ammetto che ne sono attratto anch'io ma non ho mai approfondito,ho solo due chiavi che se non sono antiche sono abbastanza vecchie,oggi se riesco posto qualche foto... Di testi per le chiavi ne ho visti e comunque so che ci sono molti collezionisti di questi affascinanti oggetti...1 punto
-
attenzione... dire che molte monete siano "imitative" o "non ufficiali" o comunque che si discostino dalla "norma"...usate il termine che volete.... e dire che siano coniate in Africa, (quindi sotto una autorità? o no?) sono due cose ben distinte... ma nettamente la penisola italica, soprattutto nel V secolo è una terra di imitative ben oltre ciò che la vulgata ci passa... Diventano sempre tutte vandale, protovandale o vandaliche, come diceva il Wroth, e ancora ce lo si porta dietro, quando, e ci tengo sempre a citarla, Cesano nel 1913 (!!!!) già scriveva queste illuminanti parole, che vi metto volutamente in neretto perché a più di 100 anni di distanza sono ancora poco ascoltate, soprattutto dalla numismatica diciamo "da negozio" o da quella "a braccio"...(che non è quella di questa discussione ci tengo a precisarlo)..... scriveva quindi la Cesano, ripeto, 1913, criticando Wroth senza mezze misure: Come si può apporre ai Vandali questo gruppo di pezzi tanto numerosi su tutta la penisola italica? Sinora mancano dunque prove e ragioni che confermino la attribuzione del De Salis e del Warwich Wroth, laddove abbondano le une e le altre per considerare primieramente quegli esemplari quali vere e proprie contraffazioni sorte sul suolo italiano nell’età preostrogotica .... e questa frase, per chi ha visto le monete da scavo in Italia, e studiato i ritrovamenti, andrebbe scolpita sulla pietra saluti Alain1 punto
-
Ma si formerebbero anche delle incrostazioni col tempo difficili da eliminare. Considerate anche questo prima di "sacrificare" le monete e la storia che portano con sé.1 punto
-
1 punto
-
Provo a ipotizzare una conclusione. La novella IX,23 del Codex Theodosianus promulgata il 12 aprile 395 stabilisce che il nummus sia l’unica moneta di bronzo utilizzabile e che ogni altra moneta vada sequestrata: “Impp. Arcadius et Honorius aa. Dextro praefecto praetorio. Centenionalem tantum nummum in conversatione publica tractari praecipimus maioris pecuniae figuratione submota. Nullus igitur decargyrum nummum alio audeat commutare, sciens fisco eandem pecuniam vindicandam, quae in publica potuerit conversatione deprehendi. Dat. prid. id. april. Mediolano Olybrio et Probino conss.”. Questa legge che proibisce l’uso di nominali diversi dal nummo, suppone che con anteriorità fosse stato decretato che questi massimali dovessero essere consegnati alle autorità e cambiati forzosamente con nummi: in questo modo fu possibile recuperare bronzo da destinarsi alla loro coniazione. Mentre nelle zecche imperiali le monete ritirate furono rifuse per produrre nuovi tondelli, è plausibile che a Cartagine, invece, fossero spezzate, ricotte e poi riconiate, forse a caldo, sì da cancellare le impronte precedenti. Da qui che queste monete triangolari dovute alla spezzatura di AE2 (decargiri o simili) siano proprie di Cartagine e non di Roma. Diversa la lettura delle monete dal modulo triangolare equilatero non derivato dalla spezzatura che invece appare anche per monete della zecca di Roma e non solo di Cartagine. Provo a ipotizzare un riempimento incompleto dello stampo a causa di una composizione della lega poco fluida (come nell'immagine postata): resta da spiegare perché l'incompletezza del riempimento possa assumere una forma triangolare, ma se si osservano queste monete collocando in alto l'ingresso del metallo, la forma triangolare diventa più simile a una goccia.1 punto
-
la 2133 è ancora della serie con la lettera d'officina.... quindi decisamente precedente per le 2150 e 2151 di cui ho diversi esemplari, dovrò girarteli in forma riservata, perchè molti non sono pubblicabili ... a oggi ormai ho qualche decina di migliaia di monete per la revisione che sto fsacendo, e molte le ho fotografate nei musei, e non posso divulgarle per Valentiniano ad esempio ho 552 monete indiscutibilmente classificabili con il ric (officina e legende incluse) e circa 1000 la cui classificazione è incerta per spezzatura di legenda o officina almeno.... certo nulla a confronto di Leone I di cui ho 2700 monete1 punto
-
se quella che citi è quella che hai messo lì... non viene da ebay, ma da Jean Elsen che citava anche la moneta come ritrovamento cartaginese... e comunque è ROΛ l'ultima di questo post è di Teodosio II e non è imitativa, è un TOV per VOT XXX / V ed è una variante nota ma ufficiale1 punto
-
Poemenius. Resto sempre in attesa di vedere l'immagine dei nummi 2150 e 2151 dei quali hai postato l'esergo. Per quanto concerne il 2150, hai ragione tu, la lettura CON che ho dato all'unico esemplare con esergo leggibile che ho in archivio è errata e la lettura corretta è ROM. Il ritratto degli esempi del 2150 è talmente simile a quelli del 2133 che mi fa pensare che nonostante la legenda nominativa completa nei secondi accorciata nei primi, vi sia ben poca distanza di tempo tra la coniazione delle due tipologie, o addirittura sia simultanea. Per il RIC 2151 con legenda SALVS REIPVBLICE, non ho mai visto nessuna immagine, né l'hanno mai vista gli amici con cui discuto sulla monetazione di Valentiniano III. Poiché nel RIC lo descrive con le parole "Victory advancing l. holding trophy over r. shoulder and dragging captive" che sono esattamente le stesse con cui descrive il RIC 2106, con l'aggiunta di uno staurogramma nel campo, mi viene logico pensare che il 2151 sia una variante del 2106 dal quale si distingue unicamente per l'assenza dello staurogramma, e accomunarle entrambe in quanto a periodo di emissione. Penso di aver fatto bene ad escludere i 2150 e 2151 dalle emissioni controverse, ciò che feci molto tempo fa.1 punto
-
riallacciandomi a quanto sopra vi faccio vedere questo schema: si tratta della variazione dell'andamento della provenienza delle anfore trovate nei depositi del porto di Ostia a partire dal 100 a.C e fino al 350 d.C. Emerge chiaramente un crescendo di rapporti commerciali tra il porto di Ostia e i territori del Nord Africa cui si assiste a un progressivo calare della provenienza della merce autoctona e dai territori di Spagna e Gallia. Le merci viaggiavano portando con sé (e lasciando ovviamente in loco) grossi quantitativi di denaro. Il cosiddetto "Tesoro dei sei imperatori" (ripostiglio da nave naufragata nella baia di Camarina, Ragusa) è la testimonianza di come grossi quantitaivi di moneta imitativa di chiara origine gallica venivano portati (e scambiati probabilmente a peso e non a valore facciale) in nord Africa e usati come strumento di pagamento in luogo della moneta ufficiale (stiamo parlando di un ripostiglio del periodo di Probo, anno più anno meno). E' innegabile inoltre come la serie imitativa Divo Claudio (altare e aquila) sia stata importata per le medesime rotte commerciali in nord Africa e abbia dato poi origine a una serie di emissioni locali autoctone dove la moneta importata è diventata modello di imitazione. Ora, ritornando alle monete "triangolari" su cui verte questa discussione, è così peregrino supporre una importazione "a peso" di moneta svilita, non ufficiale, fuori corso o altro continuato nel tempo nelle medesime rotte commerciali e utilizzato come "materia prima" per emissioni create in loco? I depositi sembrano concetrati in nord Africa stando a quel che fin qui è emerso e i ritrovamenti sparsi in altri contesti (anche italici) può far supporre a una sorta di "normale ritorno commerciale" ma in maniera e misura limitata perché evidentemente nei territori dell'impero centrale avrebbero faticato a trovare una collocazione nella circolazione ordinaria. I segni di zecca (Arles, Roma o altro) potrebbero non identificare l'officina emittente, ma solo il tipo imitato: esporto merce -> importo "moneta grezza" -> uso la "moneta grezza" per creare moneta locale ma che rechi l'impronta di una autorità comunque riconosciuta atta a garantire la validità di questa moneta. Da dire poi che imitativa non deve essere sinonimo di brutta o di mancanza di competenza. Il maggior livello incisorio di alcune emissioni a scapito di altre? Oltre alla circolazione delle merci e delle monete circolava anche chi le merci le produceva e le vendeva e analogamente circolava anche che le monete le faceva e che magari si spostava per paghe migliori o per sfuggire a guai in patria o per altre motivazioni professionali o personali e quindi accanto a una importazione di "moneta-materiale da riuso" ritengo non peregrino supporre anche una importazione di "personale e mezzi produttivi" (parlo di importazione in relazione a una possibile natalità nord africana di queste emissioni triangolari). Probabilmente ho buttato giù diversi strafalcioni, ma ho provato a rileggere queste emissioni con gli occhi del III secolo ragionando sul fatto che nonostante i cambi di governi e di equilibri politici, militari e commerciali, di fondo ci sono sempre delle costanti economiche che a fasi più o meno cicliche si replicano. Prendete il tutto quindi con le pinze e come il frutto di una serie di riflessioni a mente libera di un caldo pomeriggio di luglio.1 punto
-
nell'ottica di una produzione "non istituzionale" (non voglio dire "non ufficiale" per i motivi di cui accennavo nel mio intervento precedente) e fuori zecca e quindi in ambito locale si potrebbe spiegare l'abbinata con le tre G: non conta tanto la coerenza tra dritto e rovescio quanto piuttosto "il riconoscimento dato dall'autorità conosciuta dal popolo ripresa per il dritto". Questo ben si confà nell'ottica di una produzione "imitativa" più o meno tollerata dall'autorità ufficiale se non addirittura incentivata o comunque ritenuta necessaria e magari anche "controllata". Ora, l'ambito e il contesto sono completamente differenti, però - richiamo ancora l'analogia con le imitative galliche del III secolo - l'abbondante produzione di minimi nei territori gallici a un certo punto è stata "esportata" in nord Africa dove è divenuta moneta circolante a tutti gli effetti abbandonando il contesto (e lo scopo iniziale) in cui era stata originariamente coniata e dando il via, in loco, a una produzione autonoma che si rifaceva a questa tipologia inizialmente solo importata tramite le rotte commerciali e la triangolazione GALLIA-SUD ITALIA-NORD AFRICA.1 punto
-
Ho letto in grande velocità tutta la discussione. Purtroppo in questo periodo non ho tempo di approfondire molto, ma vedo un sacco di cose interessanti e una discussione di quelle che da tempo mancavano. Ritorno brevemente sull'argomento. Io credo vedo molte analogie con quanto accadeva in Gallia con la produzione di imitative nella fase finale di immissione nel flusso circolante dei cosiddetti minimi. Moneta precedente, frazionata e rimaneggiata (anche se non sempre) per realizzare tondelli vergini da riconiare. Per quel che conosco io la similitudine la vedo qui: nella tecnologia produttiva. Non ho competenza per discernere tra imitative e ufficiali su questa tipologia. Per voi conoscitori della materia un'analisi sulla tipologia di autorità emittente/rovescio/zecca(o pseudo tale) abbinata alle informazioni sui ritrovamenti dovrebbe poter fornire qualche dato su cui ragionare (ed è la direzione che ha tracciato @antvwaIa). Poi intendiamoci, con il termine "imitative" si apre una varietà di scenari non indifferente: fraudolente? di necessità? scarsezza di materia prima? necessità di divisionale spicciolo? Prendete il mio intervento come una bozza, una serie di appunti buttati in velocità e alla rinfusa... Ma appena ho visto le foto ho pensato alle "mie imitative galliche radiate"... E dovrei avere un quarto tagliato in vassoio da qualche parte...1 punto
-
per onestà intellettuale va detto che le 2150 e 2151 sono di Roma ... o comunque riportano RO – RM - ROΛ o simile ... e mai nella vita ne ho vista una con la scritta CON le emissioni galliche del V secolo, hanno poi uno stile abbastanza particolare, mentre queste 2150-51 rientrano nella casistica della numerazione finale di Valentiniano III, e direi che non hanno nulla di gallico. qualche immagine giusto per chiarire... tutte da 2150 e 21511 punto
-
purtroppo i dubbi ci sono... per prima cosa la marca di zecca ... RMS e RMT e secondo, non per importanza, la legenda al dritto D N PLA VALENTINIANVS P F AVG e D N PL VALENTINIANVS P F AVG, che esclude subito Valentiniano II .... peccato che al momento io abbia visto solo 1 esemplare ...e mi manchi il secondo (quello del British) e non credo ne esistano altri.... certo che diverse tipologie in generale saranno emendate, il lavoro è iniziato da 3 anni e conto di concluderlo tra altri 2.... ma non cerco risposte semplici, quindi ciò che ragionevolmente non può essere emendato, come la 2105, non lo sarà... la VRBS ROMA FELIX 1271 ad esempio, è forse un errore di lettura in tutte le tre officine... al momento non l'ho trovata in nessun museo... mi mancano Torino e Bologna che farò a settembre e spero di poter verificare il British e i Capitolini presto, tuttavia, se alla fine non ne troverò nemmeno una, almeno dubitativamente la tipologia rimarrà citata... sono emendate invece le monete di cui posso documentare l'errore di interpretazione, quelle sì1 punto
-
Illyricum. Non si può parlare di "tagli distinti" poiché riportare i 3 angoli è una semplificazione: in realtà c'è continuità tra l'uno e l'altro e non ho notato differenze di peso tra i tipi triangolari, quadrati o rotondi, così come non ci sono differenze statisticamente significative tra una tipologia e l'altra. Il peso medio risulta di 1,30 g (da un campione di 436 monete) e da questo valore si discostano solo due tipologie: lo staurogramma in ghirlanda che è chiaramente una moneta vandala, e la Vittoria con prigioniero, moneta di elevata qualità incisoria e con esergo CON, apparentemente attribuibile ad Arles.1 punto
-
Il RIC X è un ottimo lavoro e Kent ne ha curato la parte relativa a Valentiniano III: una curatela che ha i suoi limiti, essersi mantenuto fedele a quanto scritto nell'articolo del 1988, The Italian bronze coinage of Valentinian III and a hoard of fifth-century Roman bronze coins from El-Djem. Questo scritto costituisce il primo tentativo serio di porre ordine nella monetazione di Valentiniano III ed è una tappa importante nella numismatica. Ma esso nasce dallo studio di un ripostiglio nord-africano e quindi in esso sono presenti moltissimi nummi di coniazione locale, tra i quali anche quelli delle emissioni controverse che Kent dà a Roma. Durante la compilazione del RIC a Kent venne un dubbio in quanto alla loro reale provenienza: “In spite of the mint-marks, attribution to the mint of Rome may be questioned. Die-axis is erratic, and few specimens can be shown to have an Italian provenance, most coming from Tunisia or (to a lesser extent) from Sicily. The possibility that some at least are African should be retained, though the chronology and appearance of undoubtedly African silver and bronze makes it difficult to see where, when and by whom this series could have been struck.”, RIC 1994:174. Tuttavia non volle allontanarsi da quanto aveva scritto nel 1988 e inserì le emissioni controverse tra quelle della zecca di Roma, creando non pochi problemi nella sequenza delle tipologie. Sempre nel RIC X non mancano aspetti controversi: nummi di incerta esistenza annotati senza che esista una loro immagine, come nel caso del RIC 2166 attribuito a Treveri; o il nummo di Valentiniano II dato a Valentiniano III, RIC 2105, la cui legenda VICTORIA AVGGG (!) non dà adito a dubbi. Benvenuto quindi il lavoro avviato da Poemenius per una completa revisione della parte bronzi del RIC X, augurandomi che non si limiti all'inserimento dei tanti nummi assenti dal RIC (solo che per Valentiniano III mancano almeno 6 tipologie!), ma che proceda anche all'eliminazione di quelli la cui lettura appare quanto meno incerta se non errata. Dal canto mio, torno al quesito con cui ho avviato questo post: perché triangolari? con quale tecnica sono stati realizzati nummi nati dalla spezzatura di un tondello rotondo?. Cosciente di quanto sia difficile dare una risposta a questi quesiti.1 punto
-
Poemenius ha messo in evidenza un altro aspetto di questa monetazione controversa che costituisce un capitolo molto enigmatico della numismatica del V secolo: la difficoltà di separare le monete coniate da un'autorità preposta ad esso, dalla monetazione imitativa dovuta a soggetti diversi. Un altro capitolo molto enigmatico, e che si ricollega a quello di cui stiamo discutendo, è definire l'inizio della monetazione vandala: ma preferisco non mettere carne al fuoco. Vorrei, invece, riportare l'attenzione al quesito che ho proposto: perché una forma triangolare e con quale tecnica si spezzano e si riconiano dei tondelli (o monete più antiche). Rispondere che sono triangolari in quanto conseguenza della spezzatura è banale e risponde solo parzialmente al quesito: infatti seppure è certo che le monete ottenute per spezzatura di un flan tondo in quattro parti risultano necessariamente triangolari, vi sono anche monete il cui tondello nasce triangolare, come negli esempi postati precedentemente. L'argomento si complica se prendiamo in considerazione le rare emissioni RIC 2150-2151. La qualità dell'incisione è ben superiore a quella delle altre emissioni controverse; nell'unica in cui si legge bene l'esergo, il contrassegno di zecca sembra CON (!), Arles; dei soli quattro esemplari di cui ho trovato l'immagine, tre sono triangolari. Da notare, inoltre, che il ritratto al dritto mostra sempre lo stesso volto, con gli stessi lineamenti affilati, diversamente dalle altre emissioni controverse dove non esiste un modello di riferimento. L'esistenza di tre monete su quattro di forma triangolare in una tipologia apparentemente riconducibile ad Arles complica moltissimo un discorso già molto complicato.1 punto
-
Che la forma triangolare venga dalla spezzatura di AE2 teodosiani sembra la risposta più ovvia: ma mi paiono troppo un po' grandi per essere dei quarti di maiorine (decargiri). Monete più antiche (per esempio vecchi assi) mi paiono improbabili perché erano troppo spesse. Poi resta in piedi un dubbio: era più semplice spezzare monete in quattro parti e poi ricuocerle sin quasi al punto di fusione per cancellare ogni traccia di conio e arrotondarne gli spigoli, oppure fondere le vecchie monete e colare i bronzo negli stampi? Ma in questo secondo caso, perché fare degli stampi triangolari? Infine, ci sono alcuni esempi per tutte le tipologie dove la forma è di un triangolo equilatero e non sembrano essere il risultato di nessuna spezzatura, ma della volontà di dar loro questa forma... Comprendere il perché di queste monete triangolari potrebbe aiutare a capire se ha ragione Kent dandole a Roma, o Mostecky dandole a Cartagine....1 punto
-
Bentornato ! Non sai quanto mi è mancata la tua erudizione . L'apprezzeranno presto tutti coloro che in questi anni non ti hanno conosciuto. Se vorrai continuare renderai il Forum un posto migliore. Adelchi.1 punto
-
1 punto
-
In epoca romana per fusione. Le tecniche di coniazione sono riassumibili riassumendo in: - coniazioni a fusione - coniazioni a martello - coniazioni meccaniche Le monete coniate per fusione si ottengono colando metallo fuso all’interno di una matrice recante il tipo del dritto e quello del rovescio. Le monete coniate a martellate erano prodotte disponendo un dischetto liscio di metallo, il tondello, fra due coni e colpendo quindi il conio superiore con un martello per imprimere l’immagine richiesta su entrambi i lati. La monete con coniazione meccanica sono ottenute con l’ausilio generalmente un torchio. Si crea un modello in gesso di grandi dimensioni della moneta, il modello viene poi ricoperto con gomma siliconata per creare uno stampo per copiare la moneta in metallo o resina. Successivamente con un pantografo, l’immagine viene ridotta su una matrice d’acciaio dalla quale si creano i coni di lavoro.1 punto
-
1 punto
-
1 punto
-
Per confronto condivido un esemplare di Carlino del 1794 con a fianco il falso d'epoca coniato su un tondello di ottone, purtroppo senza l'argentatura.1 punto
-
Una delle statue piu’ famose della Roma antica , forse la piu’ famosa , anche per la disputa religiosa che ne segui’ nel tardo Impero , e’ certamente quella della Vittoria o Nike , che rimase riverita e venerata nella Curia del Senato per circa 650 anni . L’origine di questa statua inizia in seguito ad una vittoria sui Romani nel 280 a.C. , una delle “amare vittorie” di Pirro , ottenuta dall’ Epirota ad Eraclea ; a seguito della vittoria militare fu eretta a Taranto questa statua in bronzo dorato raffigurante una Nike alata , una Vittoria , che poggiava un piede su di un globo . Probabilmente la statua è stata identificata con relativa certezza in una terracotta conservata nel Museo Nazionale di Taranto che ne riproduce l’iconografia . E’ certo storicamente che la statua fu trasportata a Roma in occasione della presa di Taranto nel 272 a.C. da parte del Console Lucio Papirio Cursore e posta nell’ antica curia del Senato , mentre Augusto nel 29 a.C. , come riporta Cassio Dione , Storia romana , Libro LI , Tomo 22 , la pose nella Curia Giulia , nuova sede del Senato , dove rimase fino all’epoca in cui fu rimossa per sempre e dove Senatori e Magistrati prestavano giuramento . L' opera statuaria fu al centro nel IV secolo d.C. di una famosa disputa , prima nel 357 d.C. sotto l’ Imperatore Costanzo II , che porto’ a Roma l’ Obelisco piu’ alto del mondo ora al Laterano , il quale pero’ per richiesta dei Senatori ancora in gran parte pagani , rimise al suo posto la Vittoria ; questa fu rimossa successivamente una seconda e definitiva volta , quando il Prefetto dell'Urbe , Quinto Aurelio Simmaco , si contrappose aspramente con un famosissimo panegirico , ma inutilmente , a Sant'Ambrogio , vescovo di Milano , in merito alla sua rimozione insieme all'altare che la sosteneva , dall'edificio della Curia sede del Senato , in seguito a un editto di Graziano del 382 e questa volta fu la fine dell' antica e venerata statua . Un reperto di notevole interesse proviene proprio dal Foro di Augusto a Roma , dove negli anni Trenta si rinvenne un frammento di statua , un piede destro in bronzo dorato , sollevato sulle dita , facente parte di una statua di dimensioni maggiori del naturale , circa due metri , raffigurante una vittoria alata . Il piede poggia su un grosso blocco a forma di parallelepipedo , se questo sostegno fosse stato applicato all’ interno di un globo , come sostegno , potremmo trovarci d’avanti proprio ad un frammento della statua originale tarantina portata via da Taranto dal Console Papirio nel 272 a.C.1 punto
Questa classifica è impostata su Roma/GMT+01:00
Lamoneta.it
La più grande comunità online di numismatica e monete. Studiosi, collezionisti e semplici appassionati si scambiano informazioni e consigli sul fantastico mondo della numismatica.
Il network
Hai bisogno di aiuto?