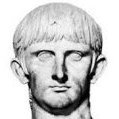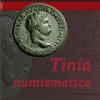Classifica
Contenuti più popolari
Elenco dei contenuti che hanno ricevuto i maggiori apprezzamenti il 11/04/23 in tutte le aree
-
Ciao a tutti , Volevo condividere con voi un evento che ha colpito la mia città: "MELFI" e i paesi limitrofi; un evento che ha portato morte e distruzione , che non tutti conoscono e per questo volevo condividerne la storia , affinché non venga mai DIMENTICATA!! Buona lettura Saluti . Luigi Fra fertili ed estesi pascoli sorge in Basilicata il monte Vulture. Alle sue falde, su un antico cratere collinare c’è Melfi. Lungo la linea del Vulture si trovano Rapolla, Barile, Rionero ed Atella; ad est c’è Venosa. Un antico Castello normanno detto di Monticchio (Castrum Monticuli) dà il nome ai due laghi esistenti, formatisi in due remoti crateri. Il lago piccolo a forma di cono è profondo circa metri 36,00; il lago grande, più antico del primo, è profondo circa 10 metri. Il 14 agosto 1851, sotto un azzurro e sereno cielo estivo, senza un alito di vento e una temperatura soffocante, mentre i contadini spensierati erano intenti al lavoro nei campi, alle due e mezzo del pomeriggio s’intese d’improvviso un gran boato e ci fu una scossa di terremoto così violenta, pari solo a quella del 27 marzo 1638 e a quella del 5 febbraio 1783 nelle Calabrie. Di quest’ultima, i resti dell’antica Certosa di San Bruno[1] con i suoi pinnacoli ruotati ricordano ancora oggi il tragico evento. Al ripetuto sbattere delle finestre e al suono stridente e penetrante dei cardini delle porte spalancate, che si aprivano e si chiudevano ripetutamente, crollavano rovinosamente al suolo gli edifici. L’improvviso rumore dello spezzarsi delle mura, che incuteva terrore, e la soffocante e impenetrabile polvere alzatasi dalle macerie come nebbia foltissima impedivano agli abitanti di cercare una via di fuga e un qualunque scampo in un luogo sicuro. Dopo un sotterraneo muggito della terra e il rumore cupo e sordo delle case cadute, in un silenzio tombale si sentiva solo il lamento dei feriti, il gemito dei sofferenti, le grida disperate di coloro che quasi senza vita o tramortiti erano vicini ai loro cari. Il terremoto fu prima sussultorio e poi ondulatorio. Seguito da fragoroso rombo durò per più di quaranta secondi. Trascorso appena che fu il breve intervallo diun’ora, ci fu una seconda scossa più lieve, annunciata da un cupo muggito sotterraneo, e prima che fosse notte ne venne una terza e poi una quarta e di ora in ora se ne contarono altre undici. Si può soloimmaginare lo spaventodi chi imprigionato sotto le macerie senza vedere una via d’uscita attendeva la morte, e l’angoscia di quelli che trovando le strade bloccate e ostruite da montagne di rovine fino alle finestre delle case più alte vagavano atterriti dal timore delle mura cadenti ad ogni scossa successiva. Un farmacistarimasto sepolto sotto la sua casa batteva inutilmente il mortaio di bronzo per essere soccorso ma quando fu liberato era già morto. Una donna fu trovata morta ginocchioni mentre invano tentava di proteggere il figlio. Dopo due giorni fu tratto in salvo un bambino piccolo trovato sotto la culla rovesciata, che lo aveva protetto. Una bambina di 18 mesi fu trovata ancora viva dopo 3 giorni. Dopo sei giorni fu salvato un bambino di sette anni. Fu di sommo dolore vedere i superstiti melfitani fiacchi e sfiniti, seduti sulle rovine della propria casa, piangere i padri, le madri, le mogli, i figli, i parenti e gli amici! Ovunque c’erano mura cadute o cadenti e tetti sfondati; i più solidi edifici erano stati abbattuti. Dalle macerie sporgevano travi mezzo sepolte, le piazze e le strade erano ostruite da montagne di detriti. Erano andati in rovina: l’antichissimo castello di Federico II; il Duomo di Melfi costruito da Roberto il Guiscardo, già distrutto e interamente ricostruito dopo il terremoto del 1694; il maestoso campanile edificato nel 1151; le quattro Chiese parrocchiali della Città (S. Teodoro, di S. Niccola, di S. Lorenzo, e del Carmine); la Chiesa ed il convento degli Osservanti; la Confraternita laicale dei Morti; il monastero delle Chiariste sotto il titolo di S. Bartolomeo e l’Orfanotrofio. Non rimase intatto un solo edificio pubblico o privato e quelli in parte crollati furono abbattuti, tanto erano essi rovinati. La Chiesa di S. Agostino, dietro alla quale erano le prigioni, cadde completamente. Nel crollo delle carceri morirono 18 detenuti, e quelli che non morirono si adoperarono prontamente per salvare gli altri. Quantunque in pessime condizioni e in parte crollati e rovinati in più punti, il castello di Melfi, l’Episcopio ed il campanile del Duomo erano ancora lì diroccati, a testimoniare la loro antica grandezza. In Atella nella chiesa di Santa Lucia cadde una parete e dopo secoli di oscurità venne alla luce un antico affesco del 1389 della Madonna delle Grazie nell’atto che protegge dall’ira dell’Eterno Padre coloro che si sono rivolti a lei. La notizia del terremoto giunse a Napoli il 17 agosto: Melfi 14 agosto 1851 Signor Direttore Nel momento che le scrivo esco miracolosamente colla famiglia dalle ruine. Una tremenda scossa di tremuoto verso le 3 p. m. ha adeguato al suolo la maggior parte di questo Capoluogo con grave danno di questi abitanti, e lo stesso mi si dice essere avvenuto nei paesi circonvicini. Ho tutto fatto conoscere nel momento al Signor Intendente, chiedendo degl’Ingegneri ed una competente forza per accorrere ai bisogni ed all’ordine pubblico. Lo spettacolo è orribile, ed io interesso la di Lei nota filantropia a dare ordini pressantissimi, perchè si accorra a sgravare in parte queste contrade dai danni immensi di cui si trovano vittima. Perdonerà il modo di scrivere perchè eseguito in mezzo la strada e nella folla della gente che piange dirottamente. Il Sottintendente De Filippis Nello stesso giorno, il Ministro dell’Interno fece partire immediatamente per Melfi l’Intendente con le istruzioni di servirsi di tutti i mezzi disponibili per alleviare la sventura dei danneggiati, soccorrere i feritie provvedere ad ogni altro bisogno delle popolazioni. L’intendente giunse a Melfi il giorno dopo, a mezzanotte e nella sua prima relazione scrisse: «Melfi e Barile non esistono più. Tutti i fabbricati o adeguati al suolo, o prossimi a crollare. Le popolazioni sono sulla via. Pianti! gemiti! Miserie !!!». Il 23 agosto il Re Ferdinando II dispose: Il prelievo di ducati quattromila dalla sua cassa privata e mille dalla cassa della Regina. L’invio di quattro ingegneri di Ponti e Strade, medici e medicine; — L’apertura di una colletta nel Regno per il soccorso dei Comuni danneggiati; — La nomina di una Commissione in ogni Comune, composta dal Vescovo, dal Sotto-Intendente e due probi e zelanti proprietari per distribuire i soccorsi ai soli e veri indigenti in proporzione dei danni subiti; — La distribuzione di pane, vestiti e tutto ciò di cui la popolazione aveva bisogno; — La costruzione di baracche provvisorie; — L’utilizzo di operai della Provinciaper eseguire i lavori, perché potessero provvedere col lavoro al proprio sostentamento; — Il trasferimento delle alunne dell’Orfanotrofio di Barile nell’Ospizio di Avigliano e degli orfanelli nel Reale Albergo dei Poveri a Napoli e nell’Ospizio di S. Ferdinando a Salerno. — Che le agevolazioni fossero destinate ai veri indigenti. — Che i proprietari e i benestanti contribuissero alle spese per la parte che li riguardava; — Che fosse redatto un elenco dei detenuti, che invece di evadere si erano adoperati per salvare le persone coperte dalle macerie ed estrarre i cadaveri, e un elenco di coloro che si erano distinti nei soccorsi. Al 31 agosto già molte strade erano state puntellate e quasi tutti i cadaveri erano stati rimossi e sepolti in fosse profonde con strati di calce e più non si sentiva l’odore della putrefazione ovunque. Ferdinando II accompagnato dal Duca di Calabria Francesco II, il Conte di Trapani, il ministro dell’interno, il ministro dei lavori pubblici e con un gran numero di persone al seguito partì dalla reggia di Portici l’11 settembre per andare a visitare i luoghi colpiti dal terremoto. Il Re giunse a Melfi il giorno 15,verso le cinque del pomeriggio e nonostante piovesse a dirotto volle subito vedere la città attraversando le strade puntellate e passando sui ruderi caduti. Da subito dispose il trasferimento delle monache ad Avigliano, degli orfanelli di Melfi a Napoli e a Salerno e delle orfanelle a Torre Annunziata. Ordinò che fosse prontamente ristrutturata la parte dell’Orfanotrofio rimasta in piedi e che fossero ripristinate tutte le strade provinciali. Il giorno dopo, il Re andò aRapolla, Barile e Rionero, visitò gli Ospedali, le capanne, anche le più povere e sporche e ogni luogo rovinato confortando tutti con parole affettuose e promettendo ogni aiuto possibile. Condonò le pene ai carcerati di Rionero che si erano adoperati per dissotterrare i cadaveri. I detenuti di Melfi che non erano fuggiti ebbero dimunuita la pena di due anni. Lasciò 50 ducati per il sostentamento di un bambino orfano salvato dalle macerie dopo due giorni, e oltre a quelli già versati precedentemente lasciò nella cassa dei soccorsi altri 4000 ducati, più altri mille da fondi personali della Regina. Il 17 settembre andò ad Atella e si recò subito ai ruderi della chiesa di Santa Lucia per venerare l’immagine della Madonna delle Grazie rimasta in piedi tra i ruderi della chiesa. Ordinò al direttore del Museo Stanislao D’Aloe di far venire da Napoli il regio disegnatore di Pompei Giuseppe Abbate (27 marzo 1852) per fare una riproduzione del dipinto. Ordinò altresì al ministro dei Lavori pubblici, che era presente, la completa ricostruzione della chiesa. Tutti i muri erano distrutti, tranne quello della SS. Vergine Maria che sovrastava l’altare maggiore. Dopo il terremoto del 1694, non tenendo conto del disegno originario, i padri Agostiniani, che avevano un ospizio adiacente alla Chiesa di Santa Lucia, avevano restaurato completamente la chiesa. Difatti, porre esporre ai fedeli la statua di Santa Lucia, i monaci agostiniani avevano chiuso con una parete sottile la nicchia piana che dietro l’altare maggiore della chiesa conteneva l’affresco della Madonna delle Grazie. Questa parete era così sottile che i chiodi usati per sostenere gli ex voto donati alla santa avevano rovinato in più punti l’immagine sottostante della madonna. Guardando l’affresco, fra le persone rappresentate che ricorrono alla protezione della Vergine, si riconoscono a sinistra la figura del Papa Urbano VI, il Cardinale Francesco de’ Tibaldeschi, che rimase fedele al Papa fino alla sua morte, il vescovo Tommaso di Rapolla alla cui Diocesi apparteneva Atella, il Vescovo di Melfi e di Lavello, due monaci dell’ordine verginiano e il re Carlo III di Durazzo con i suoi familiari, colpito da un fulmine di Dio. Carlo Durazzo era stato eletto re da Urbano VI con la nobile missione di combattere i nemici della Chiesa. Dopo aver preso possesso del regno, insuperbito aveva combattuto contro il Papa assediato nel castello di Nocera, presso Salerno. L’uomo con la barba corta è, forse, il pittore che aveva dipinto l’affresco. L’uomo colpito mortalmente è Niccolò Spinello, ministro della regina Giovanna I, che aveva spinto i cardinali francesi a contestare l’elezione di Urbano VI e a eleggere un altro papa (Clemente VI); Spinello fu la causa dello scisma. Al lato opposto c’è la regina Margherita del Balzo, moglie di Carlo III Durazzo, con le con quattro dame di corte e sette damigelle. Dopo la morte di Carlo, avvenuta nel 1386, la regina Margherita governò il regno in pieno accordo con il Papa. Sul cartello spiegato, tenuto dagli angeli, ci sono otto sigle A. M. M. G. L. N. C. A., che dicono: Ave Maria Madre delle Grazie Libera la Nostra Città di Atella. Fra le altre istruzioni impartite dal Re, il regolamento delle Commissioni di soccorso prevedeva: Che la distribuzione dei soccorsi fosse riservata a quelli che non avevano i mezzi per vivere: letti, vestiti, coperte, lenzuola, scarpe, pane, ecc. Che le persone valide fossero utilizzate per i lavori di ricostruzione; Che gli infermi e i mutilati fossero ricoverati negli ospedali; Che i ragazzi e le ragazze orfane fossero affidati ai parenti che desideravano prenderne cura. Che le baracche (circa 85 mq ciascuna), fossero destinate alle famiglie povere, rimaste prive di qualunque mezzo, e divise in quattro sezioni per ospitare quattro famiglie. Nei primi giorni di dicembre del 1851 furono completate e consegnate le prime 80 baracche costruite sul piano S. Marco a Melfi. Al 30 aprile 1852, la Commissione aveva speso 64.515,21 ducati. Su 68.881,19 ducati ricevuti ne restavano ancora in cassa 4.365,98. Poiché le somme raccolte, comprese quelle dei privati, ammontavano a 111.620 ducati, il Re decise di creare una Cassa di prestanze agrarie e commerciali «per rendere duraturo il beneficio procurato agli infelici dalla pubblica e dalla privata carità». La Cassa di Prestanze agrarie e commerciali Con un capitale iniziale di quarantamila ducati, il 15 aprile 1852 fu istituita a Melfi la Cassa di prestanze agrarie e commerciali a favore dei Comuni compresi nel Distretto medesimo. Trentamila ducati furono utilizzati per prestiti agrari ed armentizi e diecimila ducati per prestiti all’industria di arti e manifatture. Lart. 1 del Regolamento fissava i seguenti obiettivi della Cassa: 1. acquisto di semenze e per pagamento delle spese necessarie alle operazioni che servono al raccolto (grano ed altre derrate prodotte nei Comuni colpiti dal terremtoto); 2. acquisto di bestiame; 3. anticipazioni su i prodotti dell’agricoltura e della pastorizia dati in pegno; 4. acquisto di ordigni e di strumenti necessari all’esercizio di un’arte o manifattura; 5. acquisto di materie grezze da essere lavorate. L’articolo 4 destinava gli utili provenienti dalla “Cassa delle prestanze agrarie e commerciali” all’aumento del rispettivo fondo; l’art. 5 stabiliva il tasso di interesse sui prestiti al 5% l’anno. Nel discorso di inaugurazione tenuto dall’Intendente, tra le altre cose, egli disse: «Non più l’usura aduggerà (rattristerà) i sudori e lo stento del povero colono. Non lotterà più con la miseria l’onesto artigiano. A tutto provvedeva la sapienza dell’ottimo Principe. A tutto farà fronte la Cassa distrettuale di prestanze, rinnovatrice della fortuna di queste belle e fertili contrade. La sconquassò terribilmente il tremuoto. La suscita e conforta il braccio pietoso del magnanimo Pronipote di Carl III. Io già vedo il solerte colono, vedo l’onesto manifattore, distrigati dalle ambagi (tranelli) e dalle reti di ree speculazioni, trovare scampo e rifugio nel magnifico stabilimento della Cassa prestatrice, e rinfrancarsi de’ danni patiti, e porsi al rango di coloro, a’ quali amica sorride la fortuna. Io già contemplo il ricreante spettacolo di mille famiglie e mille, sfuggite agli artigli della miseria, sottratte all’ozio, ruggine e peste del civile consorzio, tripudianti in vivere agiato.» Il 4 maggio 1852, alla presenza di un’immensa popolazione, in mezzo a festive grida di Evviva il Re! furono sorteggiate a Melfi 130 quote demaniali disposte da Ferdinando II nella contrada Cavallerizza, Annunziata, Rucula e Vulture. L’11 luglio, alla presenza del Sottintendente, furono distribuiti e divisi a Venosa 2.666 tomoli di terre demaniali (circa 10.000 mq a famiglia) tra 704 famiglie povere, che ottennero così un sicuro mezzo di sussistenza. L’Istituto scolastico Agrario Tra le altre cose volute dal Re fu la creazione dell’Istituto scolastico Agrario distrettuale con annesso podere per le esercitazioni, inaugurato dal sottintendente Giuseppe Guerrieri il 30 maggio 1853, giorno dell’onomastico del Re. Potevano essere ammessi alla scuola i ragazzi vaccinati contro il vaiolo, che avevano non meno 12 anni e non più di 14. L’istituto scolastico fu insediato in una grandissima baracca di legno nella piana S. Marco. Le pareti erano formate da due strati di tavole isolate da carbone e paglia, internamente coperte con carta a disegni. Il tetto era coperto di catrame, embrici e tegole. Il pavimento era sollevato da terra, e uno strato di carbone lo separava dal suolo. Aveva moltissime stanze bene arredate. In particolare l’istituto aveva un dormitorio capace di ospitare 30 letti, ognuno col proprio mobile a cassatti, una sedia e un tavolino; un refettorio, le stanze per i professori, il portinaio e gli addetti alla cucina; la camera per il rettore, le aule per le lezioni, la cucina, la dispensa, un forno, camerini bagno, depositi per mobili, abiti, cereali e strumenti di lavoro; aveva altresì una biblioteca, un gabinetto astronomico e uno stanzone per il deposito delle piante. All’esterno aveva bellissime aiuole di fiori con piante locali ed esotiche, un frutteto e un allevamento di api, una stalla per le vacche svizzere, fatte venire appositamente per l’occasione, capre del Tibet e montoni merinos. Alla scuola furono annessi terreni e vigneti per le esercitazioni pratiche. Alcuni furono acquistati, altri furono donati dal Comune di Melfi e dalla Curia Vescovile. I vigneti furono migliorati e gli orti presentavano ogni sorte di ortaggi. La scuola era gestita dal canonico Giovanni Battista Areneo. Nel primo e secondo anno di scuola gli alunni imparavano a leggere e a scrivere, la grammatica italiana e l’aritmetica, che erano insegnate da un solo maestro. Studiavano la varietà delle specie di piante agricole e praticavano semplici lavori d’agricoltura. Nel terzo e quarto anno studiavano agricoltura e veterinaria, apprendevano i lavori da farsi per la cura del vigneto, la produzione del vino e dell’olio, l’allevamento dei bachi da seta, la cura degli animali, la cura delle arnie e la produzione del miele e si esercitavano nella tenuta dei conti e nella scrittura di lettere. Due volte l’anno gli alunni uscivano dalla scuola per studiare i metodi di coltivazione dei campi e le diverse qualità di terreni intorno a Melfi. Il rettore della scuola, un canonico che percepiva ducati 120 annui (circa 6.000 euro) insegnava anche il catechismo. La lingua italiana e l’aritmetica erano insegnati da un solo maestro, che percepiva 72 ducati l’anno. Un secondo maestro insegnava agricoltura teorica e pratica (con 120 D. l’anno). C’era poi il maestro aggiunto all’agricoltura (D. 108 annui), il veterinario, che teneva lezione due volte la settimana (con 12 D. annui), il medico scolastico, che periodicamente visitava i ragazzi (con 12 D. annui), l’infermiere (D. 24 annui), il cuoco (D. 30) e tre inservienti (D.18). La spesa annuale per la gestione della scuola era a carico della Cassa di prestanze agrarie e commerciali. I Comuni contribuivano per la retta dei ragazzi indigenti con 50 ducati l’anno mentre le famiglie agiate pagano 40 ducati l’anno, divisi in due rate. Finché ci fu il Sottointende Giuseppe Dentici la scuola progredì, ma nel 1860, ossia dopo l’unità, andò tutto in rovina, il podere si ridusse a un vero squallore, non buono neppure per il pascolo e le vacche denutrite furono macellate. «Bisogna però confessare che la colpa non deve addebitarsi tutta al Sottointendente, ma al governo di quei tempi nemico di ogni progresso sociale. Due anni dopo il terremoto molte baracche furono abbattute perché gli abitanti andarono a vivere nelle nuove case in muratura anche la scuola fu trasferita in una nuova sede. Il 10 luglio 1865 l’istituto fu trasformato in Scuola di Agronomia e Agrimensura con convitto annesso e il 20 luglio dello stesso anno la Cassa di prestanze agrarie e commerciali fu trasformata in Cassa di risparmio e di Anticipazioni7 punti
-
Buongiorno a tutti. In attesa del prossimo capitolo riporto in alto la discussione, prima che un argomento con oltre 6000 letture venga travolto da una infinità di discussioni con (forse) 30 letture.... Un saluto e a presto. 👋 ☺️5 punti
-
Carissimi amici, quest'oggi ho il piacere di mostrarvi l'ultimissimo acquisto della mia collezione. Si tratta, come da titolo, di un centesimo di Napoleone Re d'Italia coniato nel 1809 dalla zecca di Bologna. Direttamente proveniente dall'asta Ranieri ancora in corso, la moneta in questione è giudicata FDC e, personalmente, mi trovo pienamente d'accordo con il giudizio espresso dalla casa d'aste. Pur essendo una moneta coniata in milioni di esemplari, devo dire che negli ultimi anni non mi era mai capitato di vedere un esemplare di questo livello. È veramente uno spettacolo per gli occhi e mi auguro vivamente che possa piacere anche a voi.4 punti
-
Penso che sono vent'anni che nel Forum vige la legge della "cronologia" , fior di discussioni ,veramente importanti dal punto di vista scientifico che non stento a definire pietre miliari della letteratura numismatica,con attori che furono e sono monumenti dentro e fuori la Community, non hanno mai contravvenuto a tale "legge". Non posso che ribadire che nessuna discussione è al di sopra delle altre, financo discussioni che trattano di aristocratici o reali . Come ho già scritto : sento odore di " nobiltà per prossimità", non è che difendendo una casta ,per piaggeria o per convinzione , se ne diventa automaticamente parte.4 punti
-
@Adelchi66 Se noi stessi dessimo sempre il buon esempio… Ciao @Vincenzo30 e benvenuto nel forum Un pentanummio di Giustiniano I, si legge DN IV […] PP AVI. https://www.acsearch.info/search.html?id=5668908 Non dimenticare come già richiesto il peso o almeno il diametro.4 punti
-
Buonasera, Non so se sia la sezione giusta (nel caso abbia sbagliato mi scuso), ma volevo cogliere l'occasione per mandare un abbraccio e un pensiero agli amici toscani colpiti dalla tempesta. Forza ragazzi. Fabio4 punti
-
Buongiorno a tutti, vi aggiorno circa la conclusione della faccenda. La moneta è stata periziata, condizione SPL. La trattativa è stata chiusa a 5250,00 presso un compratore privato. ringrazio tutti per il Supporto, i consigli ed il tempo speso. a presto!4 punti
-
3 punti
-
Grazie a tutti dalla Toscana, fortunatamente per quanto mi riguarda sono in una zona che è stata toccata in maniera marginale dal problema, ho tanti amici che purtroppo hanno subito direttamente la tempesta ma che fortunatamente stanno bene.3 punti
-
Un ricco deposito di follis, monete di bronzo introdotte nel 294 d.C. con la riforma monetaria di Diocleziano nell'impero romano e poi utilizzate anche dai bizantini, risalente alla prima metà del IV secolo d.C., è stato scoperto nel mare della costa nord orientale della Sardegna, nel territorio di Arzachena. Ne dà notizia il Ministero della Cultura. Secondo una prima stima, fatta sulla base del peso complessivo del ritrovamento, il numero delle grandi monete di bronzo ritrovate si aggirerebbe tra i 30.000 e i 50.000 esemplari, più di quelle rinvenute nel 2013 nel Regno Unito, a Seaton, sito dal quale riemersero 22.888 follis. Oltre alle monete, sono state individuate nel deposito pareti di anfore di produzione africana e, in minor numero, di produzione orientale. A scoprire i reperti è stato un sub che, nel corso di un'immersione, ha notato dei resti metallici a poca profondità, non molto distante dalla costa. Il giorno dopo il Nucleo archeologico subacqueo della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Sassari e Nuoro insieme con i Carabinieri del Nucleo Tutela Patrimonio Culturale della Sardegna e del Nucleo Carabinieri Subacquei della Sardegna hanno eseguito una prima ricognizione nel tratto di mare interessato, con la collaborazione del Nucleo Sommozzatori dei Carabinieri di Cagliari e di quello dei Vigili del Fuoco di Sassari, insieme alla Polizia di Stato, alla Guardia di Finanza e alle Capitanerie di Porto. https://www.msn.com/it-it/viaggi/notizie/archeologia-scoperto-in-sardegna-enorme-deposito-di-monete-del-iv-secolo/ar-AA1jnIrh?ocid=msedgdhp&pc=EDGEDB&cvid=5c9deb9d551b4d028d8e33526397f0f2&ei=122 punti
-
Lingotto di metallo con iscrizioni romane trovato in un campo agricolo. Le ipotesi degli studiosi sul suo utilizzo e sulla “griffe” L’iscrizione incisa sul lingotto è particolarmente intrigante. Questa epigrafe sembra menzionare Marcus Trebellius Maximus, un importante personaggio romano che governò la Britannia per conto dell’imperatore Nerone tra il 63 e il 69 d.C. Questo collegamento suggerisce che il lingotto di piombo abbia una storia che risale a quasi 2.000 anni fa, rivelando dettagli straordinari sulla presenza romana in Britannia. Rossett, il luogo del ritrovamento è un villaggio, comunità e circoscrizione elettorale nel distretto della contea di Wrexham , nel Galles. Qui vivono circa 3000 perone. Il paese è soprattutto medievale, ma nel 2020, in un campo, sono stati trovati i resti di una villa romana. Il lingotto potrebbe essere legato alla costruzione di quell’edificio? Teniamo conto che le condutture, in quell’epoca, erano realizzate in piombo. Dopo il ritrovamento, l’oggetto singolare è stato acquisito da un museo della zona e attorno ad esso sono iniziati interessanti approfondimenti. Il marchio che reca il nome di Trebellius potrebbe essere giustificato dal tentativo di raggiungere un completo controllo, da parte dei romani, dell’attività mineraria. Con questo marchio avrebbero potuto solo circolare semilavorati provenienti da attività gestite o controllate dai romani stessi. La preziosa scritta sarebbe pertanto un documento di accompagnamento durante i trasporti e nel corso dei controlli daziari. E’ assai probabile che i romani si garantissero il monopolio dell’estrazione e che, forse per evitare furti di piombo già fuso o estrazioni non autorizzate, controllassero che la materia prima recasse il marchio di Stato. L’osservazione del reperto permette di ipotizzare che il lingotto sia stato parzialmente usato in loco perché, come possiamo vedere, pare evidente un taglio accurato di materiale dal “pane”, nella parte superiore sinistra del parallelepipedo, taglio che non sarebbe compatibile con un’azione violenta esercitata dall’aratro nel terreno agricolo in cui il lingotto è stato trovato. Il lingotto di piombo romano recentemente rinvenuto in Galles @ Ian Grant, Clwyd-Powys Archeological Trust La scoperta di Jones rappresenta una preziosa aggiunta alle prove dell’attività mineraria romana nella regione. Gli archeologi hanno identificato in precedenza meno di 100 lingotti di piombo dello stesso tipo in tutta la Britannia romana. Questi lingotti erano realizzati da galena, un minerale di piombo che spesso contiene argento. I romani valorizzavano entrambi i metalli, utilizzando il piombo per scopi ornamentali, quali scatole decorative, coppe da vino e altri oggetti domestici. Inoltre, lo utilizzavano in applicazioni architettoniche, come coperture di tetti, muratura, grondaie, condutture dell’acqua e cisterne. La scoperta del lingotto di piombo rappresenta un raro frammento di questa storia millenaria. Il primo controllo del lingotto, dopo l’estrazione @ Ian Grant, Clwyd-Powys Archeological Trust Susie White, l’ufficiale locale dei ritrovamenti (NE Wales), ha dichiarato: “È stato suggerito in passato che uno sfruttamento simile avesse avuto luogo nell’area di Wrexham intorno a Minera e in particolare a Ffrith, dove c’è un noto sito romano, anche se mancano prove chiare, probabilmente come risultato di un’attività mineraria più recente. Non sappiamo ancora da dove provenga questo lingotto e probabilmente non sapremo mai dove sarebbe andato a finire. Tuttavia, visti i ritrovamenti di altri lingotti provenienti dalla Gran Bretagna di data simile, potrebbe essere stato destinato all’Europa continentale, forse anche alla stessa Roma. L’oggetto potrebbe dirci molto su questo importante periodo del nostro passato, periodo ancora poco compreso in questa zona del Paese”. Il consigliere Hugh Jones, membro principale per le persone presso il comune di Wrexham, ha commentato: “Sono lieto di poter annunciare che il museo di Wrexham ha acquisito il lingotto e vorrei ringraziare l’Arts Council England/V&A Purchase Grant Fund, l’Headley Trust e gli Friends of Wrexham Museums per il loro sostegno all’acquisizione che altrimenti non sarebbe stata possibile. La sua acquisizione consentirà di esporre il lingotto nella città più vicina al luogo in cui è stato smarrito e ritrovato”. Chi era Marco Trebellio Massimo Nel complesso scenario politico dell’antica Roma durante il regno di Nerone, uno dei personaggi di spicco era Marco Trebellio Massimo, un influente senatore romano. Questo articolo esplorerà la vita e la carriera di Trebellio Massimo, evidenziando i ruoli chiave che ha ricoperto e le sfide affrontate durante il suo servizio. Marco Trebellio Massimo fu attivo durante il principato di Nerone, un periodo caratterizzato da eventi significativi nella storia romana. Nel 55 d.C., egli rivestì la carica di console sufetto, un importante incarico politico nell’antica Roma. Durante il suo mandato come console, Trebellio Massimo condivise la responsabilità con Seneca il Giovane, uno dei più noti filosofi stoici dell’epoca. Questo incarico era una testimonianza della sua influenza politica e del suo prestigio nella società romana. Nel 61 d.C., Trebellio fu coinvolto in un importante compito amministrativo. Egli faceva parte di una commissione incaricata di riesaminare l’elenco dei censimenti e le questioni fiscali nella provincia della Gallia. I suoi colleghi in questa commissione erano Quinto Volusio Saturnino e Tito Sesto Africano. Saturnino e Africano erano rivali, e la loro rivalità favoriva Trebellio Massimo, consentendogli di ottenere vantaggi politici durante il processo di revisione. Uno dei momenti cruciali della carriera di Trebellio Massimo fu la sua nomina a governatore della Gran Bretagna nel 63 d.C. Durante il suo mandato in Britannia, Trebellio continuò la politica di consolidamento territoriale intrapresa dal suo predecessore. Non avviò nuove campagne di conquista, ma si concentrò sulla romanizzazione della provincia. Uno dei suoi notevoli sforzi fu la rifondazione della città di Camulodunum (l’odierna Colchester) dopo che era stata distrutta durante la ribellione guidata da Boudica. Inoltre, Londra prosperò sotto il suo governo, sviluppandosi come un importante centro mercantile. Tuttavia, il mandato di Trebellio Massimo non fu privo di difficoltà. Nel 67 d.C., la situazione in Britannia divenne abbastanza stabile da permettere il ritiro della Legio XIV Gemina, ma questo portò all’ammutinamento tra le legioni rimaste. La mancanza di esperienza militare di Trebellio lo rese incapace di ristabilire la disciplina tra i soldati, e le tensioni con Marcus Roscius Coelius, comandante della Legio XX Valeria Victrix, ulteriormente indebolirono la sua autorità. Nel tumultuoso anno del 69 d.C., noto come l'”anno dei quattro imperatori,” la Gran Bretagna non propose un proprio candidato per succedere a Nerone. Invece, fu Marcus Roscius Coelius a guidare un ammutinamento che costrinse Trebellio Massimo a fuggire dalla provincia. Roscius appoggiò Vitellius, uno dei contendenti al trono imperiale, inviando unità della Legio XX a combattere per lui. Una volta che Vitellius salì al potere, nominò un nuovo governatore, Marco Vettius Bolanus, per la Gran Bretagna. Vitellius restituì anche la Legio XIV alla Britannia, nonostante questa legione avesse originariamente sostenuto l’altro contendente, Otone. Il caso di Marco Trebellio Massimo mette in luce la complessità e le sfide dell’antica politica romana, inclusi gli intrighi politici, le tensioni militari e le continue lotte per il potere. La sua carriera politica e le vicende in Britannia rappresentano un capitolo affascinante della storia dell’Impero Romano durante il periodo di Nerone e dei “quattro imperatori.” https://stilearte.it/lingotto-di-metallo-con-iscrizioni-romane-trovato-in-un-campo-agricolo-le-ipotesi-degli-studiosi-sul-suo-utilizzo-e-sulla-griffe/2 punti
-
È ufficiale: finalmente sabato prossimo verrà distribuito a Milano (all'Hotel De La Ville) il cartaceo del Gazzettino #10:2 punti
-
Ceramiche e frammenti di statua di 2500 anni fa nelle ritrovate stanze, tra terra e mare, che si affacciavano sul portico di una piazza Una missione archeologica anfibia si è svolta sul lato nord-occidentale della baia di Ampelaki, rivelando importanti scoperte relative alla città classica di Salamina. Nel corso degli ultimi anni, questa baia è stata oggetto di una sistematica esplorazione dei resti sommersi di Salamina, tra cui spicca un porticato che si affacciava su una piazza. La scoperta è stata annunciata nelle ore scorse dal Ministero della Cultura greco. Questo luogo è nei pressi del punto in cui avvennero gli scontri armati della battaglia di Salamina (480 a.C.). Salamina, Ambelaki. Veduta di parte di un edificio lungo e stretto (Stoà) durante lo scavo, da nord-ovest. @ copyright E. Kroustalis Il fulcro di questa recente esplorazione è stato un grande edificio pubblico, parzialmente sommerso, situato nell’angolo nord-ovest dell’attuale Ormos, un’area delimitata dalla diga marittima a sud ed est. Questa area era già stata oggetto di documentazione in anni precedenti, ma l’indagine ha portato a ulteriori scoperte significative. Lo scavo di questo edificio è stata condotta utilizzando una tecnica di scavo “anfibio”, che combina metodologie sia terrestri che subacquee. Per drenare l’area di scavo, è stata installata una diga e utilizzate due pompe idrauliche, consentendo così il completo esame di una superficie marina di 60 metri quadrati. L’edificio in questione, che ha una larghezza fissa di 6 metri e una lunghezza di 32 metri, mostra una notevole continuità architettonica nella sua porzione settentrionale lungo il litorale, mentre nella sua estremità meridionale presenta una proiezione quadrata. Dalle dimensioni, dalla forma e dalla disposizione degli spazi interni, così come da altri dettagli architettonici, è stato identificato come una stoà. La stoà, di origine greca antica e derivante dal verbo ἵστημι, che significa “collocare”, è una caratteristica struttura architettonica che consiste in passaggi coperti o portici destinati all’uso pubblico. Questi elementi sono situati all’interno di un edificio rettangolare allungato, caratterizzato da un lato lungo aperto e affiancato da colonne. Questa parte solitamente si affaccia su una piazza o una strada, mentre l’altro lato è chiuso da un muro. La copertura può variare da spioventi a terrazze, e l’edificio stesso può avere una parte superiore che ripete il modello del piano inferiore. Salamina, Ambelaki. Parte superiore (titolo) di colonna a risoluzione marmorea del IV sec. a. C, con sezione a rilievo. copyright Χρ. Μαραμπέα All’interno di questo edificio, sono stati individuati almeno 6-7 ambienti, con particolare attenzione ad uno di essi, che misura 4,7 x 4,7 metri e presenta un ampio pozzo di deposito situato nell’angolo nord-ovest. Le sue solide mura, spesse circa 0,60 metri, sono composte da grandi blocchi di pietra squadrata, dei quali oggi rimangono solo uno o due strati di pietre. Tuttavia, lungo il lato occidentale e le murature trasversali si appoggiano su una fondazione ben costruita. I resti archeologici in questa zona sono stati in gran parte spogliati del loro materiale da costruzione, poiché questa zona è stata utilizzata per il recupero di materiale edilizio fino alla fine del XIX secolo. L’indagine della stoà ha portato alla luce un tesoro di reperti mobili, tra cui una vasta quantità di ceramica di varie epoche. Questa ceramica include frammenti di vasi di vario tipo e ceramiche risalenti all’epoca classica-ellenistica. Di particolare importanza sono i vasi colorati e conchiglie ateniesi risalenti al periodo tardo classico (IV secolo a.C.). Salamina, Ampelaki. Ceramica ateniese del IV sec. copyright Χρ. Μαραμπέα Tra i reperti marmorei, due meritano particolare attenzione. Uno di essi è un frammento di colonna con una parte di iscrizione, mentre l’altro è la parte superiore di un’altra stele con una rappresentazione in rilievo che sembra raffigurare un eroe incoronante un uomo barbuto. Questi ritrovamenti sono datati al IV secolo a.C. e si collegano direttamente a una rappresentazione simile su una stele nel Museo Archeologico di Salamina, con l’eroe come figura principale nella celebre festa adolescenziale di Aianteia. L’identificazione della stoà è di notevole importanza per lo studio della topografia e dell’organizzazione abitativa dell’antica città di Salamina. Si ritiene che questa struttura costituisse il confine orientale dell’area dell’Agorà della città durante l’epoca classico-ellenistica, invece che essere direttamente associata al porto. La sua esistenza era stata menzionata dal viaggiatore Pausania nel II secolo d.C., e l’area in cui è stata scoperta era stata già proposta come ubicazione dell’Agorà da W. Kendrick Pritchett nel 1959, basandosi su osservazioni precedenti di A. Milchhöfer e altri ricercatori. Le ricerche sottomarine sulla sponda orientale di Salamina si sono svolte in collaborazione con l’Istituto di Ricerche Archeologiche Marine (I. EN.A.E.) e l’Eforato delle Antichità Marine (E.E.A.) del Ministero delle Antichità Marine, sotto la direzione di Angeliki G. Simosi, Responsabile dell’E.F.A. del Pireo e delle Isole, e di Giannos G. Lolos, Professore Emerito di Archeologia Preistorica presso l’Università di Ioannina e membro del Consiglio di Amministrazione. dell’I.EN.A.E., con la Dott.ssa Christina Marabea come principale collaboratrice, come responsabile del campo e della documentazione, e con la partecipazione di archeologi, altri esperti e tecnici. Si tratta della prima ricerca subacquea interdisciplinare, condotta in modo intensivo (dal 2016) da agenzie greche, nelle aree dello storico Stretto, nell’area marina di Ampelaki-Kynosoura. https://stilearte.it/ceramiche-e-frammenti-di-statua-di-2500-anni-fa-nelle-ritrovate-stanze-tra-terra-e-mare-che-si-affacciavano-sul-portico-di-una-piazza/ E per il momento mi fermo!2 punti
-
2 punti
-
Ho provato a dare una occhiata al RIC che inserisce questa moneta nella "undated", comprese nel periodo 231-235. La parte testuale non aiuta, non parlando espressamente di questo rovescio. Tuttavia, come e' stato detto sopra (e come e' anche scritto nel RIC) questo periodo fu caratterizzato dalla fine di un lungo periodo di pace a causa sia della guerra in Oriente contro i Sasanidi, sia di incursioni di popoli germanici ad Occidente lungo il limes reno-danubiano che poi porteranno alla caduta di Alessandro Severo a favore di Massimino il Trace. Qui, forse, SPES PVBLICA si può tradurre in "speranza del popolo", nel senso che l'imperatore rappresenta la speranza dei suoi sudditi in una vittoria contro i nemici che incombevano con il conseguente ristabilimento della pace? Ma vorrei tornare a questa moneta. Mi colpisce proprio l'effigie della Spes che, oltre a tenere un fiore nella mano destra, solleva con la mano sinistra un lembo del chitone, mentre leggiadra, in punta di piedi, avanza verso sinistra (la trasparenza della veste fa cogliere bene l'eleganza del movimento). Una figura davvero graziosa ed affascinante. Particolare, quindi, che la moneta @NeroDrusus ti sia stata regalata proprio dalla tua signora che ha mostrato davvero buon gusto. Ciao. Stilicho2 punti
-
Aggiungo per completezza anche la foto della casa d’aste, certamente più dettagliata e “veritiera” della mia.2 punti
-
Ciao a tutti! Prendo spunto dal bellissimo centesimo di @lorluke dell'altra discussione per finalmente postare il mio espositore (era già tutto pronto da un po', ma avevo altre "guerre" per la testa). Espositore? Si appunto, casa mia è decorata in modo strano, tra un Buddha in bronzo ed una scheggia di ossidiana di Vulcano, sul davanzale c'è pure questo: a sinistra tre monetine e due pallini: la più bella è questa, purtroppo un po' piccina così ho preso pure questa messe tra due palle di ferro: una da moschetto ed una di mitraglia (1,6 cm / 15,58 g - 2,2 cm / 39,62 g) @palpi62 e @sandokan la foto l'avevano già vista. Moschetto è chiaro... BUM! La mitraglia? Già meno conosciuta: una specie di "cartuccione a pallettoni" che veniva ancora usato all'epoca napoelonica. La moneta più grande mi sembra logico affiancarla alla palla più grande questa si che fa un "grande badaboom" come dice Leeloo! Palla da cannone (una granata da 6,2kg - 12,3cm), del 1813, Battaglia di Wartenburg / Elster, Germania orientale. cava all'interno per far posto al granulato esplosivo che in parte ho messo in un sacchetto, in parte in una provetta (sull'espositore in secondo piano) la palla da cannone è ben conservata in quanto ritrovata insieme ad altre in un casolare e non nel sottosuolo. La miccia l'ho fatta io con un cordino, il tappo? Sembra originale, ma esattamente non lo so. Buon pacifico proseguimento a tutti! Njk ================== Per saperne di più: https://it.wikipedia.org/wiki/Battaglia_di_Wartenburg https://es.wikipedia.org/wiki/Bote_de_metralla1 punto
-
Aggiungo che probabilmente la maggioranza di quelle 25300 visualizzazioni sono avvenute per puro e semplice voyeurismo, per il gusto di assistere al probabile degenerare in rissa della discussione ,quindi non credo che sia il caso di ammantare di un fantomatico "alto livello culturale" una discussione che è un grado più su di una puntata del Grande Fratello.1 punto
-
Carissim*, anche se il periodo è denso di appuntamenti volevo segnalarvi che i prossimi sabato 4 e domenica 5 novembre sarà possibile accedere gratuitamente al Museo Nazionale di San Matteo e vedere la nuova esposizione di monete medievali, tessere mercantili e gettoni dal monetiere del Museo Nazionale di San Matteo, curata da Monica Baldassarri, in collaborazione con il Direttore del museo Pierluigi Nieri e Gianpaolo Palma del CNR ISTI di Pisa. La nuova esposizione segna la fine della prima tappa di un percorso che ha visto il restauro, la verifica inventariale e - laddove necessario - la classificazione o ri-classificazione e la realizzazione di foto digitali in HD di circa 1000 esemplari tra monete, tessere mercantili, gettoni e placchette, messi in atto dai chi già nominato sopra con la collaborazione di Francesco Pagliani (giovane archeologo e numismatico), Chiara Valcepina e Mauro Stallone (restauratori), Luca Lupi (fotografo). A partire dalle ore 16,00 di sabato 4 novembre e ancora dalle 11,00 di domenica 5 novmbre è prevista anche la visita guidata da parte dei curatori. Per chi di voi avesse la possibilità di venire, è una bella occasione di vedere una importante selezione del tesoro delle Logge dei Banchi e alcuni tra gli esemplari più belli e rappresentativi delle zecche di Pisa, Lucca, Siena, Arezzo e Massa di Maremma conservati al museo (ma sono esposti anche pezzi interessanti di Berignone e Firenze...), oltre ad una prima scelta di tessere mercantili e gettoni (che saranno frutto di ulteriori e più ampie esposizioni). Sperando di vedervi in questa o in prossime occasioni (presto inaugureremo anche una nuova mostra temporanea a Palazzo Blu!) MB1 punto
-
Non dimentichiamo che sabato prossimo sarà l'occasione di ritirare il cartaceo del Gazzettino #10, un numero ancor più ricco di articoli dei precedenti:1 punto
-
Mi ero riproposto di non intervenire più in questa discussione ... primo perché non essendo esperto del periodo e dell' argomento non avrei avuto voce in capitolo e secondo perché la reputavo ( e la reputo ancora) costruttiva avendo le varie "voci" pari dignità e diritto di esporre le proprie tesi esponendo fatti e prove Ma trovo il post che cito decisamente puerile e sminuente nei confronti di chi legge. Palesare un post che nulla aggiunge ai fini del discorso solo per essere in cima alla lista della discussioni è veramente infantile ,come se chi fosse interessato ad essa non sapesse andarsela a cercare di sua sponte. Il tutto con un mal celato senso di supponenza nei confronti di altri argomenti evidentemente ritenuti inferiori solamente in base alle visualizzazioni... Peccato.. soprattutto da parte di chi ,nella stragrande maggioranza delle occasioni ha dimostrato equilibrio e capacità retorica nella migliore accezione del termine.1 punto
-
In Costa Smeralda, da un sub: https://www.agi.it/cultura/news/2023-11-04/archeologia-deposito-monete-secolo-scoperto-mare-sardegna-23812519/1 punto
-
Ad oggi sono state rese note 11 monete: https://numistoria.altervista.org/blog/?p=289871 punto
-
Sono più di cento le zecche riportate dal Price e molte di esse hanno coniato monete stilisticamente pregiate, tra cui quella molto produttiva di Babilonia. La mia preferenza va al tetradramma di Tarso del periodo c. 323-317 a. C. (Price 3042) che mi sono aggiudicato alla Tkalec di Zurigo nell'ottobre 2007. L’immagine è stata scelta da Martin Joseph Price come illustrazione della copertina dei due volumi del suo libro più famoso ‘The Coinage in the Name of Alexander the Great and Philip Arrhidaeus’. apollonia1 punto
-
1 punto
-
Buonasera, somiglia molto a questa. https://numismatica-italiana.lamoneta.it/moneta/W-GE32/111 punto
-
Ciao! Conforme alla tipologia bruttina di questo zecchino, ormai coniato ormai in modo approssimativo ed evanescente. Domenico, l'altro giorno ti ho inviato un MP che risulta non ancora letto! Grazie e saluti luciano1 punto
-
1 punto
-
Più tasse per tutti! Cito dal comunicato di Milano Finanza: _______ La legge di Bilancio approdata recentemente in Parlamento imprime una stretta sulla plusvalenze da cessione di metalli preziosi, se grezzi, e in forma di monete (di borsa). Oggi, in mancanza di documenti che attestino il costo di acquisto, gli eventuali guadagni sono calcolati prendendo in considerazione il 25% del prezzo di vendita dell'oro o dell'argento. Il disegno di legge di bilancio cambia le regole del gioco. La tassazione, con aliquota al 26%, sarà sull'intero corrispettivo. In questo modo le stime del governo contano di portare in cassa circa 196 milioni l'anno. Nel 2022 le vendite superarono i 3 miliardi di euro. La stessa relazione tecnica che accompagna il documento non nasconde che la maggior parte dei preziosi arriva spesso nella forma di regalo in eventi o feste. Perciò è difficile risalire al costo d'acquisto. Su queste basi l'imponibile stimato è di poco più di 754 milioni. Con le nuove regole, incluse nel pacchetto anti-evasione, si salirebbe a 1, 5 miliardi. _________ Ricordo che c'è sempre la ben nota ambiguità nella suddivisione tra monete d'oro da investimento e monete d'oro da collezione, almeno per le monete più comuni che hanno un valore prossimo a quello dell'oro fino contenuto. Mi riferisco, ad esempio, a tanti marenghi del Regno d'Italia che sono comuni o comunissimi perché coniati in milioni di pezzi. Distinguere tra monete per investimento e monete da collezione non è affatto semplice. Una tassa del 6,5% sul venduto (come era prima) poteva essere accettabile, ma dall'anno prossimo in poi - a meno di non avere tutte le ricevute d'acquisto - si rischia di pagare il 26%. Chissà se su un pilone del futuro ponte sullo Stretto di Messina qualcuno metterà una targa con la scritta: "costruito con le tasse pagate da chi ha venduto le monete d'oro che gli aveva regalato il nonno".1 punto
-
Grazie per la risposta. Nozioni molto interessanti in quanto a me finora del tutto sconosciute.1 punto
-
anzitutto va stabilito se l'oro/moneta è da investimento o meno, per le vendite derivanti da asta sinceramente non so come funzioni per le monete considerate "non da investimento", ho qualche dubbio che subiscano una tassazione se non derivano da attività di commerciante abituale https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2000-01-17;7!vig= https://www.lamoneta.it/topic/91394-aste-numismatiche-e-tasse/ quindi gli aspetti per incanalare una moneta d'oro in ambito da investimento, piuttosto che da collezione sono principalmente e monete d'oro di purezza pari o superiore a 900 millesimi, coniate dopo il 1800, che hanno o hanno avuto corso legale nel Paese di origine, normalmente vendute a un prezzo che non supera dell'80 per cento il valore sul mercato libero dell'oro in esse contenuto1 punto
-
Buonasera a tutti gli amici del forum. Quest'oggi ho il piacere di mostrarvi l'ultimo, piccolo acquisto della mia collezione. Il titolo è volutamente giocoso, dato che si tratta di un demi franc del 1813 zecca di Parigi. Il caso vuole che l'anno di emissione sia lo stesso della mezza lira di Gioacchino acquistata lo scorso dicembre. Ecco, dunque, che ho pensato di riproporvele assieme. Le foto non sono il massimo a causa della plastica dello slab ma, al momento, ho un po' paura a liberare la moneta, data l'esilità del piccolo tondello. Ad ogni modo, non vi dirò il punteggio attribuito da PCGS. Lascerò che siate voi amanti delle scatolette ad indovinarlo Bando alle ciance, buona visione! Ed ecco anche la mezza lira di Murat. Personalmente, tra le due, preferisco questa (non me ne voglia Napoleone).1 punto
-
Ciao abbastanza conciata. MB/BB a esser buoni a mio parere. Ha subito anche una aggressiva lucidatura. Valore commerciale assai modesto, soprattutto di questi tempi. Comunque autentica.1 punto
-
Commento al precedente tetradramma P205 var. tradotto in italiano Non notata da nessun catalogatore prima di quello che lavorava su CNG E-463 (marzo 2020, lotto 33), la piccola lettera T che si trova sopra la testa di Helios e all'interno della sua corona radiata si trova su alcuni esemplari del tipo (Price P205) apparsi sul mercato a partire dagli anni Novanta. È interessante notare che esiste un'emissione complementare battuta per Alessandro III in cui la piccola T è stata incisa sotto la testa di Elio (Price 3698). Tetradramma di Alessandro Magno con la T sotto la testa di Helios, Price 3698 (Münzen & Medaillen, Auction 9). GRIECHISCHE MüNZEN KöNIGE VON MAKEDONIEN No.: 137 Schätzpreis - Estimation DM 800,- Tetradrachmon, "Babylon", postum, 323-317. Wie vorher, im Felde l. Büste des Helios von vorn, darunter T, unter dem Thron KY 17,13 g. Price 3698. Breiter Schrötling. Feiner Stil. Vorzüglich apollonia1 punto
-
Ciao a tutti, quel "qualcuno" di sopra ero io 😁 Ciao @Asclepia: anche tu non ti fidi? Ormai è passato già qualche anno: e soprattutto (in quanto senza dubbio un esperto) sottolineo che io uso solo acetone puro, si trova in ferramenta o al brico, e poi qui si tratta (forse) di monete d'oro, sconsiglierei di sicuro solo l' acqua regia 🤣 e poi NON strofinare, come già detto. Servus, Njk1 punto
-
La seconda, portativa con foro di sospensione, molto bella e inusuale per una devozionale. Le righe chaire sono residui di doratura al mercurio, che fanno pensare ad essere molto antica, altezza 4 cm.1 punto
-
È volata via 👼 Spl....A testimonianza che giudicar da foto amatoriali è un macello. Non credo che avremmo dato in molti lo spl. Chi l' ha avuta davanti avrà visto e saputo ciò che fare😊1 punto
-
Ciao @Stilicho con i tuoi bellissimi versi sei riuscito a farmi vedere la scena nella mente riguardando la SPES (piena di grazie ed eleganza), sono contento che ti è piaciuta,ho appena fatto leggere questo tuo intervento a mia moglie e si è un po' emozionata,contenta di aver fatto questo acquisto piu che mai! Grazie inoltre per le info GRAZIE1 punto
-
1 punto
-
Hai scritto prima che “sei cosciente che sono state trafugate illecitamente in Turchia”…. Quindi sai benissimo che acquisti un bene rubato ( a tuo dire) Che sia in asta o no e che abbia o no un prezzo congruo cambia poco: stai ricettando un provento di attività illecita pur sapendo che lo è ….quindi stai compiendo un reato già solo perché sai ( come dici tu) che sono rubate .1 punto
-
Non è che ci sia un obbligo di legge di collezionare Euro... personalmente me ne sono sempre ben guardato1 punto
-
Non so che dirti , quando nelle monete , e non sono poche , mancano i dati o gli attributi : TRP , COS , PP , numero degli IMP , oppure particolari dei rovesci che possono essere databili , e' difficile e ipotetico dare delle date alle emissioni mancanti dei dati sopra esposti . Nel caso della SPES si potrebbe datare in un anno qualsiasi del suo impero , anche all' inizio , come augurio di un impero carico di buone speranze . Non vedo pero' un legame con la salute di Alessandro in quanto in questo caso esiste la simbologia della SALUS .1 punto
-
Caro Massimo, scusa se il mio precedente commento lo ho a te indirizzato, ho fatto un po' di confusione (come spesso mi succede quando uso l' informatica). Una risposta al tuo intervento comunque la volevo inviare (lo sai che ti stimo): la storia, intesa come ricostruzione ordinata di eventi umani ha una stretta relazione con la politica e quindi anche la numismatica è (di conseguenza) fortemente condizionata dalla politica stessa. Altra cosa (questo è il mio pensiero) sono i dibattiti ,le discussioni partitiche, la conflittualità' ideologica . Ma penso che queste non siano le motivazioni che hanno dato inizio alla discussione su Vittorio Emanuele III. Ma mi domando, è ancora possibile che a distanza di un secolo non si riesca a parlarne, discutere serenamente, a far conoscere il nostro comune passato? Certo, se penso che in tempi piu' recenti si cerco' di proibire ad uno scrittore e giornalista antifascista come Pansa di squarciare il velo sulle verita' negate ai "vinti" non posso dichiararmi ottimista, ma si deve parlarne perchè la democrazia è un bene assoluto e noi cittadini democratici dobbiamo esserne gelosi custodi. Gli insulsi scambi conflittuali e la deriva politica non interessano a nessuno (o quasi), concordo con te nel rifiutarli. Ricambio di cuore i saluti numismatici, ciao SANTI1 punto
-
Questo per me è sempre Giovanni Marmora, in linea con quanto ipotizzato nel mio studio sui soldini.1 punto
-
1 punto
-
Concludo con una ribattitura su didracma di Siracusa, 8,09 g. Davvero spettacolare.. Ma, come dicevo, diversi altri esemplari presenti nel medagliere della Biblioteca Nazionale di Francia sono evidentemente ribattuti su monete di Sicilia e di altre zecche greche. Personalmente resto a bocca aperta ogni volta che mi perdo in questo file del mio archivio, in viaggio con l’immaginazione su di un ponte che unisce epoche, poleis, culture, economie e culti differenti. Che fonte incredibile di informazioni può essere una moneta ribattuta!1 punto
-
L’esemplare di Crotone dall’asta Leu proviene dagli stessi coni dell’es. CNG, 190, 2008, 9 che a sua volta sembrerebbe presentare tracce di riconiazione. Lo statere appare riconducibile alla prima serie ad incuso stretto (A) prospettata dal Garraffo, caratterizzata dal tripode con anse circolari rese di prospetto sia al D/ che al R/ (ca. 480/75-465/60). Tale serie viene ulteriormente suddivisa dallo studioso in due sezioni (A1, 2) per la resa delle anse del tripode al D/, di eguali dimensioni (A1) o con ansa centrale di dimensioni maggiori rispetto a quelle laterali (A2). Leu, 16, 2021, 205 CNG, 190, 2008, 9 La riconiazione su Agrigento non è improbabile, specie se si confrontano le tracce rimaste tra i sostegni del tripode con quelle di uno statere proveniente da coni molto simili e chiaramente ribattuto su moneta agrigentina. CNG, 72, 2006, 1481 punto
-
A seguire le coppie nn. 100-101 riconiate su sottotipi incerti. Una di esse (n. 101) reca al R/ tracce di un quadrato incuso (Corinto?) (Naville Numismatics 32, 2017, 22: foto 5) 5 Tali riconiazioni, oltre a rimarcare quella importante presenza di valuta siceliota che nella polis si riscontra sin dalla prima adozione della tecnica a doppio rilievo (gruppo E), offrono alcuni importanti elementi che consentono di definire con maggiore puntualità la cronologia del gruppo F. Kraay, ipotizzando una cesura di circa un decennio tra le coniazioni dei gruppi E ed F, datò inizialmente il gruppo al 455-440 in base alla riconiazione sul citato statere di Sibari sul Traente per poi rialzarne gli estremi al 460-450 a seguito dell’esame dei materiali presenti nel ripostiglio di S. Giovanni Ionico 1971 (CH IX, 599). Tuttavia la riconiazione su Leontini, in particolare, fornendo un terminus post quem al 475/70-460 per il segmento iniziale del gruppo F (sesta coppia di conî, n. 83) sembrerebbe in realtà svalutare l’ipotesi dell’inattività della zecca prospettata dal Kraay, sulla quale peraltro Garraffo e studi successivi hanno avanzato forti perplessità. Se pertanto è corretta la cronologia di Boehringer, si ricaverebbe un ambito temporale intorno alla seconda metà degli anni Sessanta come limite entro cui inquadrare lo stadio iniziale delle coniazioni del gruppo F. Un orizzonte cronologico similare che sembra suggerito anche dalla riconiazione effettuata sul didrammo di Agrigento del gruppo IV (ca. 480/78-470), considerata la sua collocazione in una fase non iniziale della sequenza ricostruita dalla Westermark e il numero non elevato dei conî di D/ utilizzati (12). Tenuto poi conto della riconiazione su Sibari sul Traente, del volume di emissione del gruppo F (25 coppie di conî tratte da 18 conî di D/ e 21 di R/) e del carattere non particolarmente intensivo della coniazione, di cui sono ricostruibili solo brevi tronconi di catena, non si possono escludere margini temporali più ampi rispetto a quelli prospettati da Kraay. In particolare il limite inferiore del gruppo F potrebbe slittare di almeno un quinquennio, ponendosi intorno al 445 circa. Un dato che potrebbe trovare riscontro nell’associazione del più tardo statere cauloniate (F, n. 92) con la moneta più recente di Taranto (gruppo 14 Fischer-Bossert: 445-440) nel ripostiglio di Taranto 1951 (IGCH 1895) e considerato che per l’inizio del successivo gruppo G Noe un elemento di ancoraggio potrebbe essere fornito dalla riconiazione – se accertata – su uno statere di Corinto inquadrabile nel momento finale della seconda classe del III periodo Ravel (ca. 450-440: Garraffo 1984, 96, n. 22a). Gruppo Noe n. coppia di coni Undertypes Bibliografia F 83 Leontini CNG, Web shop 83 Agrigento GARRAFFO 2002, 353 83 Cuma? GARRAFFO 1984, 96, 14 83 incerto CNG 67, 2004, 178 98 Agrigento CNG 118, 2021, 33 ex CNG, 72, 2006, 137 98 Sibari sul Traente GARRAFFO 1984, 96, 15 98 incerto Nomos 18, 2018, 23 ex Roma Numismatics 7, 2014, 49 100 incerto GARRAFFO 1984, 96, 16 101 incerto (Corinto?) Naville Numismatics 32, 2017, 221 punto
-
Innanzitutto desidero ringraziare @Archestrato per aver chiesto la mia opinione su una tematica complessa ma nel contempo ricca di stimoli quale appunto quella delle riconiazioni in Magna Grecia. È interessante che gli esemplari cauloniati postati appaiano entrambi inquadrabili nella seconda emissione a doppio rilievo (gruppo F Noe), in quanto proprio in questo momento di produzione si rileva un discreto numero di esemplari riconiati che nel corso degli anni, anche grazie alla documentazione fornita dal mercato antiquario, si è notevolmente accresciuto, arricchendo il numero dei casi già noti studiati da Garraffo nella monografia del 1984 e nel successivo aggiornamento del 2002. Complessivamente il gruppo F sembrerebbe interessato da almeno nove casi di riconiazione, di cui quattro noti a Grarraffo e che pertanto non illustro nelle tavole. Possiamo partire dalla coppia di coni Noe, n. 83, che annovera ben quattro casi di ribattitura. La prima (foto 1), segnalata opportunamente in un catalogo di vendita (CNG, Web Shop: https://www.acsearch.info/search.html?id=36617), risulta effettuata su un didramma di Leontini del tipo Boehringer, 13 inquadrabile nella fase più antica della monetazione, il cui avvio viene fissato dallo studioso nella seconda metà degli anni Settanta del V secolo (Boehringer 1998, 43). 1 (da https://www.acsearch.info/search.html?id=36617) Le successive reimpressioni utilizzano come undertypes un didrammo di Agrigento del gruppo IV Westermark (ca. 480/78-470) e - con qualche incertezza - uno di Cuma (GARRAFFO 1984, 96, 14 e ID. 2002, 353) e una moneta incerta (CNG 67, 2004, 178: foto 2). 2 Proprio Agrigento, insieme a Corinto, risulta alquanto attiva nella fornitura di metallo da coniare, come documenta il caso di riconiazione (CNG 118, 2021, 33 ex CNG 72, 2006, 137: foto 3) dello statere Noe, n. 98 citato da Archestrato su un esemplare akragantino del tipo Westermark III, 203 (488/485-480/478). 3 Alla stessa combinazione di coni (Noe 98) vanno inoltre ascritte due ulteriori casi di ribattitura: il primo, già noto a Garraffo, effettuato su una moneta attribuita a Sibari sul Traente, il secondo (Nomos 18, 2018, 23 ex Roma Numismatics 7, 2014, 49: foto 4) non appare di facile identificazione come giustamente rileva Archestrato e le tracce rimaste sono alquanto labili. Al R/, a sinistra della cerva e tra le zampe si notano dei segni che potrebbero associarsi, tuttavia con ampi margini di incertezza, ad un piumaggio (aquila agrigentina?) o ad una criniera leonina (Leontini?) ma potrebbe trattarsi semplicemente di un’illusione ottica. 41 punto
-
No, questi titoli sono prescritti, e non è più possibile ottenerne il rimborso. Ma se anche non fossero prescritti, tale rimborso sarebbe limitato al capitale versato (100 lire) e agli interessi previsti nel titolo stesso, 5 lire l'anno...dal 1937 al 2019 fanno 410 lire Questo per sgombrare il campo dalle bufale, che spesso si leggono in internet, a proposito di ipotetiche rivalutazioni milionarie di simili titoli, e del fatto che lo Stato sarebbe tenuto a rimborsarli praticamente in eterno, anche dopo secoli. Così come per le monete e le banconote, il valore è dato in buona parte dalla conservazione, e quella del titolo in foto non è certo al massimo. Se a questo aggiungiamo che si tratta di un titolo comune, il valore è di pochi euro, da 5 a 10, ma direi più 5 che 10. E' un titolo del Secondo Prestito Nazionale per la conquista dell'Etiopia, emesso in base al Regio Decreto Legge 5 ottobre 1936-XIV n. 1743. Fu emesso per valorizzare i territori dell'Africa Orientale Italiana, e per procurare all'Erario i mezzi necessari a garantire la sicurezza nazionale. Si tratta di un prestito redimibile, che fruttava un interessa annuo del 5% e di cui, alla scadenza, veniva rimborsato il capitale inizialmente versato. Anche se non ha un particolare valore economico, resta comunque un interessante documento storico, da conservare con cura. petronius1 punto
Questa classifica è impostata su Roma/GMT+01:00
Lamoneta.it
La più grande comunità online di numismatica e monete. Studiosi, collezionisti e semplici appassionati si scambiano informazioni e consigli sul fantastico mondo della numismatica.
Il network
Hai bisogno di aiuto?








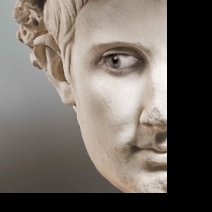







.thumb.jpg.1d3b56d02cc983aaeb9f4d6ee8eebe9a.jpg)