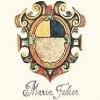Classifica
Contenuti più popolari
Elenco dei contenuti che hanno ricevuto i maggiori apprezzamenti il 11/07/23 in tutte le aree
-
Allora, questo è un Forum democratico, dove a Dio piacendo chiunque può esprimere le proprie opinioni purché rimanga nei binari dell’educazione, del rispetto delle idee del prossimo, della cortesia e, auspicabilmente, del contributo alla comune passione che unisce noi collezionisti, noi studiosi, noi semplici appassionati. Personalmente leggendo questo post, passata la sorpresa, mi ha divertito, nel senso migliore del termine, solo e soltanto la veemenza quasi ingenua, e in parte simpatica nella forma, ma nella sostanza farcita di livore, che l’autore ha espresso nei confronti dei commercianti italiani. Ma la mia facoltà di comprensione onestamente finisce qui, e si limita appunto alla curiosità e a una discreta dose di perplessità. Qual è stato l’obiettivo di questo intervento a valanga da parte di un nuovo utente? La diffidenza, almeno per quanto mi riguarda, è d’obbligo in questo caso. Caro nuovo utente, te lo ha scritto bene Marco, l’amico @gallo83. A mio modesto parere non si può fare di tutta l’erba un fascio, in Italia ti garantisco ci sono fior di commercianti assolutamente corretti (e io se fossi uno di loro un pochino magari mi offenderei pure) così come ci sono improvvisati imbonitori privi di scrupoli. E credimi, sono la minoranza, perché è il mercato stesso che, prima o poi, si incarica di emarginarli. Scrivo questo perché colleziono da 60 anni, e scusa se sono pochi. Ma questo fenomeno anzitutto è presente in tutti i settori del commercio, e poi in tutto il mondo. I prezzi in Italia non ti aggradano? Basta non comprare e rivolgersi altrove, dove sta il problema? Ciò posto, dove si voleva andare a parare con questa esternazione? A ottenere delle improbabili autocritiche e conseguenti compunte autocrocifissioni di presunti venditori italiani esosi, con relativa cenere sul capo? 🤣 Ma in che film? 😂. Se un venditore è una persona seria e corretta tutt’al più può sorridere come ho fatto io, se non lo è come in una famosa battuta di un grande film del passato…francamente se ne infischia. A volte il qualunquismo veramente non ha limiti…mah 🤷🏽♂️5 punti
-
I talleri coniati a Firenze per Pisa nel 1608 sono estremamente rari. Hanno la caratteristica di avere quasi tutti una parte della data mancante. Con certezza ne ho potuti catalogare 4 più uno senza foto pubblicato da Galeotti, Le monete del granducato di toscana. L'esemplare pubblicato da Galeotti porta nella legenda al rovescio la versione MEMORIAM. L'altro 1608 con questa legenda è il mio. Non dovrebbe trattarsi dello stesso esemplare perché altri particolari della legenda sono leggermente diversi (MAG:ETR invece di MAG⋮ETR), per quanto non si possano escludere errori da parte di Galeotti. In generale metto in catalogo solamente esemplari con foto che permettono di riconoscere gli esemplari. Quindi 5 esemplari (diciamo sicuri), di cui 3 con legenda del rovescio in MEMORIAM e 2 (tra cui quello del Galeotti) con legenda in MEMORIA. Questo è l'esemplare della mia collezione, il mio pezzo preferito, a mio modesto parere quasi fior di conio. (legenda in MEMORIA) si noti il bordo tagliente4 punti
-
Buona sera @giuseppe ballauri...per me il taglio è a treccia in rilievo, se fosse a serpentina, il disegno del taglio sarebbe più obliquo! Grazie per il dettaglio dell'asse a te e a @motoreavapore....attendo i dati da Alberto...non c'è fretta e poi sono il primo a rispondere quando posso. @Rocco68... Ciao Rocco....no!! Mi manca anche la combo caratteri piccoli al dritto e grandi al rovescio (di cui si parlava dal post 192 a scendere) sia la tua variante con caratteri piccoli sia al dritto che al rovescio, con un rombo dopo GRANA e un rombo dopo la data. E come ho scritto subito mi manca anche la tua variante, che è diversa ancora!...anche nella tua caratteri piccoli al dritto e al rovescio, ma rombo solo dopo GRANA e non dopo la data, e non è una debolezza, è un rovescio diverso, basta confrontare le foglie (esterne) del ramo di destra nel tuo esemplare sono 7 e 6 i ciuffi su quello di sinistra, nel rovescio con caratteri piccoli e rombo sia dopo data che grana, i ciuffi di sinistra son 5 e le foglie esterne di destra 6. I caratteri sembrano tutti corrispondere salvo quello della A che pare più largo! Non è facile da trovare la tua variante. Spero di essere stato chiaro, ma c'è na miriade di varianti di conio per ste monete. Il confronto con il 2 grana fa sembrare i caratteri simili, ma lo sono solo per la dimensione (pare)....se guardiamo la G , la N, la R, la I , la A, sono tutte strutturate diversamente. Sotto un taglio a serpentina. Più sotto uno a treccia in rilievo... per confronto riprendendo il discorso di Beppe.3 punti
-
Buongiorno, la conferenza che tratta un argomento molto interessante e che ha avuto recente risalto dai mass media sarà trasmessa in diretta ai seguenti link: meet.google.com/xss-vtof-eae prima parte 21/11 dalle 21 alle 22 meet.google.com/gpw-ojiq-bir seconda parte 21/11 dalle 22 alle 23 Marco3 punti
-
3 punti
-
Ciao, Il RIC 219 (raro) di Londra presenta la legenda abbreviata BEATA TRA-NQLITAS (sic) Qui mi sembra che sia la solita legenda BEATA TRA-NQVILLITAS, e quindi il più comune RIC VII 216. (Forse @Arka hai tenuto conto della descrizione sbagliata del RIC 216 con legenda BEAT TRA-NQVILLITAS, errore corretto nel libro della zecca di Londinium, Cloke-Toone p. 264) https://www.nummus-bible-database.com/monnaie-43190.htm3 punti
-
Buon giorno. Gli anni di emissione del 5 centesimi sono il 1861, 1862 e 1867 con diversi marchi di zecca. La moneta da 10 centesimi del 1862 che non ha segno di zecca è di Strasburgo. Se non ne fosse già a conoscenza potrebbe trovare queste ed altre interessanti informazioni digitando "catalogo la moneta" e di seguito le verranno indicate le sezioni, nel suo caso "regno d'Italia". Cordiali saluti. Gabriella3 punti
-
Buongiorno a tutti condivido questa mia Osella. La particolarità che mi aveva colpito è il fatto che è stata l'unica osella del doge Foscarini, visto il brevissimo periodo di dogato (è morto dopo meno di un anno). Magari le foto fatte non renderanno bene evidente la bellezza della moneta, però è particolare. saluti2 punti
-
Il presente studio analizza le due piastre celebrative coniate a Napoli nel 1791 a nome di Ferdinando IV. Lo scritto - frutto di ricerche d'archivio - aggiorna quello del prof. Carlo Prota, pubblicato un secolo fa. Infatti, Prota fu il primo a studiare le predette monete avvalendosi delle carte dell'Archivio di Stato di Napoli e gettando così luce su questi affascinanti tondelli. In realtà, compulsando gli stessi documenti consultati dallo Studioso ed esaminandone altri, ho scoperto delle novità, nonché corretto alcuni periodi di carica degli ufficiali di zecca. Con questo contributo spero di soddisfare la conoscenza degli studiosi e collezionisti di monete napoletane. Buona lettura! Alessandro Giaccardi https://independent.academia.edu/AlessandroGiaccardi2 punti
-
salve Mi piacerebbe conoscere il vostro parere a riguardo di questa monetina dal diametro di cieca 11 millimetri e dal peso di 06/07 grammi scovata in un vecchio album appartenuto al nonno marchigiano di un amica il busto ha un aspetto giovanile? Nel monogramma non riesco ad identificare il segno che sovrasta il punto centrale cordialità2 punti
-
Carissimi amici, quest'oggi ho il piacere di mostrarvi l'ultimissimo acquisto della mia collezione. Si tratta, come da titolo, di un centesimo di Napoleone Re d'Italia coniato nel 1809 dalla zecca di Bologna. Direttamente proveniente dall'asta Ranieri ancora in corso, la moneta in questione è giudicata FDC e, personalmente, mi trovo pienamente d'accordo con il giudizio espresso dalla casa d'aste. Pur essendo una moneta coniata in milioni di esemplari, devo dire che negli ultimi anni non mi era mai capitato di vedere un esemplare di questo livello. È veramente uno spettacolo per gli occhi e mi auguro vivamente che possa piacere anche a voi.2 punti
-
Non ha afferrato: se vuole una Ferrari può spende 1 come 1000 non sono un problema i soldi e non ci si lamenta. Se invece non ha questa possibilità allora se ne faccia una ragione (come la maggioranza delle persone) e si dedichi ad altro. Poi mi domando cosa significa È esagerato il doppio o il triplo ? Oppure basta una maggiorazione superiore all'inflazione ? Poi è relativo alle proprie sostanze e alla propensione a spendere: quello che per me può essere esagerato magari per lei non lo è. Il discorso è troppo soggettivo. È per gente come te che ho perso numerosi pezzi: siete sempre disposti a spendere oltre il valore medio pur di accapparrarvi un pezzo e poi vi lamentate con gli altri dei soldi spesi....un po' di coerenza (sto scherzando naturalmente). Questo è valido anche per le fidanzate che ho avuto....e per l'attuale! Ma non diteglielo...è un segreto! PS: quando un sindacato per difendere i diritti dei mariti/fidanzati dallo strapotere femminile ? Naturalmente si tratterebbe solo per quelli buoni che rispettano per primi i diritti delle donne!2 punti
-
2 punti
-
Diciamo che è in conservazione inferiore allo standard: i lineamenti di Ferdinando e Carolina sono andati, e anche di mappamondo e zodiaco non resta quasi niente. A mio parere non arriva a MB, neanche con ottimismo, come si deduce anche dal peso significativamente inferiore.2 punti
-
Ciao, la data potrebbe essere anche 1255, e ci sarebbe una kharuba algerina che ci somiglia proprio tanto: 5 Asper - Abdel Kader - Emirate of Abdelkader – Numista ma non ci siamo con i dati ponderali.2 punti
-
Fatto. Ne avviso anche @Vel Saties2 punti
-
2 punti
-
Ci troveremo qui sabato alle 9,30 precise nel salone al 1 piano Sala Duomo nell’Hotel De la Ville attiguo Duomo. Chiuse le prenotazioni per il pranzo, posso accettare fino a giovedì 2/3 posti ancora per il solo evento. [email protected]2 punti
-
Ricordiamo che i prezzi di vendita di un commerciante possono variare in virtù di diversi fattori e non solo per avidità. Primo tra tutti il prezzo dia acquisto....non sempre si sa quello che ha pagato(a meno che non sia una moneta proveniente da asta e alla quale si devon sommare diritti e spedizione). Una moneta che in asta fa 50 costa finita almeno 65 70 euro quindi 100 euro sono il minimo che può chiedere.....diffidare sempre da chi ti dice "te la giro al costo". Poi dipende se è una moneta che tratta abitualmente o meno....ma una moneta di Milano venduta in sudamerica presumibilmente sarà a un prezzo migliore che se presa a Milano......e anche il contrario. Poi dipende se la moneta è stata comprata in un lotto multiplo...se il venditore ha già guadagnato col resto del lotto c'è buona probabilità di spuntare un prezzo migliore. Insomma ci son tante variabili ma se la moneta è comune e cara si passa oltre. Diverso è il discorso se è rara e difficilmente reperibile ma anche qua a tutto c'è un limite. È non per ultimo i contronti di prezzo si devon fare su due monete in uguale stato conservativo....perche tra qfdc e fdc spesso c'è un abisso di prezzo. Marco2 punti
-
Buonasera,il tondello senza impronte deve avere lo stesso diametro e peso delle sorelle coniate, dalla immagine postata sembrerebbe di diametro minore... Il taglio com'è?... L'1 mancante in diverse annate è un difetto abbastanza comune per questa tipologia,nella maggior parte dei casi è evanescente,poi la circolazione fa il resto...2 punti
-
DE GREGE EPICURI Al CCNM (Milano, via A.Kramer 32, citof. SEIDIPIU') l' ultima conferenza del 2023 si terrà martedì 21 novembre con inizio alle h.21 precise. Costanza Cucini, archeologa medievale ed esperta di metallurgia, ci parlerà su: "La fabbricazione dei solidi del tardo impero romano: il tesoro di Como e la zecca di Mediolanum". Nel corso dello scavo condotto dalla Sovrintendenza a Como, all'angolo fra via Diaz e via Indipendenza, il 5.9.2018 venne rinvenuto il famoso "Tesoro di Como". Lo scavo aveva interessato un edificio tardoantico ubicato fra uno dei cardini e probabilmente il decumano massimo della città romana. Il tesoro era stato occultato all'interno di un contenitore in pietra ollare, chiuso da un coperchio. Al suo interno vennero rinvenuti mille solidi, battuti principalmente in zecche occidentali, assieme ad alcuni gioielli, un frammento di lingotto e alcuni semilavorati in oro. La presenza di evidenti "difetti" in alcuni solidi ha fornito l'occasione per uno studio delle tecniche di fabbricazione delle monete d'oro romane; C.Cucini ha così ricostruito la catena operativa all'interno delle zecche tardoromane, con particolare riguardo a quella di Mediolanum. L'incontro sarà trasmesso anche in video-conferenza; forniremo il link in seguito.1 punto
-
1 punto
-
1 punto
-
Daje Lazioo. Non so aiutarti, però di certo la testa raffigurata nel diritto è femminile.1 punto
-
Ciao Diobolo di Tolomeo II coniato in Sicilia al tempo di Ierone II, successivamente quando Tolomeo II lasciò la Sicilia Ierone II continuò a coniare lo stesso tipo di monete ma la differenza sta nel ritratto di Zeus che prende le sembianze del classico Poseidone che si ritrova comunemente nella sua monetazione. Silvio1 punto
-
Sembra una tessera di beneficienza dal valore di 5 soldi. Come datazione penso possa essere Settecentesca1 punto
-
Armi e monili dei Celti all'arrivo dei Romani: scoperta necropoli dell'Età del Ferro a Casalromano La necropoli della tarda età del ferro scavata a settembre 2023 è è la prima collocabile nella tarda età del ferro ad essere stata indagata nella provincia di Mantova con moderni metodi scientifici. La scoperta del nucleo sepolcrale, composto da tredici tombe, si inserisce in un progetto avviato nel corso del 2022 che ha visto alcuni siti del territorio della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Cremona, Mantova e Lodi interessati da indagini geofisiche (magnetometro e georadar), curate dall'archeologo esperto in field archaeology, Guglielmo Strapazzon, grazie alla collaborazione con l'Istituto Centrale per l'Archeologia e a fondi speciali stanziati dalla Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio. Proprio la combinazione tra i risultati del georadar, che ha individuato un nucleo di fosse rettangolari disposte su diverse file, e quelli del magnetometro, che ha restituito forti anomalie magnetiche in corrispondenza di alcune di esse, ha consentito in prima battuta di procedere a sondaggi mirati che hanno riportato alla luce due tombe a incinerazione con preziosi corredi. Si tratta di due sepolture, una maschile e una femminile, che oltre alle ceneri dei defunti conservavano diversi reperti. In quella femminile è stato rinvenuto vasellame in ceramica, un coltello in ferro e monili come fibule e una collana in vaghi di vetro e bronzo, da quella maschile, invece, il corredo di un guerriero, caratterizzato dalla presenza di uno scudo, di cui si è conservato l'umbone, una lancia, anch'essa senza l'asta in legno, deteriorata dal tempo, una lunga spada con fodero, un coltello e un ricco corredo ceramico. La scoperta ha spinto la Soprintendenza a chiedere ulteriori fondi al Ministero della Cultura per completare lo scavo dell'intera necropoli, affidato alla ditta ArcSAT, al fine di preservare il contesto da eventuali danneggiamenti agricoli e possibili scavi clandestini. La riapertura degli scavi nel mese scorso ha quindi portato alla luce altre undici tombe, disposte con orientamento nord-sud, come le prime due. I corredi emersi confermano un orizzonte cronologico e culturale della tarda età del ferro, compreso tra la seconda metà del II secolo a.C. e l'inizio del I secolo a.C. All'epoca in queste zone erano stanziati i Cenomani, popolo guerriero di cultura celtica, che a partire dalla fine del III secolo a.C. ha intessuto rapporti di alleanza con i romani. Proprio queste relazioni pacifiche avrebbero portato i Cenomani ad adottare diverse usanze dei romani, tra le quali quella della cremazione dei defunti, l'uso di deporre monete nelle tombe e l'adozione di tipologie ceramiche di imitazione. Tipicamente celtiche sono invece alcune scelte del corredo che vedono la sistemazione vicino alle ceneri di armi, nelle tombe maschili, e monili in vetro colorato, come vaghi di collana e armille, che connotano generalmente le tombe femminili. La necropoli di Casalromano è caratterizzata dalla presenza di undici sepolture a incinerazione, con ceneri che dovevano essere contenute in cassette lignee. Queste sepolture hanno restituito notevoli reperti, a partire da armi in ferro, spille (fibule) e recipienti ceramici provenienti da due ricche tombe maschili in posizione centrale nella necropoli. Alle tombe maschili si affiancano sepolture femminili con fibule, ceramiche e collane composte da vaghi in vetro, con colori e decorazioni variegati, e pendenti in bronzo. Fra questi ultimi è particolarmente curioso il ritrovamento di un elemento a forma di ruota sormontato da un cavallino, che per la sua grande somiglianza con quello più noto del sito etrusco del Forcello di Bagnolo San Vito (MN) apre a diverse ipotesi. Nelle ultime settimane di scavo gli archeologi hanno scoperto che due delle tredici tombe che compongono la necropoli erano ad inumazione, conservavano cioè i resti ossei non cremati dei defunti. Si tratta di due infanti, tra i quali una bambina che al polso sinistro portava un bracciale (armilla) in vetro blu ed un secondo che in uno dei recipienti ceramici conservava alcuni frammenti ossei, probabili resti di un pasto sacro. Diversi sono anche i reperti di piccole dimensioni, tra i quali una fibula in bronzo, recuperati dalle attività di setacciatura che hanno visto impegnati i volontari dell'associazione Klousios - Centro Studi e Ricerche Basso Chiese, che hanno affiancato gli archeologi nel corso delle attività di scavo. Le indagini sul campo si sono già concluse, ma lo studio della necropoli è solo all'inizio. I ricchi corredi sono stati temporaneamente ricoverati presso il vicino Museo Civico "G. Bellini" di Asola, in attesa del loro restauro a cura della Soprintendenza.1 punto
-
Qui vicino a casa mia in pieno centtro storico c'è un fruttivendolo storico. Lo chiamiamo amichevolmente "la boutique", indovinate perché. Certo... vai da lui e frutta e verdura sono ottime. Ma sta in centro storico, spostarsi col furgoncino è un delirio, i muri costano etc etc ed i costi sono decisamente più alti. C'è anche una meravigliosa rosticceria. Stesso discorso ma la chiamiamo l'"oreficeria". In entrambe i casi prodotti OTTIMI! Però noi dobbiamo risparmiare ed andiamo da altre parti ad acquistare. Spendiamo di meno, ma ci dobbiamo spostare in auto e qualche volta la frutta si conserva per meno tempo. Ma il fruttivendolo sta in un locale comodo, con il parcheggio, i muri sono di proprietà e se vuoi te la porta a casa con pochi soldini in più.1 punto
-
Buongiorno, se Le piace, la prenda. La moneta è molto gradevole e, soprattutto, ha un valore storico che il 99% dei prodotti contemporanei non ha. Il resto conta poco... Un saluto cordiale.1 punto
-
Buongiorno. Innanzitutto mancano diametro e peso per essere precisi nella identificazione comunque trattasi di un AE3 di Valentiniano (secondo me il I) si legge bene D N VALENTINI-ANVS P F AVG con al rovescio la SECVRITAS-REIPVBLICAE Zecca di Cizico SMK(B?) RIC IX CYZICUS 11-131 punto
-
Anche ieri Umberto Reano ha scritto di tre aurei imperiali (Massenzio, Quintillo e Vespasiano) in asta NAC sempre nell'inserto economico del CORRIERE. Bisogna riconoscere che Le testate giornalistiche con una lunga storia di editoria economica pubblicano - ogni tanto - notizie numismatiche legate alle grandi aste internazionali. Certo, a noi piacerebbe se ne parlasse a colazione, pranzo e cena, proprio come ogni astrofila vorrebbero vedere in ogni telegiornale la scoperta di un "insignificante" asteroide JG568JC357😝KI8, proprio come ogni esperto di cucito vorrebbe discutere di punto a croce con tutti i suoi rispettivi amici, proprio come ogni amante di Jacques LeGoff vorrebbe parlare dei suoi ultimi scritti con i colleghi dell'ufficio ufficio comunale. Non tutte le esperienze sono condivisibili. Ma non potrebbe essere diversamente. https://www.corriere.it/economia/risparmio/23_novembre_06/moneta-d-oro-che-vale-400-mila-euro-massenzio-riconquista-l-africa-87ee9cc6-7c8c-11ee-90f0-2d45ce928adc.shtml1 punto
-
Sono d'accordo con nikita, è il Km# 85. La data, per me è AH1256, come la moneta di cui di seguito posto una foto1 punto
-
Comunque, credo che se la giochi con il centesimo del 1807 zecca di Milano che presi qualche tempo fa da Nomisma. Entrambi due esemplari notevoli.1 punto
-
Visto con piacere il ritorno dell'ottima discussione. Il mio unico argento in "raccolta"... gr 0,54 mm. 10 h 3, da LAC auction 26, lot 2, 25/6/2013. Etnico ?1 punto
-
Valore storico forse sì (è il primo caso di Pontefice emerito, e quindi di due pontefici "legittimi" insieme, oltre che il primo papa che ha abdicato dopo 600 anni: l'ultimo era stato Gregorio XII all'inizio del 1400, anche se i motivi furono ben diversi), economico chi può dirlo? Comprala se ti piace la moneta o ti interessa l'evento nella storia del Vaticano, altrimenti lasciala1 punto
-
Evviva lo storico diritto al mugugno! (...con moderazione) https://www.arcipelagomilano.org/archives/29086 Felice mattina comunque a tutto il forum.1 punto
-
Forse il caso di ricordare che il mercato è fatto da domanda e offerta, se c'è la prima ...la seconda sarà di conseguenza.1 punto
-
1 punto
-
Mi perdoni se glielo chiedo. Vorrei contestualizzare. L'eccessivo sovrapprezzo su quale monetazione lo ritrova? Altra cosa: parliamo di negozi fisici, negozi online o aste?1 punto
-
Scusi ma non mi pare che sia obbligato a comprare qui in Italia. Se trova più convenienti i prezzi che fanno all'estero, compri pure da loro. Non capisco perché debba pretendere che i venditori italiani applichino i prezzi che dice lei. Se chiedono più del doppio, vorrà dire che ci sarà qualcuno che gliele compra a quella cifra (buon per loro). Le faccio un esempio: ho un problema alla macchina. Vado dal primo meccanico e mi fa un preventivo di 2.000 euro. Mi sembra un costo eccessivo, quindi mi rivolgo a qualcun altro. Il secondo meccanico mi dice che per risolvere il problema bastano 1.000 euro. Cosa faccio? Porto la macchina dal secondo meccanico o mi ripresento dal primo e lo accuso di essere uno speculatore perché c'è qualcun altro che mi fa pagare la metà di lui?1 punto
-
@Reficul In effetti l'intervento era in buona fede ma capisco il "rimprovero" e lo accetto, impegnandomi a non ripetere l'errore. 🙂 @Cremuzio Mi permetto di dissentire dal Suo intervento per i motivi che ho già espresso in qualche post precedente. Aggiungo che l'obiettivo della discussione non è certo quello di far cambiare idea a nessuno bensì quello d'invitare a una riflessione storica coloro i quali vorranno cogliere i tanti spunti emersi. E' chiaro che il Forum non è luogo di "guinness dei primati" ma sono fermamente convinto che migliaia di visualizzazioni significhino interesse per questa discussione e non solo attesa della rissa, come da taluno paventato. Invero, come si possa collezionare monete di Vittorio Emanuele III senza conoscere o riflettere sulla Sua biografia rimane per me un mistero. Un saluto cordiale e a presto.1 punto
-
Boh per me rimane un sesterzio da 1000/1200 euro massimo, l'unico prezzo sensato mi sembra quello di Rauch. Da NAC potrebbe anche essere andato invenduto, dato che parrebbe aver fatto solo la base e in questi casi se c'e' una protezione di qualche tipo sulla moneta non si puo' sapere se e' una vera vendita o una moneta protetta. Da Heritage sara' finita a qualche collezionista di slab, ormai ci son quelli che collezionano il grado senza guardare manco la moneta: una moneta che a me pare un onesto BB+ al massimo, con debolezze di conio sulle legende e corrosioni importanti, il ritratto non mi sembra niente di che a livello di dettaglio e conservazione. Belli invece i dettagli della porta al rovescio ma non sufficienti a giustificare certi prezzi. Come si fa poi a dare 5/5 di strike grade alla battitura di questa moneta quando ha debolezze di conio su entrambi i lati e una leggera doppia battitura? Bah... numeri che sembrano dati a caso... Contenti loro...1 punto
-
Secondo me, il doge è sempre in ginocchio e quello sotto è il drappeggio della veste. Se fosse in piedi le mani dovrebbero essere in diversa posizione. Arka Diligite iustitiam1 punto
-
Poco conosciuto, poco citato, purtroppo mai tradotto in italiano, ma un ottimo libro.1 punto
-
taglio: 2 euro cc paese: Germania G anno: 2022 A tiratura: 4.200.000 condizioni: Spl città: Pavia (PV) taglio: 2 euro cc paese: Francia anno: 2021 A tiratura: 7.000.000 condizioni: Spl città: Pavia (PV) taglio: 2 euro cc paese: Italia anno: 2023 A tiratura: 3.000.000 condizioni: Spl+ città: Pavia (PV) note: NEWS!!!!1 punto
-
L’abbinamento colore del metallo delle monete-colore del velluto dei vassoi può sembrare un tema banale, ma in realtà ha una sua qual rilevanza. Come per tutti i collezionisti anche per la grande maggioranza di noi l’occhio vuole la sua parte.😳😉 Personalmente io prediligo: a. l’argento sul velluto blu notte b. Il rame sul velluto verde scuro c. l’oro sul velluto rosso Ma è del tutto soggettivo 🤷🏽♂️1 punto
-
1 punto
-
una riproduzione fatta MOLTO male ha fatto una truffa a avenderla l'originale. Il modello-tipo ellenistico da cui la figura del cavallo col fantino è stato ripreso ancora di più “Fantino di Capo Artemisio”, in bronzo, opera di scultore anonimo databile intorno al 140 avanti Cristo.1 punto
-
Hai presente una banconota da tre euri ? Uguale. E tu hai fatto bene a chiedere prima.1 punto
Questa classifica è impostata su Roma/GMT+01:00
Lamoneta.it
La più grande comunità online di numismatica e monete. Studiosi, collezionisti e semplici appassionati si scambiano informazioni e consigli sul fantastico mondo della numismatica.
Il network
Hai bisogno di aiuto?







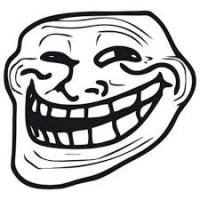

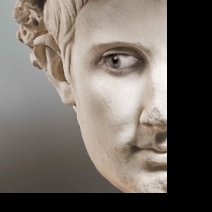

.thumb.jpg.7465dcefb0e1213792bc96ce11cef23e.thumb.jpg.54888fa11660589b37c279812a6cc72d.jpg)
.thumb.jpg.a1a5a94449a3252a5e0fc3b3e618ead2.jpg)