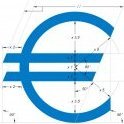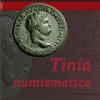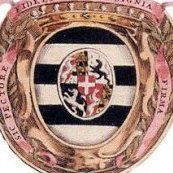Classifica
Contenuti più popolari
Elenco dei contenuti che hanno ricevuto i maggiori apprezzamenti il 02/20/24 in tutte le aree
-
5 punti
-
Buona serata a tutti Volevo annunciare anche sul Forum il prossimo evento Collezionistico( prevalentemente Numismatico ) A FIRENZE . DOMENICA 7 APRILE ci sarà il primo "mercatino del collezionismo" a FIRENZE . INGRESSO LIBERO DALLE 9:30 ALLE 18:30 PRESSO IL PARTERRE ( PIAZZA DELLA LIBERTA') in Via del ponte rosso 2 a FIRENZE . PER INFO potete scrivere qua sotto o contattarci direttamente . ANCORA DISPONIBILI POSTI PER ESPOSITORI ( TOT 15/20 POSTI TOTALI) con possibilità in futuro di usare gli spazi esterni . Nelle prossime settimane pubblicheremo anche la lista degli espositori . Una breve descrizione dell'evento e info generali : l'evento non è un convegno numismatico ma un mercatino , seppur ci siano molti aspetti che possano ricordare un consegno . l'obbiettivo è quello di creare un ambiente stimolante per il commercio e lo scambio di oggetti da collezione ( anche se principalmente improntato sulla numismatica ) . Per quanto semplificate le due planimetrie 3d sono pressoché identiche rispetto agli ambienti reali , la porta centrale sarà chiusa e tutti gli espositori avranno le spalle coperte . Come intuibile dal nome è previsto un evento per ogni stagione . L'ingresso è libero e il costo per gli espositori sarà di 20 euro totali per 2 tavoli 80x80 cm . Ci sono a disposizione 2 bagni e il bar al piano di sopra . Sotto la struttura è presente un ampissimo parcheggio a pagamento che vi può permettere di trasportare il materiale in discreta sicurezza essendoci solo 50 m scoperti per arrivare alla sala . Anche per una bevuta in compagnia o due scambi siete tutti i BENVENUTI . Leonardo Lavagnini4 punti
-
Carissimi, ho notato una certa confusione da parte di qualcuno nel ricostruire e comprendere la vicenda delle monete della Nota 56 e ne approfitterei per chiarire alcuni passaggi, fornendo, grazie all'aiuto dell'Utente Viganò, silenzioso ma preziosissimo compagno di viaggio, oltre che instancabile e convinto sostenitore che i “muri di gomma” non esistono (ma finora la Sua teoria si è rivelata fallace...😁.), il Decreto ministeriale del 1992, che allego alla presente: 1. Come noterete leggendolo, questo decreto del Ministero del Tesoro istituiva nel 1992 una Commissione interministeriale allo scopo di catalogare e stabilire il valore delle monete della Nota 56 nonché formulare una “'ipotesi di alienazione o immissione graduale nel mercato” (sic!) assegnando al Museo della Zecca solo quelle monete del compendio aventi particolare valore storico e/o numismatico. Da qui la preoccupazione, certamente tutta collezionistica e mercantile, che l'immissione sul mercato (normativamente consentita ed auspicata dallo Stato) in grande quantità di queste rare o rarissime monete di V.E. III, potesse determinare la discesa verticale dei prezzi degli esemplari in mano ai collezionisti e ai commercianti. Ma accanto a questa considerazione, che poteva anche lasciare il tempo che trovava a chi non era interessato al valore venale dei suddetti esemplari, si aggiungeva l'interesse e la curiosità degli studiosi per alcuni pezzi citati dalla Nota 56 quali, su tutti, i pezzi di prova del 100 Lire 1940 XVIII E.F. in proof, lavorazione della quale il Gen. Luppino, che per motivi professionali aveva frequentato la Zecca all'epoca delle indagini della G.d.F. ma anche a seguito dei suoi studi ulteriori, non aveva mai trovato evidenze che la confermassero. Con questo spero di aver innanzitutto chiarito i motivi che spingevano (e, in teoria, dovrebbero ancora spingere....) alcuni numismatici ad approfondire il tema della Nota 56; 2. Passando al lavoro della Banca d'Italia intitolato “Beni svelati” esso è certamente pregevole, ma lascia del tutto a bocca asciutta coloro che si erano interessati, se vogliamo anche molto attivamente, alle vicende della Nota 56. In primo luogo perchè il lavoro della B.I. non fa proprio alcun riferimento alle monete della Nota 56. Inoltre, se si va a leggere la prima parte dello studio della B.I. e si cerca di coordinarla con il contenuto del D.M. del Tesoro del 1992, non si può non provare un senso di disorientamento. Cercherò di spiegarmi meglio. Se leggete la parte introduttiva dei “Beni svelati”, noterete che i preziosi di cui lo studio si occupa vennero “traslati” dai caveaux della Tesoreria dello Stato (siti in Roma nella Via XX Settembre) ai caveaux della Banca d'Italia (siti in Roma nella Via dei Mille) solo nel 1999. Ciò significa che in occasione dell'emanazione del Decreto ministeriale del 1992 (vedi allegato), che istituiva la Commissione per la catalogazione delle monete riportate nella Nota 56, tali monete - contenute nei famosi 11 barili - si trovavano ancora in Via XX Settembre. Nel 1999 avrebbero dovuto essere trasferite insieme a tutto il resto del materiale prezioso in Via dei Mille (B.I.) ma, considerato che la Commissione istituita nel 1992 terminò i suoi lavori nel 2009 (questo ce lo dice la Nota 56), si può forse pensare - e questa è una domanda - che nel 1999 gli 11 barili della Nota 56 non vennero trasferiti anch'essi, unitamente a tutti gli altri beni preziosi, alla B.I. ma rimasero in Via XX Settembre a disposizione della Commissione istituita con il D.M. del 1992 che non aveva ancora terminato i suoi lavori? Ciò potrebbe spiegare perchè tra in “Beni svelati” non compaiano le monete della Nota 56. D'altro canto, però, e questo è il motivo del “disorientamento” di cui dicevo prima, è abbastanza singolare che fra le due Commissioni (quella interministeriale istituita dal Ministero del Tesoro nel 1992 e quella sempre interministeriale + B.I. istituita dal Ministero dell'Economia e delle Finanze nel 2018) non ci sia stato alcun coordinamento, sebbene nella parte introduttiva del lavoro “Beni svelati” si dia atto di pregressi “Gruppi di lavoro” che operarono alla ricognizione dei materiali nel 2005/2006 e persino (a pag. 26 del testo dei "Beni svelati") si faccia riferimento ad una Commissione istituita già nel 1978. Quindi l'excursus storico che possiamo leggere nello studio della B.I., fra l'altro molto accurato e circostanziato, non si limita a trattare le vicende dei materiali a partire dal 1999 (anno in cui i beni pervennero all B.I.) ma risale a ben prima. Ciononostante, non si fa alcuna menzione del D.M. del 1992, dell'istituzione della relativa Commissione, dell'esito che ebbero i lavori della stessa e della collocazione delle monete che a questo punto, se tanto mi da tanto, non sono confluite in B.I. ma dovrebbero essere rimaste in Via XX Settembre. Un'altra, per me sorprendente notizia, che si apprende leggendo lo studio della B.I., riguarda il numero delle interrogazioni parlamentari presentate alle quali è stata (a quanto pare) sempre fornita risposta, in merito alla situazione e consistenza di beni preziosi già appartenenti a Mussolini ed a Casa Savoia, custoditi prima dal Ministero del Tesoro e poi, dal 1999 in avanti, dalla B.I. Probabilmente alla “nostra” interrogazione, che come è noto non è stata minimamente presa in considerazione anche dopo essere stata riproposta dal parlamentare firmatario con ulteriore sollecito, sono forse mancate nel suo contesto le parole “Mussolini”, Casa Savoia” o “Fascismo” per riscuotere quell'appeal che evidentemente non è stato (volutamente?) colto da chi sarebbe istituzionalmente chiamato, se non per trasparenza almeno per educazione, a rispondere ad un parlamentare della Repubblica che deposita un atto formale quale è l'interrogazione a risposta scritta. In realtà, la risposta che la “nostra” interrogazione parlamentare sulla Nota 56 sollecitava non era poi così diversa dalle risposte che sono state fornite dai ministeri competenti alle simili interrogazioni sui beni preziosi appartenuti ai personaggi sopra citati e custoditi prima dal Ministero del Tesoro e poi dalla B.I. Ma tant'è. A questo punto della storia, per me la vera domanda da porsi dovrebbe però essere diventata questa: che fine hanno fatto le monete della Nota 56?😁 Saluti. M. DMT 25.05.1992.pdf4 punti
-
Buonasera a tutti, condivido una mia Piastra 1834 - Variante al R/ aquile capovolte - R2 (Nomisma 931 - Gigante 58g) Contorno al D/ (37,5 mm / 27,30 g).3 punti
-
La prima volta che mi mostrarono questa moneta la mia risposta fu: "deve esserci un errore, il rovescio è di un'altra moneta, credo di Aureliano". E invece ero io quello che sbagliava. Grande fu la mia sorpresa quando poco dopo mi fu mostrato un video che mostrava chiaramente che dritto e rovescio erano le due facce della stessa moneta. Dritto: IMP(erator) CONSTANTINVS P(ius) F(elix) AVG(gustus). Busto laureato, drappeggiato e corazzato a destra di Costantino I. Rovescio: ORIE-(N)-S AVGG (Augustorum). Sol avanza a sinistra e calpesta un prigioniero con berretto frigio seduto ai suoi piedi, solleva la mano destra, regge un globo nella mano sinistra, la clamide cade dalla spalla sinistra. Lettera R a sinistra del campo e lettera F a destra. Esergo: R*P (Romae * Prima = Prima ufficina della zecca di Roma). 2,76 gr; 21 mm Inedita in tutte le operare consultate.2 punti
-
Napoli Ferdinando IV (1759-1816) primo periodo (1759-1799) Piastra del 1791 D/Busti accollati dei regnanti R/Sole, Terra e Zodiaco2 punti
-
Ciao, è un mezzo carlino coniato a Napoli durante il regno di Filippo III di Spagna,1598-1621... Dovrebbe collocarsi nelle produzioni del I° periodo,1599-1609.. Con dietro la testa la sigla GF del mastro di zecca Giovanni Antonio Fasulo che ricoprì la carica dal 1594 al 6 settembre 1611,e sotto al busto la sigla GI del mastro di prova Gaspare Giuno che ricoprì la carica dal 1591 al 6 giugno 1609... Il tuo mezzo carlino è catalogato Raro al numero 36,pagina 175 del: "LA MONETA NAPOLETANA DEI RE DI SPAGNA NEL PERIODO 1503-1680"... di Pietro Magliocca... La tua moneta è assolutamente originale...2 punti
-
Eccomi di nuovo con qualche dettaglio. Innanzitutto la coroncina di fianco al volto di Carlo III, segno distintivo di questo set proprio perché il 2023 è l'anno dell'incoronazione. Il ritratto è di Martin Jennings, come si nota dalla firma piccola sotto al collo MJ. Il rovescio mostra, sulla parte sinistra, un pattern formato da tre C, simile al pattern delle monete di Carlo II (1660 - 1685). Il pattern delle monete di Carlo II d'altronde si rifà a quello che è il suo monogramma.2 punti
-
Il contenuto della nota 56 poteva essere noto solo ai componenti della Commissione (interpellati con zero risposte) o a funzionari dell'IPZS...(interpellati, zero risposte)..Banca d'Italia...non ne sapeva assolutamente nulla..2 punti
-
le citazioni esistono e per un tipo diverso da quello di Antiochia citato...2 punti
-
Una delle prime che trovai da bambino e che fece partire la mia collezione, sempre un piacere ritrovarla Taglio: 2 euro Paese: Monaco Anno: 2001 Tiratura: 899.800 Condizioni: BB Città: Bibione (VE)2 punti
-
Se andate a leggere il libro Dei due autori potrete notare che la nota 56 è del tutto avulsa dal pezzo che va dalle pagine 150 e seguenti...quanto scritto nella nota 56 non appare nel volume pregevole dei due funzionari..e dunque..da dove sono stati estrapolati quei numeri?? In quanto ad essere presi/ossessionati dalla questione...lascio agli studiosi ogni autonoma valutazione...se volete vi scannerizzo le pagine 150 e seguenti...ma non troverete quei numeri...inventati? estrapolati da qualche altro scritto? chissà..l'ossessione continua😂 Fatti..non parole...e direi..carta NON canta😂2 punti
-
Buona sera a tutti. Vi pregherei di dare un'occhiata a queste banconote. La Slovenia, dopo essere diventata indipendente, non usa più il dinaro come valuta, ma usa l'€uro. Prima dell'€uro però cosa c'era? I tallero, come voi tutti credo sappiate. E in mezzo al dinaro e al tallero? C'era una valuta, che non aveva nome, pero esisteva. Le banconote di questa "valuta fantasma" sono state stampate nel '91, dopo l'indipendenza slovena. Durò poco, ma fu stampato un contingente abbastanza elevato di banconote. Queste banconote hanno un a storia perciò interessante, ma al contrario dei talleri venuti dopo, sono dal punto di vista estetico orribili :nea: VI PREGHEREI DI FORNIRMI LA VALUTAZIONE D QUESTE BANCONOTE, E SE QUALCUNO HA QUALCHE INFORMAZIONE CHE MI è SFUGGITA O ALTRO, SCRIVA PURE, grazie Ecco la banconota da 50, dalla mia collezione (come tutte le banconote che posterò)!1 punto
-
Con largo anticipo segnalo anche quest' anno l'iniziativa del Ns. circolo giunta alla 47 ma edizione: Siamo a 5 Km. da Forte dei Marmi, 20 minuti dalle cave di marmo di Carrara e mezz'ora dalle 5 terre....ideale per programmare un bel fine settimana di vacanza ! Vi aspettiamo Daniele1 punto
-
Patina bellissima, la moneta è mineralizzata, verde smeraldo. 18.2g e 29 mm1 punto
-
Quella che sembra ruggine non sono altro che le zone dove è saltata la patina ed è venuto fuori il metallo originale, purtroppo non ci sono soluzioni a riguardo...1 punto
-
E spessore (mm) Se ti stai appassionando,un bilancino dai cinesi, due cifre dopo la virgola,per intenderci,lo trovi a 8€. Serve sempre.1 punto
-
Grazie, la uso per paragone. Sembra buona. Sotto un bello strato di verde, ma credo sia ok.1 punto
-
Cantami, o diva, del Pelìde Achille l'ira funesta che infiniti addusse lutti agli achei,… Buona serata, apollonia1 punto
-
Stessa discussione, medesimo richiedente, stesse identiche conclusioni ... a esattamente un anno di distanza. Mi sembra davvero assurdo.1 punto
-
1 punto
-
1 punto
-
Numismatica Ars Classica > Auction 140 Auction date: 7 November 2023 Lot number: 161 Price realized: 50,000 CHF (Approx. 55,754 USD / 51,879 EUR) Note: Prices do not include buyer's fees. Lot description: Rhodes Tetradrachm, reverse die signed by Xe(no)– circa 404-385, AR 22 mm. 15.14 g. Head of Helios facing, slightly r. Rev. POΔION Rose, bud to r.; below, Ξ – E and in l. field, A above lion's head r. All within incuse square. Hecatomnus 50 (A33/P43) = Bérend, Tétradrachmes 33 (this coin). Ashton, CH IX 28 (this coin cited). HN Online 1018 (this coin illustrated). Extremely rare, only six specimens known with the signature by Xeno on the reverse. A portrait of excellent style struck in high relief and a superb old cabinet tone. Extremely fine Ex Leu 77, 2000, 326; Classical Numismatic Review XXV, 2000, 51 (illustrated on cover page); Triton X, 2007, 358 and Triton XIV, 2011, 329 sales. From the Marmaris hoard (IGCH 1209). The coinage of Rhodes has been the subject of intensive study in recent decades, and many aspects of the series are now more clearly defined. Coinage for 'Rhodes' commenced in 408/7 B.C. after the citizens of three major cities on the island largely abandoned their ancestral homes to create a new city, Rhodes, on the northern tip of their island. This bold act was the catalyst by which Rhodes became a powerful maritime state that prospered throughout the political chaos of the Greek world during the forthcoming age of the Hellenistic monarchies. This Chian-weight tetradrachm was struck in the midst of the period of great production at Rhodes, by which time the mint's engravers were routinely producing facing heads of excellent style in high relief. This series covers nearly two decades that span the tail end of the 5th and the early years of the 4th Century B.C.; it includes 41 different symbols and control letters that have thus far been identified, though statistical analysis suggests more are yet to be discovered. Perhaps the most surprising aspect of Rhodian coinage from this period is that it appears to have enjoyed relatively limited circulation. Hoard evidence shows that they are seldom found outside of the island of Rhodes or the nearby regions on the mainland. Considering the formidable reputation of Rhodian sailors and their extensive mercantile contacts, one might presume the larger silver coins would be widely dispersed throughout the Greek world, especially since the Delian inventories indicate Rhodian coinage was commonly used, and coins of the Rhodian type apparently were in demand by Greek mercenaries. A key to this riddle might be the anachronistic weight standard used by Rhodes, which may have assured its coins were not readily exchangeable with those struck to the more popular Attic and Phoenician/Ptolemaic weight standards. Though it is always possible that most of the Rhodian coins exported in trade were melted due to their inconvenient weight, it is just as likely that Rhodian coinage was struck to a local standard with the intention that it would remain local to pay for the extraordinary expenses accrued each year by this powerful state, and that trade was largely conducted in the 'international trade currencies' produced by the major Greek states. Estimate: 40000 CHF1 punto
-
In effetti è strano che case d aste le quotino a prezzi insensati. È per questo che mi era venuto il dubbio sul loro intrinseco valore. Di oro nn c è nulla però magari il mercato degli collezionisti poteva essere interessato... Ora ho capito che ne l uno ne l altro hanno sbocco... e certo non mi metto a venderle per ciò che non sono (non sono avvezzo a truffare gli altri). Ps diam 10 mm peso 0,5 gr l una Grazie a tutti del tempo dedicatomi Ern1 punto
-
No, si tratta esattamente di quello che la legge richiede e concede di fare. E adempie a tutti gli obblighi di legge. Andare oltre non avrebbe senso giuridico e non sarebbe neanche legale se non in pochissimi casi di pregressa provenienza pubblica. Si richiede un passo per volta nel procedimento inverso, per tutela degli attori1 punto
-
Ciao, moneta autentica con delicata patina. Mi sembra tutto a posto, è un piacevole esemplare per la tipologia. Se la devi acquistare è importante sapere il peso, per scongiurare eventuale tosatura. ps. Sposto la discussione nella sezione dedicata alle monete napoletane1 punto
-
1 punto
-
Si ,anche i depositi del museo archeologico di Napoli non sono musealizzati a essendo proprietà dello Stato non credo che qualcuno possa , ufficialmente,anche solo pensare di commercializzare tali oggetti. Anche perché sta' tonnellata e rotti di oro montato avrà ormai assunto dignità di insieme numismatico con valenza storica..1 punto
-
ok quindi parliamo di un aspetto che però è psicologico, non numismatico .... sapere che questa cosa esiste, anche se non è in vendita e non lo sarà mai, cambia il mio approccio alla cosa stessa.... non lo capisco...non mi sembra perfettamente logico... ma la cosa c'è è ne prendo atto. grazie comunque per la risposta e scusate "l'intormissione"1 punto
-
Ciao,sono repliche ridotte placcate in oro 8 karati,anni fa ne comprai alcune per mio figlio e mi sembra di ricordare che le pagai 3 Euro e mezzo l' una,le comprai in edicola... https://www.poggiobracciolini.it/it/asta-0260/carta-settebello-con-piccole-monete-oroand-202011110104600 Mi sembra strano che la pandolfini metta in asta delle cose del genere che non hanno nulla ne con l'arte e tantomeno con la numismatica,per non parlare poi della stima...1 punto
-
Beh insomma. Sapere che da qualche parte ci siano solo più di 5000 pezzi di 100 lire fascione non è proprio cosa da poco. Non colleziono ori del regno ma come minimo ci penserei 10 volte prima di prenderla. Poi che nessuno abbia interessi a farle uscire da lì è un altro discorso.1 punto
-
Falso numismatico o falso moderno,atto a frodare il collezionista. Ne esistono altri, fatti peggio di questo. Saluti1 punto
-
Mi spiace ma non sono in grado di dare valutazioni su questi amuleti e non ho idea se esista un mercato per tali oggetti. Anche per l'autenticità non posso pronunciarmi... troppe varietà prodotte in oltre 400 anni e troppe copie moderne. In rete ne ho trovati di identici ... ma dichiaratamente falsi (da 10 a 60 $) Però c'è un Museo in California (CMA) che ha una vasta raccolta di monete cinesi e... c'è anche questo amuleto. https://cmacoin.com/goods.php?id=2654 P.S. Si può selezionare la lingua Inglese o cinese ... ma probabilmente è più semplice usare il traduttore1 punto
-
Ne ho trovato un esemplare senza stampa del numero di serie e dell'intestazione.1 punto
-
Non sono ancora in grado di dare giudizi autorevoli sulle monete che lascio quindi agli esperti del forum, magari imparo qualche cosa anche io, come contributo, sperando possa essere utile, metto come paragone quella in mio possesso che sono certo essere autentica perché acquistata da un negozio di fiducia: Asse, coniato da Caligola, 37-41 d.C., Roma, RIC 58, 10.53g x 27mm Al D/ M AGRIPPA L - F COS III; testa coronata di rostri. Al R/ S - C; Nettuno con delfino e tridente.1 punto
-
@Atexano E' sempre bene non attaccarsi a vecchie discussioni (questa e' di sei anni fa) in quanto dopo così tanto tempo si e' ormai perso il filo conduttore. A meno che non si voglia dare loro una rinfrescata apportando qualche novità significativa ad esse attinente. Ho visto che hai già aperto una discussione sulla tua moneta in area "identificazioni". Se lo ritieni opportuno, potresti magari citare questa discussione nella tua. Capisco la tua fretta di avere una risposta, ma devi considerare che la maggior parte delle persone che scrivono qui sul forum lo fanno nel poco tempo libero (sempre più poco, in verità) che hanno a disposizione. Ciao. Stilicho1 punto
-
Certa gente non ha proprio niente di meglio da fare che deturpare monete? Bah...1 punto
-
Arrivato oggi dalla Royal Mint. Devo dire che mi piacciono molto. Perdonate le foto non eccelse1 punto
-
1 punto
-
Il bello del Convegno di Pistoia, fin dalla prima edizione a cui avevo partecipato, e’ questo sapiente mix di unire l’ambito commerciale con quello culturale di presentazioni libri o relazioni creando maggiori interessi e opportunità di partecipazione all’evento.1 punto
-
1913 CARLO ROMUSSI (MILANO 1847 - MILANO 1913) Avvocato, giornalista e politico Italiano, studioso della storia milanese. Scrisse in due volumi: Milano ne' suoi monumenti, 1875; Il libro delle società operaie, 1880; I grandi italiani. Carlo Cattaneo, 1884; Il Duomo di Milano, 1902; Storia d'Italia narrata al popolo, 1910; Manualetto del cittadino italiano,1910; Milano che sfugge, 1913; LE CINQUE GIORNATE DI MILANO nelle poesie, nelle caricature, nelle medaglie del tempo, 1894. Anche Numismatico che ha collezionato Monete e medaglie di Milano. Bronzo argentato, mm.70 - Autore Ernesto Bazzaro, stab. GIOVANOLA1 punto
-
Ripropongo questo accendino (ca 4x5 cm) marcato argento 800 tra le braccia del giovane che sventola la bandiera perché la foto originale non si vede più. L’accendino è a benzina. Alla sommità la scritta su tre righe D. R. G. M. PAT. a./IN ALLEN/KULTURSTAATEN Il marchio di fabbrica (Deutsches Reich Gebrauchsmuster) e la frase “In tutti i paesi civilizzati” rivelano la sua appartenenza al Vintage di Germania. Però io l’ho acquistato negli Anni '70 in un mercatino di Londra. apollonia1 punto
-
Mah...gli statuti sono belli e roboanti..come la Costituzione..peccato che poi molti articoli siano totalmente ignorati..diritto allo studio dell'obbligo gratuito, sanità, concorrere equamente in base alla capacità conttributiva ecc ecc. Quindi...sicuramente le associazioni hanno obiettivi preminentemente culturali ma non posso fare a meno di notare che nei circoli si fanno anche tante compravendite, e non sempre di qualche centinaio di euro.. Dai, diciamolo chiaramente, a nessuno fa piacere sapere che di alcune tipologie monetarie esistono migliaia di pezzi...anche se non immessi sul mercato creano ansie nel collezionista che fino a ieri pensava di avere pezzi piuttosto rari in collezione. Si la NIA qualcosa ha fatto visto che il Presidente insieme a Viganò ha fatto di tutto per promuovere le interrogazioni parlamentari. Bizerba ha scritto ai Ministeri, ai componenti della Commissione che si è occupata di inventariare il materiale di cui alla nota 56 ma le risposte sono state evasive e in alcuni casi non ci sono state proprio! Senza l'errore della nota 56, che considero uno scivolone, di questo materiale non si sarebbe saputo nulla per chissà quanto tempo ancora. Mi piacerebbe tanto sapere chi ha inserito nella monografia la nota..e soprattutto sapere che fine ha fatto😀1 punto
-
saluti a tutti, da organizzatore del Convegno di Salerno, mi permetto di dare qualche specifica ulteriore. 1) L'area militare dove sorge la stazione marittima di Salerno, e' interdetta al passaggio veicoli se non autorizzati ( autorizzazione all'ingresso carico /scarico e costo della sosta per espositori fuori regione SONO A TOTALE CARICO della organizzazione) 2) l'area e' presidiata da sbarra di ingresso con guardiola tra due edifici , uno della GDF e l'altro della Capitaneria di Porto che ha autorita' sulla zona portuale. 3) 35 le telecamere tra esterno ed interno che supervisionano la zona della esposizione. 4) 7 elementi della security incluso guardianìa notturna armata e in borghese hanno sorvegliato tavoli, ingressi e esposizione (ANCHE questi a totale carico della organizzazione) 5) la zona di Carico e Scarico pertanto era protetta da telecamere e personale queste cose ovviamente hanno un costo, un costo che spesso gli organizzatori NON vogliono pagare per intascare cifre che dovrebbero invece essere destinate alla esposizione. Le scelte di altre organizzazioni di non inserire elementi di sicurezza, di non stipulare un contratto con una societa' di sorveglianza diurna o notturna, di utilizzare location economiche o fuori mano o disagevoli, sono figlie della avidita' organizzativa. Da imprenditore credo illuminato, ho scelto di fare piazza pulita di questi errori e di investire nella qualita'; il tempo mi ha dato ragione. Il meteo quest'anno non ci ha consentito di fare aperitivo sul mare, ma la esposizione ha premiato economicamente tutti gli espositori e garantito ai collezionisti di aggiungere un pezzo o piu' alle loro collezioni. La presenza di produttori che hanno esposto, come la Leuchtturm, direttamente dalla germania, la presenza di 5 case d'asta, e di quella di espositori da ogni regione ncluso le isole di Sardegna e Sicilia, ci hanno gratificato pur essendo solo la seconda puntata della kermesse. Questo vuol dire che non basta avere un pedigree di decenni per fare una fiera di grande qualità. L'appunto sulle luci lo ricevo e lo prendo a spunto per migliorare ulteriormente il servizio di illuminazione che era gia' stato implementato e arricchito dalla prima edizione dello scorso anno, ma migliorare si puo' e SI DEVE. Ultima nota a margine: mi occupero' anche della organizzazione del primo convegno di Giulianova, per creare lo stesso standard qualitativo per una nuova esposizione nel centro italia. Mancano a mio parere le basi strutturali e la voglia di INVESTIRE economicamente (anche magari andando in perdita per qualche anno) per CREARE e MANTENERE un successo espositivo; ma ci proviamo almeno per Salerno e spero Giulianova. Un saluto a tutti Pierpaolo Irpino.1 punto
-
Premetto che condivido in toto quanto scritto da @Tinia Numismatica. Purtroppo, a mio parere, questo non è un attestato di provenienza. Ció che il venditore si è limitato ad attestare è l’autenticità della moneta. E certamente non basta richiamare l’art. 64 per fare assumere a questo documento la valenza di attestato di provenienza. La cosa peggiore è che il venditore non si è neanche sforzato di scrivere “attesto ai sensi dell’art. 64 CdB la lecita provenienza della moneta”, come pure molti fanno (secondo me sbagliando) ma almeno sarebbe stato qualcosa…1 punto
-
Vale milioni!!! Avevate mai visto prima un 100 LIRI?? Un unicum! 🤣🤣🤣1 punto
-
Buonasera a tutti, per far compagnia alle piastre di @El Chupacabra, posto una delle mie Napoletane. Piastra 120 grana Ferdinando II millesimo 1834, Taglio inciso al rovescio, scusate per le foto, oggi la luce è pessima. ? Riporto una triste notizia di quell'anno. Voi volete provare ad aggiungere qualcosa, magari come si comportò Ferdinando II ?. VESUVIO Eruzione effusiva ed esplosiva Data : 23 agosto 1834 - 10 settembre 1834 Comuni della Provincia di Napoli interessati dall'evento : Lava tra Boscoreale ed Ottaviano. Distrutto il borgo di Caposecchi e di S. Giovanni (800 persone senzatetto). Saluti Alberto1 punto
-
Ciao a Tutti, Condivido la mia Piastra 1844, scusandomi per la scarsa qualità delle foto ( scansionata qualche anno fa ). Noto 5 pallini nello stemma del Portogallo. Ciao Beppe1 punto
Questa classifica è impostata su Roma/GMT+01:00
Lamoneta.it
La più grande comunità online di numismatica e monete. Studiosi, collezionisti e semplici appassionati si scambiano informazioni e consigli sul fantastico mondo della numismatica.
Il network
Hai bisogno di aiuto?