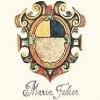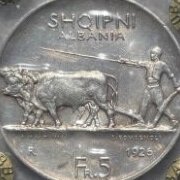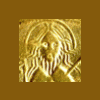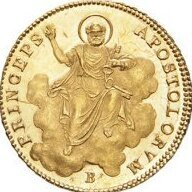Classifica
Contenuti più popolari
Elenco dei contenuti che hanno ricevuto i maggiori apprezzamenti il 02/24/24 in tutte le aree
-
Posto il mio unico (per il momento) ramino del Bombetta. 1854, 4 su 3. Uno spiccetto al quanto raro. Voi cosa ne pensate? Un saluto a tutti. Raffaele.6 punti
-
Questa mia moneta è proprio una vera moneta e non certo un notgeld, ma come classificarla dall'agosto del 1944 al giugno del 1945? Coniate a Filadelfia queste monete da 2 franchi furono utilizzate dagli alleati durante lo sbarco in Provenza nell'agosto del 1944, oltre che nel sud della Francia furono destinate per la circolazione anche in Algeria ed in Tunisia. I soldati coinvolti nello sbarco in Provenza ricevettero queste monete, pur non essendo ancora ufficializzate furono utilizzate per la spendita. Sono state regolamentate dal Ministro delle Finanze francese solo il 25 giugno 1945 e rimasero spendibili sino al settembre 1949.5 punti
-
Buongiorno, qui ha una breve carrellata su denari severiani... Se cerchi sul Forum troverai anche un contributo sulle emissioni in bronzo, argento e oro legate alla Britannia e un' analisi sulla serie di denari VICTORIAE BRIT. Saluti Illyricum 😉3 punti
-
Questi sono pezzi di profonda storia, io ho qualche biglietto ad esempio,ma definirli notgeld secondo me non sarebbe opportuno. Andrebbero incanalati nel settore dell' exonumia a mio avviso,come gettoni di pagamento alternativo,perchè il motivo non era l' emergenza per i materiali,bensì una circostanza di luogo e giurisdizione: i campi. Riccardo3 punti
-
Buonasera. Questa sera voglio condividere questo grosso di Marino Zorzi che ha governato per solo un anno dal 1311 al 1312. Pesa 2,14 grammi ed ha una conservazione che difficilmente si trova nei grossi di questo doge. Moneta molto rara, ancor di più in questa conservazione. Presenta una bellissima patina di medagliere.Cosa ne pensate?2 punti
-
2 punti
-
Avevano circolazione ed uso limitati, quindi sono più propriamente gettoni In Germania (più propriamente in Sassonia) ebbero una breve circolazione, ma poi furono coniati per l'esclusivo collezionismo. Però, questo mi arriva da ricordi tramandati indirettamente, quindi prendilo con le pinze. Ne possiedo sia la versione francese, sia quella belga; fanno parte delle tante emissioni di guerra2 punti
-
Ha ragione @Gallienus. I concetti di evo moderno (dal 1492 al 1815) ed evo contemporaneo (dal 1815 in poi) sono codificati negli studi storici. Contemporaneo significa che alcune caratteristiche fondamentali dell'epoca sono comparse dopo la rivoluzione francese e sono tuttora valide. E speriamo che lo siano ancora per molto tempo... Lo stesso vale per l'evo moderno che accomuna tre secoli con caratteristiche comuni. Arka Diligite iustitiam2 punti
-
Come sempre dai miei cassetti arrivano esemplari vissuti, ma arrivano!😁 Frànscia, Louis XVI LA NATION LA LOI LE ROI · L'AN 4 DE LA LIBERTE la nazione / la legge / il re (che poi è durato solo più un anno) Anno 4 della libertà, cioè a partire dalla rivoluzione del 1789. Njk2 punti
-
Napoli Carlo II di Spagna (1674-1700) Tari' del 1684 D/globo terrestre R/ stemma coronato2 punti
-
Rimanendo su Venezia un esempio.. La parola "erinnofilia", dall'etimologia di origine tedesca (erinnern = ricordare), si riferisce al collezionismo chiudilettera celebrativi, ossia ad un prodotto grafico che si ispira alle caratteristiche del francobollo tradizionale (formato, carta gommata, tecniche di stampa, dentellatura), con la differenza che è senza il valore facciale che è riservato solo ai valori dello Stato. Praticamente una vignetta simile ad un francobollo che non è un francobollo.2 punti
-
E questi 2 heller del campo di prigionia di Grodig secondo voi rientrano nella categoria dei notgeld?2 punti
-
Anche io ero partito con collezionare i denarii dei Severi, poi ho optato per i bronzi del IV secolo (preferenzialmente😁). Il problema e' che io collezionerei tutto! In effetti, i denarii dei Severi offrono una ampia scelta di rovesci. Come collezionare? Io all'epoca pensavo di partire con un denario per ognuno dei Severi (comprese le "Severe") per poi allargarmi sui rovesci. Poi, ognuno ha il suo modo di collezionare, anche in base alla disponibilità di spesa ed alla reperibilità dei pezzi. Direi di correggere il piccolo lapsus calami: Severi con la S maiuscola😉. Ciao. Stilicho2 punti
-
Ringrazio il CNT per l'organizzazione, i partecipanti e l'amico Tiziano @Parpajola per le foto.2 punti
-
Buonasera a tutti, ciao @gennydbmoney... dai documenti a nostra disposizione, si evince che la Zecca di Napoli coniò monete con l'effige di Francesco I a partire dal 1825 e per tutti gli anni consecutivi, fino al 30 Aprile 1831. Premetto che - ad oggi - non si conosce nessuna moneta con i millesimi 1829, 1830 e 1831 - e queste coniazioni sono indistinguibili dalle precedenti. Ora - riporto un esempio che dovrebbe essere ancora più esaustivo per poter comprendere che, quando si tratta di date di coniazione, non possiamo affatto ragionare "a rigor di logica": Anche il 15 Ducati con data 1825 - a rigor di logica - dovrebbe essere stato coniato nell'anno 1825... invece no, i documenti della Zecca ci raccontano tutt'altra storia! La coniazione delle monete in oro di 15 Ducati con data 1825, ebbe inizio il 21 Gennaio 1826 - con una prima liberata di 1.936 monete. La seconda ed ultima liberata invece, fu eseguita solo il 7 Giugno 1828 e furono coniati soltanto altri 401 esemplari. Basterebbe questo dato, per comprendere il senso del mio precedente intervento. Questo per dire che, nella Zecca di Napoli, non vigeva affatto la regola "a rigor di logica" ma, si coniava moneta eseguendo degli ordini ben precisi (Ministero delle Finanze - Decreto legge) e se in un determinato momento si necessitava di una determinata tipologia di moneta - perché ad esempio, scarseggiava nelle piazze dei mercati - allora si batteva tale moneta per favorire i pagamenti nel commercio. Un saluto, Lorenzo2 punti
-
Curiosando quà e là sulla baia cercando banconote sono incappato in diverse banconote messe in alcune buste con la dicitura verde "PMG". Cercando su internet ho visto che in poche parole fanno un servizio di perizia/valutazione di banconote di un certo pregio. Sul loro sito ho visto che hanno un sistema di valutazione che onestamente non conoscevo, il massimo è 70*EPQ (Exceptional Paper Quality). Qualcuno di voi ne aveva già sentito parlare ? Per curiosità metto il link del loro sistema di valutazione: The PMG Grading Scale1 punto
-
1 punto
-
DE GREGE EPICURI Le incrostazioni calcaree a volte sono molto tenaci e per niente facili da asportare; a parte il fatto che asportarle o meno è una decisione del proprietario. E comunque non dimostrano che la moneta è stata oggetto di uno scavo recente.1 punto
-
Ahahahah grandi scozzesi😁 E grande van der merwe. Che giocatore. Grande partita di quell' arbitro. Domani certamente forza 🇮🇹1 punto
-
grande Scozia, man of the mach con cartellino giallo......noi ci consoliamo con l'arbitro, oggi per la prima volta un arbitro italiano al sei nazioni nella gara dell'Irlanda contro il Galles. Una buona direzione di gara direi. Domani mi raccomando tutti a guardare l'Italia.......ce la possiamo fare.....1 punto
-
MONETE per RICOSTRUIRE l’Ara Pacis di Antonio Castellani | Monete di Nerone e Domiziano raccontano l’Ara Pacis voluta da Ottaviano Augusto e dal 2005 racchiusa nell’involucro progettato da Richard Meier Correva l’anno 1996 quanto a Richard Meier, noto architetto statunitense, venne affidato l’incarico di dare all’Ara Pacis, una delle testimonianze più belle della Roma imperiale, un nuovo contenitore. Nel 2005, non senza polemiche per il forte contrasto fra antico e moderno, la struttura venne inaugurata e ancora oggi fa da palcoscenico non solo per il famoso monumento ma anche ad eventi mondani, culturali e artistici. Quasi dieci anni, dunque, per passare dal progetto alla sua realizzazione; purtroppo i tempi morti, le lungaggini, le incertezze non sono solo dei nostri giorni: il complesso dell’Ara Pacis ha subito un oblio di oltre 15 secoli. Già alla fine del I secolo d.C. il complesso era fortemente danneggiato e snaturato da un incendio (80 d.C.) oltre che da un cedimento del terreno che ne avevano fatto perdere le tracce e la memoria fino al Rinascimento. L’Ara Pacis di Ottaviano Augusto nel moderno contenitore architettonico che ne rende possibile ogni anno la visita a migliaia di persone La zona era stata caratterizzata da espansione edilizia durante l’epoca dei Severi e fino al 1536 (anno in cui abbiamo la riproduzione di una parte del fregio) e al 1566 (ritrovamento di un consistente nucleo dell’altare) non se ne seppe più nulla. In realtà il monumento dedicato alla pax di Augusto era nato sotto i migliori auspici come parte di un progetto più ampio al quale partecipò anche Virgilio con la sua Eneide: dare visibilità, forma, dignità artistica e storica al nuovo assetto politico inaugurato da Ottaviano Augusto nel recupero della tradizione romana, degli eroi fondanti quella civiltà, del ripristino della pace dopo quasi un secolo di guerra civile. Dettagli dell’altare, con la porta e le sculture a bassorilievo, su un asse neroniano coniato nel 65-66 forse a Roma o forse a Lugdunum L’Ara Pacis (inaugurata il 30 gennaio del 9 a.C.), sorgeva vicino al mausoleo di Ottaviano Augusto nel Campo Marzio, un’ampia zona vicina al pomerium (uno spazio di terreno consacrato lungo le mura della città) che era stato urbanizzato da poco; in precedenza era zona di esercitazioni per la cavalleria e l’esercito e, viene fatto di pensare, non deve essere stato scelto a caso per questo tipo di monumento, dedicato alla Pace. Del complesso faceva parte, sempre nell’ambito di un disegno propagandistico e simbolico di estrema complessità e raffinatezza, anche un horologium, una meridiana che aveva come gnomone un obelisco proveniente da Heliopolis, oggi in piazza Montecitorio. Quando ci si trovò di fronte a ritrovamenti sparsi di elementi architettonici e decorativi dell’Ara Pacis molte furono le perplessità nell’assegnare figure e decorazioni ai giusti spazi originari, addirittura nel ricostruire l’architettura del tempo di Augusto. L’esterno dell’edificio progettato dall’architetto Richard Meier per contenere l’altare inaugurato nell’anno 9 d.C. e voluto da Ottaviano Augusto Tra i documenti sicuramente vanno citate le fonti scritte tra cui alcune molto famose ed autorevoli, quali Ovidio e Plinio, nonché il matematico e astronomo Facondo Novio che aveva progettato la meridiana; è comunque innegabile che tra i documenti più attendibili vadano ricordate alcune monete coniate al tempo di Nerone, che offrono la visione di come doveva essere la struttura del grande altare dedicato a quella fragile divinità, preziosa ancora oggi, che è la pace. Chi si reca nel moderno edificio progettato da Meier vede oggi una costruzione quadrangolare con due entrate, una a oriente ed una a occidente; la struttura a recinto riproduce in muratura quello che era il modello del templum minus della tradizione arcaica locale alla quale la retorica augustea fa espresso riferimento. Un altro asse in bronzo di Nerone risalente al 65-66 ci mostr l’Ara Pacis sul rovescio Questi spazi consacrati avevano un recinto in legno, erano decorati con festoni e bucrani, patere o coppe rituali; l’interno dell’Ara Pacis, molto più ampio nelle dimensione e di materiale decisamente più nobile, marmo, vuole però riprodurre la stessa struttura e lo stesso tipo di decorazione e richiama l’arcaica simbologia della vita che si rinnova, del susseguirsi delle stagioni e del pacifico e produttivo lavoro dell’uomo. Non c’è traccia, nella ricostruzione attuale, di una porta che chiudesse le due entrate al luogo sacro; troviamo però l’indicazione di questo particolare, non documentato da fonti scritte, proprio su alcune monete della seconda metà del I secolo d.C. e in particolare su nove coni a nome di Nerone ed uno da ascriversi all’impero di Domiziano, dell’86 d.C. Sul rovescio dell’asse di Domiziano vediamo la riproduzione dell’Ara Pacis che testimonia la presenza delle porte che dovevano servire a proteggere la mensa sacra. Alcuni studiosi ritengono che le porte fossero presenti fin dalla costruzione del monumento, basando la loro affermazione su scanalature osservate sul pavimento; altri pensano invece che la chiusura ad ante sia stata successiva. Anche Domiziano, nell’anno 86, fa coniare assi con l’Ara Pacis che hanno permesso agli archeologi di ricostruire dettagli mancanti del monumento E’ comunque certo che le porte esistessero e questo lo affermano indiscutibilmente le monete. Inoltre si osserva che il conio presenta anche degli acroteri di decorazione sulla cornice superiore del recinto. E’ interessante vedere anche come l’autore di uno dei coni riproduca l’Ara Pacis durante un sacrificio: al suo interno si intravedono infatti gli uomini impegnati nel sacrificio, i victimarii. Riguardo alle citate monete di Nerone va ricordato che non tutti i numismatici concordano sul fatto che l’immagine dell’edificio sia l’Ara Pacis di Roma (Mattingly e Meissonnier) e fanno riferimento a quello costruito nella località di Lugdunum all’incirca nel 65 d.C. Pur tenendo conto di questa indicazione, dal punto di vista della ricostruzione della struttura e dei particolari dell’Ara Pacis di Roma, la zecca di emissione risulta ininfluente. Si è fatto accenno al particolare delle due entrate. Sulla parete occidentale del monumento romano troviamo un pannello in cui Enea sacrifica ai Penati e uno con una scena particolarmente significativa per il recupero della mitica fondazione di Roma: Romolo e Remo allattati dalla lupa mentre Faustolo, il pastore che li adotterà, e Marte, loro padre, osservano la scena. Anche la figura della dea Roma di questo sesterzio di Nerone del 65 d.C. è stata utile per il restauro e la ricostruzione dell’Ara Pacis Sul lato orientale troviamo la scena della Tellus, la madre Terra della tradizione latina anche identificata nella figura allegorica della pax (o forse Cerere, Roma o anche Venere, la madre di Enea altrimenti “assente”). Per la lettura della figura del pannello di sinistra ci si è avvalsi ancora una volta della numismatica, in particolare della figura femminile presente su un rovescio di un sesterzio coniato a nome di Nerone nel 65 d.C. nella zecca di Roma. Molto affine è infatti la ricostruzione che venne fatta, nel 1938, della dea Roma sull’Ara Pacis alla figura femminile che troviamo sulla moneta, seduta su armi accatastate sotto di lei. La fierezza dell’espressione, l’elmo, le armi, un seno scoperto testimoniano il recupero, in età augustea, di figure legata all’epoca e alla tradizione repubblicana. https://www.cronacanumismatica.com/monete-per-ricostruire-l-ara-pacis/ Pardon, @CdC sarebbe da spostare in monete imperiali, non repubblicane. Ho fatto un errore1 punto
-
No, no, figurati! A me fa piacere chiacchierare sulle monete; e' sempre una bella occasione di confronto e di arricchimento, soprattutto per me che sono un semplice appassionato. Quanto all'entusiasmo....coltivalo! E' la molla che ti farà crescere, in ogni ambito. Chissà se il nostro @apollonia può dirci qualcosa in merito.1 punto
-
Ciao Mi associo a chi mi ha preceduto, grosso originale che soffre, oltre alla tosatura, anche un evidente salto di conio che ha confuso un po' le lettere che compongono la legenda. saluti luciano1 punto
-
Complimenti, bellissime monete, i Severi piacciono moltissimo pure a me 😃 Hanno la particolarità che non solo gli Imperatori hanno coniato moltissime monete ma pure le Imperatrici, alcune di loro donne molto influenti e vere tessitrici di trame politiche non indifferenti. Ti segnalo a questo proposito, un interessante articolo a questo link: https://www.panorama-numismatico.com/wp-content/uploads/LE-DONNE-DELLA-DINASTIA-DEI-SEVERI.pdf1 punto
-
La scomparsa Balbi de Caro è stata molto precisa nel corso di conversazioni che ebbi con lei nel definire una moneta PROOF. Aveva le idee ben chiare. Impossibile che si sia sbagliata. E si torna al punto di partenza: se la nota 56 non fu farina del suo sacco, allora posso anche concordare con chi ha sollevato dubbi sul PROOF delle lire 100 del 1940...rimane anche il dilemma della scritta PROVA su questa moneta..c'è o non c'è?1 punto
-
Buongiorno a tutti., Ciao Lorenzo, grazie mille, è sempre un piacere confrontarsi con te. Un saluto Raffaele.1 punto
-
Taiwan 10 new dollars anno 80 del calendario cinese repubblicano. Il loro calendario parte dal nostro 1912 (anno della fondazione della Repubblica di Cina), la moneta è quindi del 1991. Per ricavare la data dai simboli presenti sulla moneta: 10 x 8 = 801 punto
-
1 punto
-
Leggendo il RIC "S" sarebbe proprio un marchio di officina di Nicomedia (zecca orientale). Come già detto in post precedenti, le lettere nei campi possono variare di significato e non indicare sempre le officine (spesso indicate in esergo), anche in base al periodo storico. Su alcune monete, se non ricordo male, potrebbero anche essere segni di valore (mi vengono in mente alcuni bronzi tipo FTR). Ovviamente, sempre disponibile a correzioni ed integrazioni da chi ne sa più di me. Ciao. Stilicho PS: La tua moneta sarebbe quindi una Not in RIC proprio per l'officina1 punto
-
1 punto
-
1 punto
-
Bel denario, il rovescio mi piace moltissimo 😃 Dei Severi mi mancano ancora Settimio e Alessandro (senza contare 2 Giulie...), di Settimio mi è sempre piaciuta la particolarità della barba 🙂1 punto
-
Buona sera Mi ricorda i sigilli cilindrici di Uruk, c'era una trentina di anni fa un articolo su Le Scienze (in soffitta) presumo si possa trovare molto materiale in rete. Cordialità1 punto
-
Allo stato @ARES III, dell' oggetto in sé mi é difficile farmi una qualche idea . Sembra appoggiato in un contenitore tipo monetiere, magari con caselle 60x60 mm, e quindi piuttosto piccolo . Dal cartellino, poi, considererei che " Etruria " può avere un significato più vasto che " Etrusco " . Una buona serata1 punto
-
come già detto, basta che guardi la foto della moneta postata qualche giorno fa1 punto
-
Bella anche l' immagine del nuovo campanile, inaugurato il giorno di San Marco il 25 aprile 1912 dopo il crollo.1 punto
-
Ciao! Nulla da aggiungere a quanto scritto dai miei dotti amici; ma cosa c'entra la balaustra? Una immagine vale più di 100 spiegazioni .... balaustra del ponte dei Camerlenghi a Venezia. saluti luciano1 punto
-
L’esemplare #1 dovrebbe riferirsi al tipo CNI 116. Si potrebbe azzardare una cosa: cioè che non vi è “spazio” al R/ tra MARCVS e VENETVS. Ossia: MARCVSVENETVS1 punto
-
Soldino tipo Lando. Argento 0.398 peso tra i 0.31 e 0.60 gr. Montenegro 578, Paolucci 12 - comune1 punto
-
Per tornare alla nota, sono anch'io del parere che si sia trattato di un messaggio "parzialmente nascosto", volutamente inviato da Silvana Balbi De Caro, unica autrice dell'articolo apparso sul BdN 54 (che riporta l'anno 2010, ma fu pubblicato nel 2012) e dunque della nota 56. Chi l'ha conosciuta non può pensare che la Balbi De Caro potesse essere connivente con un sistema tecnico-politico che forse aveva la tentazione (tutta italiana) di far sparire qualche monetina (o più di qualche) ... in silenzio ... E chi ha seguito aste e vendite pubbliche non può non aver fatto caso che da quegli anni le monete d'oro incriminate si sono magicamente moltiplicate nel mercato, ed hanno ridotto il loro valore commerciale, nonostante tentativi forsennati di assorbirne l'esubero e sostenerne il prezzo da parte di alcuni importanti commercianti. E se dopo 3 anni (2009 > 2012) dei risultati della Commissione non si era ancora parlato, forse valeva la pena far trapelare la notizia dell'esistenza di quelle monete (e quali monete!) e relativo Panel incaricato di catalogarle, per una loro salvaguardia, quantunque tardiva ... E teniamo conto di quale tempo possa essere stato necessario ad un'opera di classificazione e valutazione di parecchie decine di migliaia di monete (di cui 10.000 italiane) da parte di una Commissione ristretta: se fossero state esaminate 50 monete per seduta (ed immagino che i membri della Commissione non facessero quel lavoro a tempo pieno ma, all'italiana, a "tempo perso" e senza specifiche competenze di numismatica mondiale contemporanea ) sarebbero stati necessari 200 giorni di lavoro per la sola parte delle italiane. Vorrei ricordare che le note spesso si prestano a commentare molti aspetti: il rimando iniziale può essere relativo ad un aspetto marginale, ma poi la nota sviluppa aspetti che è difficile attribuire ad un qualche autore diverso da chi la scrive. E sicuramente Cardarelli-Mantano non potevano avere idea della consistenza, numerosità e tipo delle monete contenute negli "undici barili" a meno che questi non fossero stati da loro preventivamente e senza autorizzazione esaminati (ed allora non lo avrebbero ammesso). Un'ultima osservazione sulle monete di prova "proof": credo si tratti di un problema semantico; non è detto che tutti, per quanto valenti numismatici, conoscano le sfumature terminologiche e tecniche relative a tutti i periodi di monetazione. Molte monete definite "proof" anche da periti o case d'asta, tali non sono (PROOF è una modalità produttiva delle monete che parte dalla preliminare lucidatura dei singoli tondelli prima della coniazione): in molti casi si tratta solo di monete con fondi lucidi perchè di primo conio. Credo che a questo si riferisse la SBDC relativamente alle 100 Lire 1940 prova.1 punto
-
1 punto
-
Piastra 1831 (37 mm / 27,59 g) Contorno al D/ - Provenienza: da Coll. privata / ex Artemide Aste1 punto
-
Buonasera a tutti, condivido una mia Piastra 1834 - Variante al R/ aquile capovolte - R2 (Nomisma 931 - Gigante 58g) Contorno al D/ (37,5 mm / 27,30 g).1 punto
-
Ciao Raff, interessante la tua analisi sull'evoluzione della frattura di conio che sembra effettivamente iniziare nel 26 per poi essere ancora più accentuata nel 25, quindi è plausibile( a ragion di logica) pensare che il conio del 25 possa essere stato battuto anche negli anni successivi a quello del decreto di emissione, certo,non si può affermare in che anno,ma effettivamente mi sembra giusto pensare che le piastre del 25 siamo state coniate anche successivamente,e potrebbero essere anche (perché no) state coniate negli anni in cui venivano battute le 26 o le 28... Ovviamente senza documentazione a riguardo si possono fare solo supposizioni ma a volte l'intuito e lo studio possono portare a nuove scoperte...1 punto
-
E di cosa dovresti scusarti? tutt' al più dovrei essere io a scusarmi per averti segnalato una variante che in realtà non lo è,ma si sa,chi non risica non rosica,e successo molte volte anche a me di acquistare monete con presunte varianti che poi in mano non erano tali, è il rischio in cui si incorre quando si acquista senza avere la moneta in mano,di contro succede anche che si può incappare in varianti sconosciute,e quando succede è una grande soddisfazione...1 punto
-
Buongiorno a tutti, condivido l'ultima arrivata... direttamente dal 2° convegno di Salerno, dove tra l'altro, ho avuto il piacere e l'onore di conoscere delle persone veramente squisite, di chiacchierare con alcuni dei massimi esperti della monetazione napoletana, con numismatici di lungo corso e con collezionisti tanto giovani, quanto promettenti. Piastra 1856 - variante al R/ aquile capovolte (che in Araldica è simbolo di arma diffamata, fellonia o tradimento). Un saluto, Lorenzo1 punto
-
Ciao a tutti, libro arrivato.. adoro le tavole di concordanza con Elmer, cunetio, bastian.. Sono veramente contento.. mi sembra proprio una bella edizione per quel poco che ho visto fino ad ora.1 punto
-
Ciao @stuyvesant di fatto è la tesi stampata, da quel che ho potuto vedere/leggere tra i commenti e pareri di altri forumisti francesi e inglesi appassionati del periodo. La cosa che però ha sorpreso e stupito alcuni è che in questo testo, che si attendeva da tempo, ci sono delle lacune e delle mancanze che un po' sorprendono... rimane l'impressione che per la parte relativa ad Aureolo, Mairat abbia completamente ignorato il lavoro certosino di Doyen che, pur risalendo ormai agli anni '80, rimane ancora piuttosto valido e sostanzialmente rappresenta quanto di più completo esista su queste emissioni. In più, Jerome, nonostante sia egli stesso curatore di un importante museo inglese, abbia omesso (dimenticato? ma come?) alcune rare emissioni - per esempio di Tetrico - provenienti da ripostigli e conservati in importanti musei come ad esempio questo pezzo: D\ IMP [C] TETRICVS P F AVG R\ TR [P ?III] // COS P P Acquistato nel 1972 dal British Museum (n. inventario: 0712.3), il rovescio ha un die-link con un pezzo proveniente dal ripostiglio di Irchester e conservato al Northampton Museum. Qui qualche info sul ripostiglio: Quindi che dire... indubbiamente è e rimane un'ottimo lavoro quello di Mairat, ma... la mia valutazione è che si sia persa l'occasione di fare un po' il punto della situazione raccordando gli studi inglesi agli studi francesi e tedeschi su questo periodo coinvolgendo i diversi numismatici che in questi ultimi anni si sono cimentati con la produzione di testi, studi e analisi di ripostigli. Mairat in passato provai a contattarlo, prima di trovare la sua tesi online in pdf, ma da lui non ricevetti mai risposta quindi non so come abbia affrontato la revisione del RIC, se in solitaria o coadiuvato da altri e da chi. A ogni modo so che prima o poi mi procurerò anche questa nuova versione del RIC dedicata ai gallici, se non altro per completezza di bibliografia.1 punto
-
@numa numa Sono d'accordo sulla ironia ma, mi creda, quando rileggo la storia della "nota 56" mi passa la voglia di sorridere... Sono d'accordo anche su questo poiché è fuor di dubbio che la cosa più importante sarebbe conoscere l'inventario al fine di poterlo studiare e poter tutelare al meglio l'interesse pubblico alla conservazione e alla migliore allocazione possibile dei beni: ma ciò che a noi pare ovvio a quanto pare non lo è nelle sedi deputate ad agire. Quanto ai Collezionisti mi consenta di essere antipatico: tolti pochi interessati, la gran parte degli appassionati ignora totalmente la questione (preferendo dei meri esercizi intellettuali sul quarto di punto di conservazione in più o in meno) oppure la conosce ma finge di non saperne nulla sperando che vada nel dimenticatoio senza turbare troppo lo stato attuale delle cose. Considero questi atteggiamenti frutto di ignoranza (intesa come non conoscenza frutto di scarso interesse e di scarso aggiornamento) e/o di egoismo e, pertanto, non li condivido. Vuole un esempio: non ho mai visto o letto NIP o SNI "stracciarsi le vesti" su di una questione come quella in parola con un potenziale d'interesse elevatissimo. Come sempre, ben lieto di essere smentito...1 punto
Questa classifica è impostata su Roma/GMT+01:00
Lamoneta.it
La più grande comunità online di numismatica e monete. Studiosi, collezionisti e semplici appassionati si scambiano informazioni e consigli sul fantastico mondo della numismatica.
Il network
Hai bisogno di aiuto?