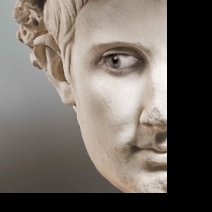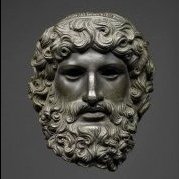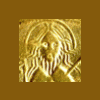Classifica
Contenuti più popolari
Elenco dei contenuti che hanno ricevuto i maggiori apprezzamenti il 10/08/24 in tutte le aree
-
Condivido con piacere la versione in argento da poco entrata in collezione.3 punti
-
Gli anni che seguirono la fine del conflitto furono difficili per molti al Nord e terribili per la maggior parte della gente del Sud, compresi gli ex "oggetti di attenzione" di entrambe le parti, ovvero gli afroamericani liberati dalla schiavitù. Anche se ora erano formalmente liberi, divennero presto un motivo di imbarazzo per i vincitori, mentre da parte dei vinti esplosero subito nei loro confronti odio e paura. Per superare tutto questo ci sarebbe voluto molto tempo, gli anni post-bellici in cui il Nord tentò di imporre le sue politiche razziali a un Sud prostrato, infine fallendo, dimostravano che il processo sarebbe stato lento e doloroso. Ma qua e là spuntava anche qualcosa di buono, l'alba di un nuovo rispetto tra le persone delle due parti e le razze: non molto, ma un inizio. E il Sud pian piano si riprese, anche se per il primo anno dovette dipendere quasi completamente dal baratto e dalle donazioni di cibo da parte del governo federale. Le sue zecche rimanevano chiuse, due, Charlotte e Dahlonega, definitivamente, New Orleans avrebbe riaperto solo nel 1879. Il sistema bancario era crollato alla fine della guerra, e le banconote confederate non avevano più alcun valore. Ma, rapidamente, sorsero nuove National Banks. Un record fu quello della First National Bank di Richmond, ex capitale della Confederazione, che ottenne l'autorizzazione ad operare il 24 aprile 1865, esattamente 22 giorni dopo che la città era stata conquistata dai nordisti! Non sono riuscito a trovare emissioni di questa banca, ne allego una di un'altra banca di Richmond, la National Bank of Virginia: 5 dollari del 1° luglio 1865... anche loro non ci avevano messo molto a ripartire petronius3 punti
-
Ciao condivido le foto di una bella moneta da 5 lire Roma, in buona conservazione (peccato per una precedente pulizia del dritto). Che ne pensate?2 punti
-
Buonasera a tutti, fuori piove, tira vento, cadon le foglie. Quale migliore occasione per rintanarsi attraverso qualche monetina "enigmatica"? Eccola. Questa moneta ha una storia particolare. Io credo di conoscerne un pezzettino, ma la scriveremo assieme. Intanto pesa 2,36 gr. A voi la parola!2 punti
-
2 punti
-
Cartolina illustrata affrancata con 1d (dime) ultramarine + 3d Deep lilac, emissione detta Wilding del 1952. Questi sono i primi francobolli con l' immagine della Regina Elisabetta II. Il valore accanto alle cifre e' con la "d" di dime, siamo infatti in periodo PRE-decimale, la Gran Bretagna adotterà il sistema decimale dal 15 febbraio 1971. Annullo meccanizzato pubblicitario o commemorativo (purtroppo non riesco a leggerlo) di Edimburgo 15 agosto 1961 4pm. Nell'immagine con lo sfondo in tartan il tipico tessuto scozzese, abbiamo l' immagine del castello di Edimburgo con i pipe bands, i tipici suonatori di cornamusa. BELLISSIMA con lieve quotazione, dopo la morte di Elisabetta II tutto il materiale filatelico di questa regina e' lievitato di valore. A me ricorda ottimi whiskies ed altrettanto ottimi tabacchi da pipa.2 punti
-
I miei talleri. Le prime 2 foto non sono un granché perché la luce non era adeguata. Le monete son meglio di come appaiono. 1595, 1595, 1601, 1603 1604, 1605, 1606, 1608 1609, 1611, 1615, 1616 1618, 1619 (variante senza croce di S. Stefano), 1619 (con baffi, data piccola), 1620 senza data 1603 (variante con corona di altro tipo), 1612, 1615 1617, 1621, senza data (variante nella legenda)2 punti
-
Direi che si tratta di Quintililo con al rovescio la rappresentazione di Marte . Guardando su OCRE ho visto come tutte le legende al rovescio, che hanno questa raffigurazione, finiscono con PACI/PACIF o altre cose simili, qui mi sembra di leggere AVG2 punti
-
Perché non glielo chiede direttamente lei alla SNI se è almeno capace di disturbarsi per questo2 punti
-
Salve. Cartolina di sughero della Sardegna. Fa parte di una serie di cartoline che raffigurano diversi costumi sardi. apollonia1 punto
-
Salve a tutti, questo è il mio primo contributo attivo al forum, dunque spero mi perdonerete per eventuali errori. Oltre alla consueta bibliografia (strettamente) numismatica, sono interessato a quei testi che possano aiutare a comprendere maggiormente il contesto di produzione e di uso di una moneta, offrendo, così, uno sguardo più ampio. Dunque vorrei che chiunque ne abbia voglia aggiunga i suoi testi, se possibile correlati da una breve descrizione, a questa discussione. Comincio io: - Leges publicae populi Romani, Giovanni Rotondi, 1912, Società editrice libraria Offre un compendio dettagliato dell'attività legislativa della Roma repubblicana, dal quale è possibile desumere importanti informazioni riguardo alle leggi finanziarie e dunque numismatiche. -Römische Kaisertabelle: Grundzüge einer römischen Kaiserchronologie, Dietmar Kienast, 1990, WBG Da questo titolo è possibile ricostruire le titolature imperiali e la loro evoluzione nel tempo (anche nel corso della vita del singolo imperatore). Questo permette, in alcuni casi, di avere una precisa collocazione temporale degli esemplari monetari.1 punto
-
Salve, ho visto che il thread è stato riportato in alto, grazie. Ne approfitto per comunicarvi che anche quest'anno svolgerò il corso nel secondo semestre, penso con orario simile a quello dello scorso anno. Se siete interessati, quando saprò le date (più avanti) e appena sarà pubblicato il programma, vi farò sapere. Comunque potrete trovare tutto sul sito web dell'Università Statale di Milano, cercando o attraverso il mio nome o con l'intitolazione del corso "Storia delle monete medievali e moderne". Ne approfitto per dire a @gpittini, che gentilmente aveva aperto il thread per lo scorso anno accademico, che quest'anno mi piacerebbe anche riprendere e sviluppare qualcuno degli argomenti accennati nella seconda parte del corso precedente e promuovere altre visite a musei o altre sedi con raccolte numismatiche, per le quali sono ben accetti suggerimenti. Inoltre tra novembre e febbraio in Statale saranno organizzati alcuni seminari, presentazioni di volumi e conferenze sul tema, che vi segnalerò appena avrò le locandine con i dettagli definitivi. Un caro saluto, MB1 punto
-
DE GREGE EPICURI Mah, a me sembra di leggere parte del nome di VICTORINUS.1 punto
-
1 punto
-
Salute cortesemente chiedo un aiuto agli esperti del settore per classificare questa Tessera mercantile fiorentina e se potete postare disegni o foto per comprendere al meglio questa tessera. Grazie a chi interverrà odjob1 punto
-
Non hai niente da farti perdonare, l' esperienza insegna.. basta l' interesse e la volontà. Ottimi acquisti.1 punto
-
1 punto
-
La destinazione non è Francoforte sul Meno in Germania (Frankfurt in inglese), ma Frankfort Illinois. (Frankfort Township è una delle 24 township nella contea di Will in Illinois) SEGUE.......1 punto
-
Classical Numismatic Group > Electronic Auction 572 Auction date: 9 October 2024 Lot number: 265 Price realized: This lot is for sale in an upcoming auction Lot description: CRETE, Aptera. Circa 250-67 BC. Æ (15mm, 2.99 g, 12h). Head of Hera right, wearing stephane / Warrior advancing left, holding spear and shield; grain ear to right. Svoronos, Numismatique 24; cf. SNG Copenhagen 332. Dark green patina, slightly soft strike. Near VF. Estimate: 100 USD1 punto
-
Qumran, località della Giordania situata in prossimità della sponda nord-occidentale del Mar Morto, nel deserto di Giudea. Dal 2° sec. a. C. al 1° d. C. fu sede della comunità religiosa ebraica (probabilmente esseni) a cui appartennero i manoscritti del Mar Morto (https://www.treccani.it/enciclopedia/qumran/) apollonia1 punto
-
Si avvicina molto ai tipi Vanni 125/126, Siena, lettera B , Bicchierna dello stato senese,1 punto
-
Cartolina illustrata affrancata con 10f commemorativo dell' emissione 18.5.1957 serie eroi della resistenza + 5f dell'emissione ordinaria del 11.11.1954 serie stemmi provinciali di Saintonge. Affrancatura annullata con meccanizzato pubblicitario di Albertville (nella Savoia) del 23 VIII 1957 ore 22. Bella cartolina rilassante della province francaise.1 punto
-
Si tratterebbe di un ibrido con conio di rovescio del fratello Claudio II (emissione 268/fine 269) https://ric.mom.fr/en/coin/206?tempRIC=&asmSelect0=&Reign=Claudius+II&asmSelect1=&asmSelect2=&asmSelect3=&asmSelect4=&asmSelect5=&asmSelect6=&asmSelect7=&Legend=VIRTVS+AVG&asmSelect8=&asmSelect9=&asmSelect10=&asmSelect11=&BustDescription=&ReverseDescription=&Note=&Reference=&page=3&hpp=5&mod=result&from=advanced1 punto
-
Oro di troppo Con la fine della guerra civile riprese anche la normale coniazione delle monete metalliche, rallentata, se non del tutto sospesa, durante il conflitto. Per la maggior parte delle denominazioni, il dopoguerra vide un aumento della produzione, almeno fino ai tempi difficili della metà degli anni 1870, quando la massiccia disoccupazione portò a un calo della domanda di nuove monete. La sola eccezione a questa regola fu rappresentata dalle double eagles, le monete d'oro di più alto valore, 20 dollari, la cui produzione addirittura crebbe in quegli anni. Questo accadde perché sembrava ci fosse una scorta infinita del biondo metallo in California, Colorado e Nevada. Quest'oro doveva essere trasformato in prodotti utili, e le double eagles erano perfette per tale scopo: ragionevolmente facili da coniare, richiedevano molto meno lavoro alle zecche che non le monete più piccole. La maggior parte di esse era coniata a San Francisco, aiutata, dopo il 1870, dalla nuova zecca di Carson City. Mentre molte monete venivano inviate all'est, altrettante rimanevano vicino ai luoghi di produzione, così che, nei fatti, stavano diventando un fastidio per i banchieri dell'area della Baia (di San Francisco) all'inizio degli anni 1870. Il conteggio e la movimentazione di così tante monete d'oro, portava via troppo tempo, era un ostacolo all'efficienza delle operazioni bancarie (avercene, di simili fastidi ). Il Congresso avrebbe potuto fare qualcosa? Ve lo dico domani petronius1 punto
-
Ha ragione, c'è gente piena di problemi, ed è tanta, che non si arrende mai e certamente non si sogna nemmeno di commettere reati. Queste persone sono solo da ammirare e sarebbe proprio doveroso che le istituzioni facessero di più per loro e, aggiungo, per tutti noi. Però la situazione è questa e non mi pare si possa essere particolarmente ottimisti, né per il miglioramento della nostra società (c'entra anche l'educazione, sempre più carente, peraltro), tantomeno per lo stato dei nostri beni culturali. Aggiungo anche che sarebbe ora che lo stato avesse un diverso atteggiamento verso i cittadini, per favorire la loro collaborazione, invece del silenzio o addirittura del furto. Vede, quante strade, quante costruzioni, quante altre cose sono state fatte distruggendo tombe, aree archeologiche e tanto altro? Certo, chi sta zitto per paura di lavori bloccati per mesi se non anni è colpevole, chi distrugge e ruba lo è ancora di più, ma ferme restando le responsabilità individuali (talora anche collettive), non pensa che qualche mea culpa e qualche cambiamento sia auspicabile anche da parte delle nostre istituzioni?1 punto
-
È un piacere! Prova con un pennellino molto piccolo intingendolo in una goccia di succo di limone e poggiandolo poi delicatamente sulla parte da trattare. Se è ostinato puoi sostituire il limone al “liquido magico”, che di certo lo elimina senza sforzo1 punto
-
Non è un aiuto mi sono solo dimenticato a scriverlo: XX° secolo.1 punto
-
Grazie mille 😊 per il tuo riscontro sempre preciso e competente. Guardando con la lente credo che lo sporco sia rimovibile, ci proverò con calma ed attenzione. Grazie ancora1 punto
-
Penso che sia un ottimo traguardo raggiunto vista la rarità (e il costo!). L’esemplare che hai scelto riflette a mio parere un ottimo rapporto prezzo/qualità, in linea con il tuo buongusto e preparazione. Come hai ben detto la pulizia è ben visibile. L’unica cosa a mio personalissimo parere più “fastidiosa” è la macchiolina che avvolge parzialmente l’orecchio e lo sporco nel pizzetto della barba (qualche sparuto residuo di sporco in alcuni interstizi della legenda e del millesimo). Qualche minima irregolarità nel bordo, ma nel complesso esemplare godibilissimo. Da vedere certamente in mano per un parere più preciso (specie per lo stato dei campi), ma da queste foto il qspl potrebbe anche starci, ma con la nota “moneta pulita”. Complimenti sinceri, pezzo ostico e costoso da inserire in collezione1 punto
-
Ciao Max! È indubbio che siano ben impressi, non afflitti da debolezze. Considerando però il contesto qualitativo della moneta a mio parere rimaniamo su questo grading. Potrebbero essere valutati mBB, ma cambierebbe poco ai fini della valutazione complessiva. Si, leggera debolezza che riguarda la parola regno (la R ha l’occhiello aperto). Son però problematiche tecniche soventi in queste tipologie. Ogni moneta ha i suoi problemi tecnici, della serie: se non è l’uno è l’altro1 punto
-
1 punto
-
Cristo santo. Se esistesse la macchina del tempo, potresti andare a fare un weekend nel 1600.1 punto
-
Come ha già detto qualcuno, quello che non mi convince proprio è il prezzo a cui viene proposta, 40 euro mi sembrano veramente troppo pochi. Va bene l’affare, ma così mi pare troppo e quindi mi puzza un po’…1 punto
-
DE GREGE EPICURI Assolutamente d'accordo con @Vietmimin: su una moneta dell'impero (seppure in area balcanica) non si sarebbe mai alluso ad attriti o discordie nella famiglia imperiale. A parte il fatto che, considerando le date, qui si sarebbe trattato di capricci fra due bambini... Quanto al significato del rovescio, in effetti le ipotesi possono essere molte, ma vanno tutte inquadrate nella cultura e nei miti locali, quelli di Nicopoli. Io credo che il senso più probabile sia l'alternanza fra il giorno e la notte, insomma il susseguirsi della luce (il gallo fa chicchiricchì per annunciare l'alba) e delle tenebre, rappresentate dal serpente. Mi fa venire in mente (ma è solo una associazione) il mosaico sul pavimento della basilica di Aquileia, dove però si fronteggiano un gallo e una tartaruga.1 punto
-
in questo punto perlinatura e bordo non mi convincono affatto.. c'è anche poco dislivello con il campo1 punto
-
Come ho avuto modo di scrivere già in un’altra discussione riguardante il 20 lire littore, questa indicazione del range del peso è errata. Il limite di tolleranza è di 5 millesimi di grammo per ogni grammo. Quindi, considerando i 15 grammi del peso della moneta, il range è tra 14,925 e 15,075 grammi. Purtroppo, in passato qualcuno ha sbagliato con gli zeri (750 milligrammi anziché i corretti 75) e questo errore continua a ripetersi ancora oggi… P.S. Ovviamente, si parla del peso di esemplari che non presentano usura. Quelle oscillazioni di peso sono quelle tollerate per quanto riguarda monete emesse dalla zecca.1 punto
-
La ringrazio per l'attenzione, ma forse il mio modesto intervento non è stato così chiaro, come credevo. Mi sembrava infatti di avere specificato che tutto il malaffare sia sempre da perseguire, lo ribadisco ora comunque. Vede, l'accenno sulle problematiche sociali ed economiche di alcune zone del paese può eventualmente spiegare il perché tanti soggetti si dedichino al traffico clandestino, ma tutto ciò non potrà mai giustificare e tantomeno assolvere i responsabili, almeno dal mio punto di vista di umile commentatore. Semmai, oltre alla giusta repressione, bisognerebbe operare al fine di sostenere l'economia locale (e legale) e dare alle persone alternative concrete per vivere. Caro signore, se non c'è lavoro e la gente non riesce a mangiare è più facile che possa commettere reati per sostentarsi, non crede?1 punto
-
No, guardi ... Nella polemica non La seguo giacché questa discussione non merita di essere rovinata con le Sue chiacchiere e con il rischio che io ne faccia a mia volta. A proposito di "fatti", attendo ancora di sapere - Suo cortese tramite - cosa ha fatto la SNI per la Nota 56.1 punto
-
1 punto
-
@gpittini questo e altri punti verranno visti durante la conferenza, anche se per vederli veramente bene non basterebbero tre conferenze!! Per il momento "accontentatevi" di un'altro 8 reales con data 1663, anche questa moneta con tutti i dati ben leggibili.1 punto
-
Sulla storia,diffusione ed evoluzione del tallero ecco un ottimo libro che può deliziare ancor più il palato del collezionista desideroso di approfondire a livelli più ampi la sapienza storico-monetaria che si cela dietro le monete acquisite...1 punto
-
Omaggio al Patrono d'Italia Pietro Cavaro ( 1550 ) San Francesco riceve le Stimmate Oristano - Monastero di San Francesco1 punto
-
DE GREGE EPICURI Ci sono molte discussioni nel Forum sul trattamento del cancro del bronzo (principalmente con benzotriazolo, dopo pulitura a fondo). Ma questa mi pare quasi incurabile...1 punto
-
Buona Sera concordo con l'intervento dell'utente cippiri76, indico i riferimenti al lavoro del dott De Benetti che sono la posizione 234 del pdf o la pagina 227 del testo. Aggingo qualche considerazione. Il “nuovo piede” si presenta per la prima volta con il Fiorino MIR 5-20 (segno “Monte tra i monti” diverso da quello indicato erroneamente nelle tavole) successivo a MIR 5-19 (segno giglio “piccolo”) dove il punzone si “rompe” e viene sostituito. Da notare come il Fiorino MIR 5-2 (segno Aratro ( o Barca)) sia catalogato in modo errato (presenta stesso piede “nuovo” e in alcuni coni sia il bottone sul petto che il bisante sotto la croce sono scavati). La posizione dei pendenti (sepali) può essere fuorviante, ha valore in media a livello statistico, esistono una infinità di casi particolari discordanti. Molte caratteristiche non sono “stabili”, possono talvolta riemergere sporadicamente particolari anacronistici. Per quanto riguarda il tipo b del Fiorino MIR 6-1 (segno corna di cervo) si tratta a mio parere solo di un conio malriuscito, se dovessimo classificare individualmente ogni conio, presumo dovremmo considerare un numero spropositato di varianti, quelle considerate dal Bernocchi sarebbero solo un punto di partenza. Per continuare, in base a quali criteri un Fiorino (o comunque una qualunque moneta) diventa una nuova tipologia? Vorrei puntualizzare come molte volte non sia agevole, ai fini della determinazione delle varianti, neppure stabilire la posizione (alta, centrale o bassa) dei bisanti di interpunzione delle legende. Se da una parte il livello di dettaglio si spinge al singolo conio, la tipologia deve considerare i caratteri distintivi generali. I due approcci hanno metodi e finalità diverse, e diverse sono le informazioni e le valutazioni che ne derivano. Cordialità Un ultimo appunto, data la difficoltà di accesso, anche solo alle immagini delle monete delle collezioni pubbliche, sarebbe opportuno allegare immagini esplicative per facilitare la comprensione. Allego l’immagine del possibile Fiorino tipo b, dall’asta Numismatica Picena 13 lotto 68. Ne sono passati anche altri in asta. Chiaramente non conoscendo i riferimenti citati si tratta di una ipotesi. Ulteriore ultima annotazione, se il Fiorino indicato è effettivamente quello mostrato, devo puntualizzare che esistono esempi di maggiore difformità che comunque, a mio parere, non sono un tipo diverso.1 punto
-
sarebbe metà croce porta reliquie, circa anno 1000. questa è la mia. Madonna con Bambino.1 punto
-
Allora, in attesa dell’esito dell’esemplare Aurora: Gritti Nomisma 70 1.500 euro (ok) Gritti Nomisma 71 : invenduto1 punto
-
Di seguito, tre esemplare che saranno esitati nei prossimi giorni/settimane. Lotto 74 - Asta Nomisma 70 31/8/2024 COLLEZIONE A.S. VENEZIA Andrea Gritti (1523-1538) Scudo d'oro - Pa. 3 AU (g 3,38) Esemplare eccezionale - FDC https://nomisma.bidinside.com/it/lot/629749/collezione-as-venezia-andrea-gritti-1523-1538-/ Lotto 893 - Asta Nomisma 71 1/9/2024 VENEZIA Andrea Gritti (1523-1532) Mezzo scudo d'oro - Pa. 4 AU (g 1,58) RRR Leggere traccie da montatura Grading/Stato: BB https://nomisma.bidinside.com/it/lot/630568/venezia-andrea-gritti-1523-1532-mezzo-scudo-/ Lotto 233 - Asta Aurora 32 9/10/2024 Venezia, Andrea Gritti (1523-1538) Mezzo Scudo d'oro, Rara Au 18 mm 1,70 g, di alta qualità per questo nominale, in Slab NGC MS64 Top Pop! (cert. 2789370008) https://auctions.aurora.sm/it/lot/14923/venezia-andrea-gritti-1523-1538-mezzo-scudo-/1 punto
-
1 punto
-
Salve a tutti. Quest’oggi volevo proporvi una nuova discussione “trasversale”, dato che l’argomento di cui andremo a trattare ci permetterà di spaziare in situazioni storiche e numismatiche dal Mezzogiorno al Settentrione della nostra penisola. Anche questa volta, al centro del nostro dibattito troviamo un sovrano napoletano della dinastia francese degli Angioini, Roberto d’Angiò (1309-1343), autore di una coniazione molto particolare ed estremamente rara che merita di sicuro un approfondimento. Ecco la descrizione del pezzo in esame: Gigliato. D/ + ROBERTUS • DEI GRA IERLM • ET SICIL • REX Robertus Dei gratia Ierusalem et Siciliae Rex. Roberto, per la grazia di Dio, Re di Sicilia e Gerusalemme. Il Re coronato, seduto frontalmente su di un trono con protomi leonine ai lati, tiene nella mano destra lo scettro gigliato e nella sinistra il globo crucigero. R/ + IPPETUU CU SUCCESSOIB DNS TRE PRATI In perpetuum cum successoribus dominus Terrae Prati. Signore in perpetuo della Terra di Prato con i suoi eredi. Croce piana ornata, con le estremità fogliate, accantonata da quattro gigli. CNI XI, p. 345, n° 1 (tav. XXII, n° 4). AR 3,90 g. e 27 mm. (esemplare della Collezione Reale, già ex Collezione Gnecchi, n° 3515). Un altro esempio trovato in rete, dal peso dichiarato di 3,78 g.: Si sa benissimo oramai che il gigliato fu una moneta ampiamente accettata in molti luoghi diversi tra loro, non solo d’Italia, ma anche d’Europa e addirittura fu imitata e scambiata nelle zecche e negli Stati dell’Oriente Latino. Tale fama scaturisce dalla bontà della lega utilizzata per la coniazione di queste monete, molto più ricca di fino rispetto ad altri nominali, non solo italiani, che si potevano trovare in circolazione all’epoca. Era, se vogliamo, una specie di “dollaro” d’argento del Basso Medioevo, utilizzato per i commerci locali nel Regno di Napoli, ma anche per quelli di più vasta portata, tant’è che si sviluppò un vero e proprio giro d’affari intorno all’imitazione del gigliato napoletano o robertino, come veniva chiamato per via del sovrano che lo fece diventare così celebre e ben accetto. Non ci si sorprende, quindi, di trovare una moltitudine di gigliati che si differenziano anche molto da quelli coniati a Napoli durante il regno di Roberto d’Angiò, ma il gigliato “pratese” ha avuto sempre un ruolo molto particolare nella numismatica non solo napoletana, ma italiana in generale, per via della sua esimia rarità, ma soprattutto per i risvolti storici che tale moneta potrebbe rivelare. E allora è il caso di vedere meglio le circostanze storiche che portarono alla realizzazione di questo strano pezzo. Innanzi tutto occorre spiegare perché la definizione di “pratese”. La caratteristica peculiare risiede proprio nella legenda di rovescio, ampiamente sciolta e tradotta in fase di descrizione. In pratica, Roberto d’Angiò, oltre che Re di Napoli, veniva riconosciuto anche come signore della Terra di Prato, la città toscana in provincia di Firenze. Il privilegio signorile si estendeva anche ai suoi eredi, quindi, dopo la morte del sovrano angioino, i suoi successori avrebbero beneficiato della signoria di Prato. Come si configura storicamente un tale potere? Come arrivò Roberto d’Angiò a detenere i diritti su città così lontane da Napoli e dal suo Regno, coinvolte in ben altre realtà politiche? E, soprattutto, come si giunse alla coniazione di una moneta, il gigliato, appunto, che per stile e standard ponderale rientra perfettamente nei meccanismi economici napoletani, ma che è di più difficile inserimento in quelli toscani? Dobbiamo pensare ad un’Italia divisa tra due principali fazioni: i Guelfi, sostenitori del partito filo-papale, e i Ghibellini, favorevoli invece nel riconoscere all’Imperatore di Germania un potere temporale superiore a quello della Chiesa di Roma. L’autorità imperiale, inoltre, voleva anche consolidare la propria influenza in Italia, ormai solo un ricordo rispetto a ciò che era stata nel corso del XIII secolo o anche prima. Gli scontri tra le diverse fazioni nelle città dell’Italia settentrionale portarono i liberi comuni ad indebolirsi per i dissidi e le divisioni interne: sia Firenze che le città limitrofe della Toscana, infatti, erano molto deboli militarmente e non riuscivano a fare fronte alle esigenze belliche che il tempo imponeva. Tra il 1305 ed il 1310, quindi, Roberto d’Angiò, uno dei sovrani più potenti d’Italia, era stato coinvolto nelle lotte politiche toscane e si schierò dalla parte dei Guelfi: il Re di Napoli, infatti, già nel 1305, quando era solamente Duca di Calabria, fu insignito della signoria di Firenze, che mantenne pressappoco fino al 1321, e messo a capo di una lega di città toscane che si opponevano al potere ghibellino ed imperiale in Italia. Prato, la cui situazione militare non era molto diversa da quella della vicina Firenze, aveva vissuto anni migliori dopo che, alla metà del XIII secolo, si era fissato lo Statuto cittadino e il centro aveva riconosciuto la propria qualifica di libero comune. La floridezza economica di quei tempi, dovuta al grande sviluppo dell’industria della lana, era solo un lontano ricordo. Dal 1312 la situazione peggiorò ulteriormente a seguito delle guerre intestine che affliggevano le città toscane: Prato, insieme alla lega di città che facevano capo a Firenze, composta da Siena, Pistoia, Arezzo, Volterra, Colle Val d’Elsa, San Gimignano e San Miniato, si trovò contrapposta alla Pisa di Uguccione della Faggiola, condottiero ghibellino e vicario imperiale in Italia. Uguccione si rivelò una minaccia concreta per i Fiorentini i loro alleati nel 1315, quando le armate ghibelline collezionavano sempre più successi sui nemici di parte guelfa. Fu proprio in quell’anno (tra l’altro, passato alla storia come il più fulgido per il partito ghibellino in Italia) che Firenze si decise a chiedere aiuto militare a Re Roberto. Quest’ultimo acconsentì, radunando in breve tempo un congruo numero di truppe che, inizialmente, dovevano essere guidate da suo figlio, nonché erede al trono, Carlo d’Angiò (1298-1328), Duca di Calabria dal 1309 e Vicario Generale del Regno. Il comando, però, passò poi all’ultimo momento nelle mani del fratello del Re, Filippo I di Taranto (1294-1332). La colonna partì dunque per Firenze per unirsi al resto dell’esercito guelfo che la lega toscana aveva raccolto per far fronte alla minaccia ghibellina. Lo scontro sembrava giocare a favore dei Fiorentini e dei loro alleati napoletani, vista la loro superiorità numerica. Uguccione, oltre ai Pisani, poteva fare solo scarso affidamento su Lucca, perché questa città era stata presa dai Ghibellini con la forza. Il confronto armato non si fece attendere: la battaglia di Montecatini (29 agosto 1315) sancì la gloriosa vittoria dei Pisani di Uguccione che, contro ogni pronostico, misero in fuga i Fiorentini con i loro alleati. Il comandante napoletano Filippo di Taranto neanche prese parte allo scontro perché, colto da febbre, fu costretto a ritirarsi dal campo di battaglia e a rientrare precipitosamente a Firenze, la cui situazione peggiorava giorno dopo giorno. Roberto d’Angiò, da parte sua, non si mostrò molto preoccupato della sconfitta subita dalle sue truppe in Toscana: Firenze, che dal 1305 si era costituita sotto la sua protezione, rimaneva, con il suo circondario, ancora salda e sicura. Qualche anno dopo, però, tale sicurezza crollò: nel 1325 il baricentro ghibellino da Pisa si era spostato a Lucca che, sotto il suo signore Castruccio Castracani, aveva riscoperto un nuovo periodo di riscossa militare, culminato con la vittoriosa (per i Ghibellini) battaglia di Altopascio il 23 settembre di quello stesso anno. Questa volta, Roberto non aveva inviato alcun aiuto contro il Castracani per favorire i Fiorentini, così, quando questi arrivò addirittura a minacciare la città stessa, essi si rivolsero al Duca di Calabria, Carlo, figlio di Re Roberto, il quale fu eletto dai Guelfi nuovo signore di Firenze a garanzia della protezione angioina sulla città. Carlo accettò e l’anno successivo, nel 1326, il 13 gennaio, si recò a Firenze per prendere possesso del nuovo incarico che gli era stato offerto. Ma la permanenza di Carlo e del suo seguito di Angioini nel capoluogo toscano fu breve: nel 1327, il Duca fu richiamato a Napoli, poiché le truppe tedesche di Ludovico IV il Bavaro (1328-1347), allora Rex Romanorum (1314-1328), minacciavano il Regno nella loro discesa in Italia verso Roma. Si ritiene che il gigliato “pratese” fosse stato battuto intorno al 1326, quindi durante la signoria fiorentina di Carlo d’Angiò, per l’infeudamento di Prato alla casata angioina. Le legende sulla moneta, che vanno lette in modo continuo tra diritto e rovescio, comunicherebbero che Roberto d’Angiò, già Re di Napoli, era anche signore (dominus) di Prato e che il privilegio si estendeva anche ai suoi successori, cioè a Carlo Duca di Calabria. Quest’ultimo, nato dal matrimonio celebrato il 23 marzo 1297 tra Roberto e Jolanda d’Aragona (1273-1302), era l’unico figlio maschio della coppia reale e, nel 1316, contrasse una prima unione, infruttuosa, con Caterina d’Asburgo (1295-1323). Nel 1324, poi, prima di essere chiamato dai Guelfi a Firenze, Carlo sposò in seconde nozze la giovanissima Maria di Valois (1309-1332), dalla quale ebbe la figlia, futura Regina di Napoli, Giovanna I d’Angiò (1343-1381). Appena Carlo si allontanò da Firenze nel 1327, Castruccio ne approfittò per occupare molte città che prima erano cadute sotto la giurisdizione feudale angioina: in nome dell’Imperatore tedesco, il condottiero ghibellino, divenuto intanto Duca di Lucca, arrivò ad attaccare anche Pistoia e Prato. Gli abitanti di questi due centri, soprattutto i contadini che erano quelli più esposti alle scorribande ghibelline nelle campagne intorno alle città, per non subire gli attacchi nemici, scesero a patti con il Castracani: in cambio di un tributo semestrale da pagarsi in denari, i Pistoiesi ed i Pratesi evitarono attacchi e saccheggi da parte dei Ghibellini del condottiero lucchese. In realtà, fino a quando gli Angioini si ersero a garanti della sicurezza dei Guelfi toscani, Firenze e gli altri centri toscani limitrofi non subirono mai il sopravvento della parte ghibellina avversa. Il gigliato “pratese”, dunque, costituisce una moneta commemorativa (e non una medaglia, come credeva Arthur Sambon e com’è riportato anche nel CNI XI) che aveva lo scopo di manifestare la sovranità signorile degli Angioini, di Roberto e di suo figlio Carlo, sui centri guelfi toscani minacciati dall’inarrestabile potenza militare ghibellina. Si potrebbe anche pensare che la moneta circolasse nel ristretto entourage del Duca di Calabria e che difficilmente abbia interagito con la moneta e l’economia locale fiorentina, poiché, come faceva già notare il Sambon, il gigliato era sì una moneta ben accetta all’epoca (quindi magari sarà anche stata accettata in alcune transazioni tra Angioini e Fiorentini), ma era profondamente diversa per caratteristiche fisiche rispetto al sistema monetario ed economico fiorentino. Dobbiamo poi pensare che Prato patteggiò un accordo per non essere occupata dai Ghibellini di Castruccio solo nel 1327, ovvero dopo la partenza di Carlo d’Angiò da Firenze. Dato che Prato non ebbe mai una propria zecca, sembrerebbe più logico ipotizzare che il gigliato in questione fu coniato nel 1326 a Firenze, durante il breve soggiorno del Duca di Calabria in città. Forse la sua breve permanenza e il circoscritto utilizzo del gigliato “pratese”, in unione con lo scopo commemorativo dell’emissione, non consentirono la coniazione di un gran numero di pezzi, anzi, ne frenarono la produzione allo stretto indispensabile per le esigenze degli Angioini, padroni della scena politica cittadina. Dobbiamo poi notare che questa teoria non sembra priva di fondamento, se pensiamo che, a Napoli, la locale zecca incrementò la produzione di gigliati, per volere regio, proprio nel 1326! In questo anno, infatti, furono assunti nuovi manovali in zecca per la lavorazione delle monete d’argento, in vista del successo e delle attenzioni che il gigliato napoletano stava ricevendo in molte parti d’Europa e del Mediterraneo. Ma non furono solo gli Angioini ad aiutare militarmente i Guelfi toscani e ad importare a Firenze il gigliato “pratese” di stampo e peso napoletani: sotto Roberto d’Angiò, le finanze del Regno di Napoli erano quasi monopolizzate da potenti banchieri fiorentini. Pensiamo che molte Compagnie bancarie avevano filiali a Napoli che costituivano il fulcro di importanti guadagni. Proprio con il governo di Roberto assistiamo spessissimo all’affidamento dell’incarico di Maestro di Zecca, ufficio fondamentale per la gestione della stessa, ad esponenti di queste potenti Compagnie. Tra questi ricordiamo: 1. Lapo di Giovanni di Benincasa, un mercante fiorentino, fattore della Compagnia degli Acciaiuoli, fu Maestro di Zecca nel 1317. Fu proprio tra il 1317 ed il 1319 che si decise di inserire sui gigliati dei simboli per poter distinguere l’operato delle diverse maestranze, poiché in molti casi si erano verificati dei cali nel peso effettivo delle monete rispetto a quello teorico stabilito (pari quasi a 4 grammi). 2. Donato degli Acciaiuoli, Maestro di Zecca nel 1324 (al 12 febbraio si data l’appalto per il suo incarico), proseguì la battitura dei gigliati di peso accurato, com’era già stato fatto sotto l’amministrazione dei suoi predecessori, Rainaldo Gattola, di Napoli, e Silvestro Manicella, di Isernia. 3. Petruccio di Siena, Maestro di Zecca nel 1325, anch’egli esponente della Compagnia degli Acciaiuoli. 4. Domenico di Firenze, Maestro di Zecca sempre nel 1325, esponente della Compagnia degli Acciaiuoli. 5. Dopo l’intermezzo del napoletano Rogerio Macedonio, nel 1327, a dirigere la Zecca partenopea troviamo nuovamente un fiorentino, un certo Filippo Rogerio, della Compagnia dei Bardi. 6. Pieruccio di Giovanni, ugualmente fiorentino, fu Maestro di Zecca dopo il 1327 ed esponente della Compagnia degli Acciaiuoli. 7. Sempre in una data posteriore al 1327 a capo della Zecca viene annoverato il fiorentino Matteo Villani, della Compagnia dei Bonaccorsi. Tutte queste Compagnie bancarie fiorentine avevano, attraverso il controllo dell’ufficio di Maestro di Zecca, oltre a rapporti commerciali di favore tra Firenze ed il Regno, anche il sopravvento sulla gestione della moneta regnicola e sulla sua circolazione. I Bardi, presso la cui filiale di Napoli lavorò anche il padre di Boccaccio, gli Acciaiuoli e i Bonaccorsi, insieme ad altre Compagnie fiorentine, fallirono a seguito del mancato saldo del debito che i Re si Francia ed Inghilterra avevano contratto con i Fiorentini a seguito dell’allestimento degli eserciti per la Guerra dei Cent’anni. Anche Roberto d’Angiò aveva un grande debito con gli Acciaiuoli, che di fatto erano i banchieri della Casa d’Angiò e tenevano in mano le finanze di mezza Napoli, in quanto questi ricevette un primo prestito di ben 50.000 fiorini d’oro e suo figlio Carlo, Duca di Calabria, beneficiò di un secondo prestito pari a 18.500 fiorini. Dopo la mancata restituzione delle somme dovute dai sovrani francese ed inglese, Roberto non saldò il suo di debito usando come precedenti le insolvenze degli altri due Re, Filippo VI ed Edoardo III. Ma gli Acciaiuoli beneficiarono grandemente della benevolenza regia: sotto Roberto, Niccolò Acciaiuoli fu nominato prima cavaliere e con l’avvento di sua nipote, Giovanna I, fu invece creato, nel 1348, Gran Siniscalco del Regno. Fu proprio Niccolò a farsi promotore del (secondo per la sovrana) matrimonio tra Giovanna I e Luigi di Taranto (1352-1362). Quando questi morì, il 26 maggio del 1362, l’Acciaiuoli fu il principale protettore dei diritti della Regina angioina (a cui, tra l’altro, doveva tutte le sue fortune) quando altri nobili ne minavano il potere. Ma, ritornando in Toscana, Prato rimase ancora per poco tempo in mano angioina: morto Roberto a Napoli, il 16 gennaio 1343, (Carlo era già morto il 9 novembre 1328) Firenze tentò, a partire dal 1350, di conquistare con la forza la città vicina, vedendo la morsa angioina allentarsi dai comuni toscani come un’occasione di rinascita politica. Nel 1351, con un atto cancelleresco approvato da Giovanna I, la Corona di Napoli cedeva i diritti feudali di Prato a Firenze dietro pagamento di una somma ammontante a circa 17.500 fiorini. Anche dietro questo atto si nasconde un disegno politico di Niccolò Acciaiuoli che, in virtù della propria influenza sulla Regina napoletana, spinse la sovrana a concludere un accordo remunerativo con Firenze. Da allora, la città di Prato non è mai uscita più dall’orbita fiorentina.1 punto
Questa classifica è impostata su Roma/GMT+01:00
Lamoneta.it
La più grande comunità online di numismatica e monete. Studiosi, collezionisti e semplici appassionati si scambiano informazioni e consigli sul fantastico mondo della numismatica.
Il network
Hai bisogno di aiuto?




.thumb.jpg.49bf7893ab8deb0b9efbfc02c41b7421.jpg)