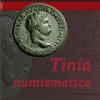Classifica
Contenuti più popolari
Elenco dei contenuti che hanno ricevuto i maggiori apprezzamenti il 04/19/25 in tutte le aree
-
Cari amici un post anzitutto per augurare serene festività Pasquali a tutti. Qui nel bel Chianti piove continuamente, e fa anche freddino per la stagione ma insomma, cerchiamo di essere ugualmente felici. Detto ciò oggi - dopo molte riflessioni - mi sono convinto che togliere le monete dagli slab, purtroppo, è in fondo una gran fesseria. Ne ho distrutto alcuni in passato perché inizialmente proprio non li sopportavo, ma ora mi fermo e sono costretto ad ammettere che (a) occorre conservarli se si ha occasione di acquistare monete ivi contenute e (b) mi rammarico di aver tolto dai sarcofagi alcune monete slabbate acquistate negli anni passati. Come scriveva qualche giorno fa l’amico @odjob si tratta di una pratica commerciale ereditata dagli USA che può essere odiata (a me tuttora non piace) ma non c’è nulla da fare, se un giorno vuoi alienare la collezione (o anche lasciarla ai figli) ai pezzi importanti la presenza degli slab ne aumenta l’appeal commerciale. Proprio oggi ho ritirato a San Marino due importanti invenduti dell’asta 72 (che a breve condividerò) ed ho acquistato una scatola porta slab della ditta Zecchi di Firenze, che è un po’ il top di gamma per gli accessori numismatici. Potete vedere l’articolo sul loro sito ma comunque quando mi arriverà ve lo mostrerò. Può contenere fino a 13 slab e spero di dover presto acquistarne un altra 😁 Auguri a tutti voi e alle Vostre famiglie3 punti
-
Caro Massimo, non sono del tutto d'accordo. Lo slab è utile se non puoi vedere direttamente la moneta, perché comunque ti indirizza sulla conservazione. Se la vedi, però, lo slab ti impedisce di giudicarla adeguatamente. Tra i motivi che mi fanno dubitare degli slab vi sono: l'abitudine da qualche tempo da parte dei titolari di Case d'Asta, di aprirli (liberando la moneta) quando il giudizio non soddisfa (per cui, dal punto di vista della statistica, gli slab indicano in media una conservazione superiore a quella effettiva), l'imperizia degli slabbatori nel giudicare le monete nostrane, il conflitto d'interesse tra graduatori e committenti (esistono grandi Case d'Asta che slabbano tutto e pagano di conseguenza, e nessuno mi toglie dalla mente che vengano trattate con "estremo riguardo" rispetto alle conservazioni proposte), l'esclusione di alcuni difetti dal giudizio (bordo e contorno): io li apro e valuto di persona. Lo faccio sempre e non mi interessa se ciò condiziona (certamente) l'eventuale ritorno economico: graffietti, hairlines, colpi e colpetti, patine artefatte, peso calante ... sono alcune tra le sorprese non gradite che si ritrovano poi. Attualmente, inoltre, non acquisto più monete poste di sbiego nello slab, perchè malizia di chi "perizia" è quella di nascondere sotto le alette di bloccaggio i difetti di bordo e contorno (che ovviamente sono solo casualmente perpendicolari agli assi principali di una moneta). E' un po' quello su cui ci si interroga rispetto ai tradimenti coniugali: è meglio vivere cornuti e felici ignorando, o sapere e soffrire? Io preferisco conoscere la verità. Le monete della mia collezione provenienti dalle recenti aste sammarinesi sono ormai senza slab ... Auguri a tutti di Buona Pasqua!3 punti
-
Un'aquila nel cielo La prima aquila in volo su una moneta americana. Accadde nel 1836, e la moneta, dopo oltre 30 anni, era un dollaro d'argento Per la prima volta compariva sulle monete americane una "vera aquila", ossia disegnata basandosi sull'osservazione dell'animale in natura, e non su sculture della tradizione coloniale o sull'araldica. La leggenda dice che il disegnatore, Titian Peale, abbia voluto ritrarre Peter, l'aquila della Zecca di Philadelphia che già conosciamo. In realtà non è chiaro se Peale abbia potuto studiare Peter in volo dal vivo, o abbia visto soltanto il suo corpo imbalsamato, o ancora, come sostengono alcuni, non abbia fatto né l'uno né l'altro, ispirandosi invece ai disegni di alcuni naturalisti, tra cui il famoso ornitologo John James Audubon. A contornare l'aquila, nel "cielo" della moneta, compaiono 26 stelle, a simboleggiare gli Stati che all'epoca facevano parte dell'Unione. Ma solo nella monete del 1836, in quelle del 1838/39 le stelle spariscono, per trasferirsi, in numero di 13, nel giro del dritto. Un dritto che presentava anch'esso un'assoluta novità. Per la prima volta di Lady Liberty non comparivano più solo la testa o il busto, ma era a figura intera, e perdipiù seduta. Sembra che il disegnatore, Thomas Sully, si sia ispirato alla figura allegorica della Britannia, che compariva sulle monete inglesi. Quel che è certo è che questa raffigurazione ha goduto di grande fortuna, comparendo da allora in poi, con diverse varianti, su tutte le monete d'argento fino ai primi anni 1890, quando fu sostituita dai disegni di Charles Barber. Non altrettanta fortuna ebbe il rovescio. Il disegno dell'aquila, nella mia opinione, nella versione con le stelle, il più bello di sempre, fu abbandonato dopo soli tre anni e meno di 2000 monete coniate. A causa della bassissima tiratura, questi dollari furono considerati a lungo alla stregua di "pattern coins", monete di prova mai entrate in circolazione, ma il ritrovamento sempre piú frequente di esemplari con evidenti segni di usura, e un piú attento esame dei registri della Zecca dell'epoca, hanno infine portato gli studiosi a ritenere che i dollari del 1836 e 1839 abbiano effettivamente, almeno in parte, circolato, mentre quelli del 1838 sono indubbiamente semplici "patterns". (foto da PCGS, conservazione stimata PR61) L'incisore dei dollari fu Christian Gobrecht, che si firmò per esteso alla base di Lady Liberty, dove compare l'iscrizione C. GOBRECHT F. (Christian Gobrecht Fecit). E da lui hanno preso il nome. E di lui ci occuperemo in maniera più approfondita nel prossimo post... e poi, naturalmente, delle sue monete d'oro petronius3 punti
-
3 punti
-
Un "ci metto la faccia" in maniera abusiva... Napoli. Filippo III, mezzo scudo 1617. Ex asta NAC 85, lotto 151. All'apparenza tutto normale... ma ruotando il D/. Ecco apparire nel taglio del busto del sovrano quello che alcuni studiosi indicano come il profilo del duca di Osuna Pedro Téllez-Girón y Guzmán, vicerè a Napoli che sembra non abbia resistito a farsi immortalare su di una moneta. Realtà o pareidolia?3 punti
-
Senza i dati metrici quali peso e diametro non è facile rispondere. Provo ad esprimere la mia opinione. Prima di tutto va detto che il 2 carlini indicato nel catalogo Sambon è da riferirsi al 15 grana. Moneta in argento simile a quella descritta con un peso teorico di circa 4.99 gr. La descrizione tuttavia, in particolare quel "ramoscelli" la identifica in maniera obiettiva in quanto è noto che nel 15 grana la croce è cantonata da fiamme. Si potrebbe però, giustamente, obiettare che si tratti di una variante. Una variante del 15 grana riportata in seguito nell'opera del Cagiati (p. 243, nr. 31) con le stesse caratteristiche indicate nella moneta ex coll. Sambon, ramoscelli compresi, (nel disegno del Cagiati in realtà, anche se indicata, manca la N del coniatore). Anche in questo caso non sono indicati peso e diametro ma viene indicata la fonte nella collezione del prof. dell'Erba. Nella "Riforma monetaria Angioina..." proprio Luigi dell'Erba riporta la rarissima moneta con la croce cantonata da ramoscelli come 15 grana senza indicazioni di peso e diametro. Il passo successivo è lo studio del Bovi sulla monetazione di Filippo IV pubblicato sul BCNN del 1965-1966. Il Bovi documenta che il tarì di Filippo IV debba avere un giusto peso pari a gr. 5.92, quindi la sua metà, il carlino, dovrebbe avere un peso pari a 2.96 gr. Al nr. 122 di tale studio viene riportata la moneta sotto esame e, finalmente ne viene indicato il peso: 2.98 gr. con un diametro pari a 19 mm e l'appartenenza alla collezione Catemario. Nella descrizione la croce è indicata come cantonata da fiamme, ma nell'immagine delle tavole quelle fiamme sembrano effettivamente dei ramoscelli. Per il Bovi la moneta è indubbiamente un carlino. Stessa cosa per Pannuti/Riccio che, riferendosi proprio alla moneta riportata dal Bovi, la riportano al nr. 44 come carlino aggiungendo una nota con la quale, riferendosi all'esemplare del Cagiati indicato come 15 grana, in base al peso debba essere invece considerato un carlino. Qualcuno però potrebbe pensare che tale moneta altro non sia che una moneta da 15 grana tosata e quindi bassa di peso. A mio avviso non è così. Le monete finora note (pochissime) con la presenza dei presunti ramoscelli invece che delle fiamme nei quarti della croce, hanno tutte la legenda praticamente quasi completamente leggibile il che escluderebbe una tosatura drastica che ne giustificherebbe un peso così ridotto. A questo si aggiunga poi che il peso di queste particolari monete è proprio quello del carlino. A supporto poi di questa mia opinione porto a confronto le immagini pubblicate dal Bovi del carlino e del 15 grana. Credo non ci sia altro da aggiungere. Dopo tutte queste chiacchiere posso finalmente rispondere al quesito iniziale: Sì, per me la moneta ex coll. Sambon è il carlino in oggetto. Anche se peso e diametro non sono indicati, le caratteristiche iconografiche sono indizi fondamentali per tale risultanza.3 punti
-
Scherzi? Avanti Savoia! Vi posto il mio scudo da 6 lire di quel duca d’Aosta che si trovò a essere principe e quindi re, dopo che il fratello primogenito morì di vaiolo. Savoia (Torino) Carlo Emanuele III (secondo periodo, monetazione post riforma del 1755) Scudo “nuovo” da 6 lire 1755 Ag 906‰ - diam. 44mm; p. 35.07g (range 34,6 - 35,22) CNI 115, SIM. 33/1, MIR 946a3 punti
-
Non sapevo se anche i Sabaudi erano ben accetti in questa discussione, ma visto che non sono il primo mi fa piacere partecipare con "Riccioli d'oro" Carlo Emanuele IlI su un Mezzo Scudo. Mi sono sempre piaciute in questi busti le borse sotto gli occhi e il doppio mento...3 punti
-
Eccomi, sperando che questa volta non mi succedano pasticci e frattanto auguro a tutti buona Pasqua. Di seguito: Lira da 20 soldi, in argento, titolo 0,948 – mm. 28-29 – gr. 5,74-6,52 D/: NICOLAVS TRONVS DVX foglia d'edera, busto del doge barbuto volto a sinistra con corno ducale; sotto il busto un ramo con tre foglie d'edera R/: SANCTVS MARCVSleone in soldo che regge il libro con le zampe anteriori, il tutto in una corona legata da nastri E' la prima Lira monetata, fino alla sua coniazione la Lira era semplicemente una moneta di conto, virtuale, che rappresentava un multiplo di 20 Soldi. Guardando la faccia del Doge non si può non notare quanto fosse brutto il Tron; non era colpa dell'incisore dei conii, certamente quell'Antonello detto "della Moneta", che operava in zecca in questo periodo e che abbiamo già incontrato. Era proprio brutto il Doge e ce lo conferma un suo contemporaneo che così ce lo descrive: "de grave natura, grosso, bruto de faza; (con la barba ispida lasciatasi crescere per lutto, dopo la morte del figlio a Negroponte - Eubea) avea brutta pronunzia in tanto che parlava spumava pé labbri"; ce lo conferma anche la statua che lo raffigura nel suo monumento funebre nella Basilica di Santa Maria Gloriosa dei Frari di Venezia. (Vedasi sotto)2 punti
-
Ciao ,bronzo di Valeriano I per Anazarbos in Cilicia. https://rpc.ashmus.ox.ac.uk/type/602732 punti
-
è assolutamente il 2° tipo come ben illustrato da @PostOffice la doppia in basso non lascia dubbi2 punti
-
Grazie ancora. Sono andato a consultare il Cagiati. In effetti, si descrive il tipo n. 31 ed è presente il disegno/raffigurazione dell’esemplare descritto, ma -salvo errore - la N pare essere presente.2 punti
-
2 punti
-
Davvero encomiabile la tua signorilità davanti a certi modi di porsi…, specialmente per il servizio che rendi al Forum e a chiunque desideri approfondire. Grazie per il tuo contributo di spessore, a te e a @fapetri2001.2 punti
-
Eccomi ! 😄 Ormai è chiarito che non si tratti di un falso, ma di una delle tante varianti del diritto di questo mezzo scudo, l'unico per Roma con ritratto, di cui stando alla molteplicità di conii, è plausibile che la produzione sia stata cospicua e magari protratta anche per anni successivi al 1777-III. Si tratta in particolare dell'ultimo tipo elencato nella scheda del catalogo lamonetiano, con punto dopo "SEXTVS" ma non prima di "PONT", credo il tipo più raro. Nel tempo ho censito parecchi "diritti", e le differenze sono quelle qui individuate: la punteggiatura, la stola, la presenza o meno del cordoncino annodato. Queste a seguire due che ho in collezione, differenti dal tipo "classico" Muntoni 23, il primo classificabile CNI 29 - Ser. 125, il secondo Ser. 122: Altrettanti conii esistono per il rovescio, anche qui può esserci o meno il punto dopo "AVXILIVM", minime varianti sulla figura della Chiesa, ma soprattutto c'è la data 1777 con il "7" finale su "6", riutilizzo del conio dell'anno precedente: Ciao, RCAMIL.2 punti
-
Continuando con il Cosimo III, qui imbruttito e appesantito, gotta, bigotto e fissato con la religione tanto da ottenere a fine 600 ill trattAmento regio, che consisteva a non doversi piú inchinare alla presenza del papa.2 punti
-
Ciao! È un proverbio biblico contenuto appunto nel libro dei proverbi di Salomone al cap. 15 versetto 22. Complimenti a tutti per l’interessantissima disquisizione, e a milza per il bel francobollo. Un saluto a tutti, in particolare ai due pilastri di questa sezione. Fabrizio2 punti
-
Buonasera Proseguo sempre con Modena e con un ritratto di Francesco III d'Este ma su un sesino! Una piccola meraviglia. Saluti a tutti2 punti
-
Non sono esperto di penale ma spero che sia truffa anche se Sempronio, pur potendo informarsi circa il vero valore del fagiolo prima di venderlo a 1000 euro, decide direttamente di metterlo in vendita a 1000 euro.2 punti
-
Facendo seguito alla discussione “ci metto la faccia”, che ne dite di aprire anche agli altri secoli? Qualcuno, un po’ più timidamente, ha inserito i volti dei secoli successivi… Ma perché non raggrupparli qui? XVII, XVIII… fino all’Ottocento è tutto valido. Comincio io, vi lascio un busto di Ferdinando Gonzaga, dapprima cardinale e poi VI duca di Mantova e IV del Monferrato. Siamo agli inizi del XVII secolo, con un ducatone per Casale datato 1617. N.1 punto
-
Ciao a tutti! Concordo in pieno con quanto esposto da Giovanni. Però è pur vero che lo slab ha un ritorno economico non indifferente, e lo si vede anche dai realizzi. Io non acquisterei una moneta chiusa in slab, ma se dovesse capitare, visto l’indiscusso credito di cui godono a livello mondiale, non lo aprirei proprio per “tutelare” il più possibile il capitale investito. Certo, questo approccio è più da investitore che Vero Collezionista, ma con certe cifre in gioco, credo che molto dipenda anche da come si percepiscono i soldi investiti e dalle proprie possibilità. Qui entriamo in un campo personalisssimo, dove il giusto o sbagliato si riduce a considerazioni molto personali di come si pensa di tutelare il capitale investito (poi… se si hanno risorse infinite tutti questi problemi non me li farei: darei giù di mazzetta e via ) un saluto a tutti! fab1 punto
-
1 punto
-
Grazie per l'intervento, purtroppo non conoscendo a fondo il mondo degli aes rude e pre monetazione varia, facendomi prendere dall'euforia degli oggetti caduti dal cielo e soprattutto sotto consiglio di alcuni utenti di forum di meteoriti ho (giustamente sbagliando) fatto emergere alcune parti dei due oggetti credendo si trattasse appunto di materiale spaziale. Mi sono fatto prendere la mano anche perché in rete ho visto alcune meteoriti tagliate in sezioni o "a fette", quindi mai avrei pensato di poter arrecare un danno così grave a questi presunti oggetti da scambio. Comunque chiedo scusa in primis a me stesso per essere stato così ingenuo (la patina verde doveva farmi riflettere che potesse trattarsi di materiale antico), ed in secondo al mondo della numismatica per non aver rispettato la regola basilare di non spatinare questi oggetti. In conclusione non possiamo quindi affermare che si tratti di aes rude o quanto meno confermarlo al 100%?1 punto
-
Giovane Regina Elisabetta II°, tipo " fiocchetto" secondo tipo.1 punto
-
1 punto
-
1 punto
-
1 punto
-
1 punto
-
Busta in perfetta tariffa posta aera affrancata con due francobolli di Libia serie pittorica cent. 25 probabile dentellatura 14, + un francobollo di Tripolitania cent. 50 Posta Aerea ( per coprire la tassa da cent. 50 P.A.) usuale le buste affrancate con francobolli sia di Tripolitania che di Libia, bollo di partenza Guller "Posta Aerea . Tripoli d'Africa" 2.10.19341 punto
-
T e S timoni, alte LE, visi V O "TESTIMONIAL" TELEVISIVO Ciao. Stilicho1 punto
-
Con l’occasione ricordo il termine per le consegne degli articoli che e’ fine giugno ma consiglio caldamente di inviare prima di quella data visto il numero già importante di lavori ricevuti. Oltre un certo limite fisiologico di pagine dovremo poi riservarli al successivo numero.1 punto
-
Grazie Roberto, in quello postato da @Claudio59 manca del tutto la Croce sulla Stola (giusto?) del Papa. Un particolare molto evidente, un falso cerca di essere la perfetta copia dell'originale, anche se non si può mai dire, ma non è questo il caso, giusto?. Il MIR non riporta questa differenza ma solo le varianti per punteggiatura. Sarebbe ancora più raro, purtroppo questa tipologia,Papali, è talmente ampia e non tanto per quantità ma per varietà che non credo siano state censite tutte e ci vorrà ancora del tempo, molto tempo. Suggerirei di mettere il "tipo" nel catalogo Lamoneta dal momento che è confermata l'originalità. Sarebbe da far periziare cosi potrà essere anche inserito nei futuri cataloghi e libri con più facilità, anche a questo servono le Perizie o almeno dovrebbero. Grazie @rcamil1 punto
-
InAsta 117 del 15 Aprile 2025 Lotto 1969 Ferdinando IV Tornesi 6 1800 sigle R.C. (Regia Corte) Magliocca 381, R31 punto
-
Cari amici Carlo Emanuele IV di Savoia, detto l'Esiliato (Torino, 24 maggio 1751 – Roma, 6 ottobre 1819), fu re di Sardegna, duca di Savoia e sovrano dello Stato sabaudo dal 1796 al 1802. Nacque a Torino il 24 maggio 1751. Era il figlio maggiore del Re di Sardegna Vittorio Amedeo III e dell'infanta di Spagna Maria Antonietta, figlia di Filippo V di Spagna. Tra le sue sorelle vi furono Maria Giuseppina, moglie di Luigi XVIII di Francia (all'epoca conte di Provenza); Maria Teresa, moglie di Carlo X di Francia (all'epoca conte d'Artois); Carolina, moglie di Antonio I di Sassonia (all'epoca principe ereditario). Malaticcio, epilettico, psicologicamente fragile, Carlo Emanuele fu profondamente provato dagli effetti della rivoluzione francese: nel 1793 fu condannato a morte il cognato Luigi XVI, nel 1793 subì la stessa sorte la cognata Maria Antonietta, l'anno seguente toccò all'altra cognata, Madame Elisabeth, e le truppe della repubblica francese fecero irruzione nei domini del padre. Devotissimo, come Amedeo IX, Carlo Emanuele trovò sollievo nella sua fede: nel 1794 divenne membro del terz'ordine di San Domenico, prendendo il nome di Carlo Emanuele di San Giacinto. Sfuggì anche a due congiure finché, sfinito, nel 1802 abdicò a favore del fratello Vittorio Emanuele I entrando poi quale novizio nei Gesuiti. Mori nel 1819 a 68 anni. La sua monetazione non è particolarmente vasta ma è sempre stata molto ricercata perché non è mai stata comune sul mercato numismatico, se si eccettuano i 2,6 soldi in mistura e i 2 denari in rame. Particolarmente negli ultimi anni le sue doppie e mezze doppie d'oro, se in ottimo stato di conservazione, raggiungono quotazioni di tutto rispetto. Il massimale in argento è rappresentato dal mezzo scudo, con due millesimi di grande rarità (1797 e 1800) e due assai più reperibili (1798 e 1799). I pezzi datati 1799 e 1800 sono stati coniati dalla Repubblica Cisalpina nell'ultima parte del 1800. L'esemplare che qui vi presento, da molto tempo in collezione, è di buona qualità; presenta i consueti graffietti di conio al D (neanche tanti) e minimi colpetti al bordo al R. Si tratta di monete di conio basso per cui l'usura è facilmente riscontrabile; da qui le quotazioni non indifferenti per gli esemplari sopra lo SPL.1 punto
-
1 punto
-
E soprattutto dovrebbe segnalare bene il luogo del ritrovamento, perché potrebbe trattarsi di un ripostiglio e magari trovare anche molte altre monete, in questi casi non bisogna mai agire con superficialità @Messe, perché si ricordi che la legge non ammette ignoranza, " ignorantia legis non excusat".1 punto
-
Ciao, dato certo che la moneta sia una riproduzione è altrettanto certo che è riprodotta da aurei autentici. Posto foto del rovescio di un aureo ( giudicato autentico) con identico conio di rovescio della moneta di cui parliamo. A me sembra addirittura meglio definito quello della riproduzione 🙂. ANTONIO1 punto
-
1 punto
-
1 punto
-
È una bella moneta, però a meno che le monete FDC non presentassero rilievi già appiattiti, direi che il consumo nelle parti superiori di entrambi i lati non me la avrebbero fatta classificare come BB se fosse stata mia. In ogni caso resta molto gradevole1 punto
-
Nelle monete Romane quando tutto collima è come come se parlassero... Succede molto spesso fortunatamente. Ma altre volte, invece qualche aspetto non torna pienamente. Se pensiamo che neppure alcune primarie opere esposte nei principali musei sono considerate certamente autentiche, come il famosissimo e bellissimo busto di Nefertiti del Neues di Berlino, ci possiamo consolare. Eppure a mio parere questo rende il tutto ancora più affascinante, perché è una sfida ad entrare in sintonia con il reperto che abbiamo davanti, il che è una forma di amore, e per questo ne abbiamo fatto una passione.1 punto
-
Quelle due , diventando bibliografia, comportano un danno molto più grave che una moneta autentica condannata per falsa…. E così come lo sono i falsari, umani, lo sono anche i periti… ergo… È la diuturna corsa tra scassinatori e costruttori di serrature…. Un giorno è in vantaggio uno e il giorno dopo lo è l’altro.1 punto
-
C'è tempo... Ancora più breve fu la produzione delle half eagles, che iniziata sempre nel 1834, terminò nel 1838. E per entrambi i valori i quantitativi andarono sempre più calando dopo i primi tre anni. Le monete d'oro di Kneass si possono considerare una tipologia di transizione tra le prime e quella che, a partire dal 1839/40, percorrerà tutto il secolo fino a sbarcare nel successivo. (foto da Heritage Auctions) Se guardate bene, al dritto della moneta, tra il collo di Lady Liberty e la data 1838, compare la lettera D. Non è il, ben più famoso, marchio di Denver, ma quello della Zecca di Dahlonega, in Georgia, entrata in funzione proprio quell'anno insieme a quella di Charlotte, nel North Carolina. Nei due stati era stata scoperta una certa quantità d'oro, non tanta quanto quella che sarà in California, ma abbastanza. Oro che, per essere trasformato in monete, doveva essere portato nella lontana Philadelphia, operazione lunga, costosa, e piena di rischi. Così, dopo che per un po' furono alcuni intraprendenti privati a sopperire, aprendo piccole zecche artigianali, crebbe sempre di più da parte della popolazione dei due stati la richiesta per una Zecca ufficiale nelle vicinanze. E alla fine il governo federale li accontentò, aprendone addiritttura due Due Zecche dalla vita relativamente breve, e oggi quasi dimenticate, ma con una significativa particolarità: vi si coniarono ESCLUSIVAMENTE monete d'oro. La loro storia, sarà raccontata in finale di discussione... c'è tempo petronius1 punto
-
Resto del parere che queste emissioni lascino il tempo che trovano. Non so quanto tu le abbia pagate ma, personalmente, avessi soldi da investire in monete d'oro, preferirei acquistare monete autentiche, che oltre al valore del metallo hanno anche un valore storico, piuttosto che delle mere copie che valgono solo l'oro contenuto.1 punto
-
Poi ci sta la genealogia dei Savoia. Poi ci sta anche una interessante tavola di ragguaglio, tra monete estere e Lira italiana e per finire, quello che non deve mancare nell'armadietto farmaceutico della famiglia....1 punto
-
Allo stato dell’arte non lo si può con assoluta certezza , ne personalmente ne tramite analisi con macchinari di vario tipo. si può solo ridurre il margine di errore1 punto
-
Medaglia devozionale, bronzo/ottone della prima metà del XVII sec.- produzione romana.- D/ S. Pietro apostolo volto a DX, aureolato.- R/ S. Paolo apostolo, volto a SX, aureolato, questa tipologia di medaglie veniva particolarmente prodotta durante gli Anni Santi per i pellegrini e visitatori di Roma come atto di devozione e ricordo.- Ciao Borgho1 punto
-
Ciao @niko, mi fa piacere che tu abbia dato un seguito alla bellissima discussione aperta da @Philippus IX! Come nella precedente, "metto le facce" di alcuni pontefici che hanno regnato nel corso del '600. Il XVII secolo è forse per la monetazione pontificia la massima espressione artistica relativamente alla ritrattistica papale, grazie alla grande abilità incisoria dei maestri che si sono succeduti al servizio del soglio di Pietro. La famiglia Hamerani, Mola, St. Urbain, Borner, Lucenti hanno prestato opera proprio durante questo secolo, lasciando sui tondelli da loro incisi segno perenne della loro maestria. Ecco una carrellata di volti dei papi del '600, presentati in ordine cronologico. Sono tutti testoni della mia collezione: Paolo V (1605-1621) Urbano VIII (1623-1644) Innocenzo X (1644-1655) Clemente X (1670-1676) Innocenzo XI (1676-1689) Alessandro VIII (1689-1691) Michele1 punto
-
1 punto
-
Mi permetto di provare a fare una sintesi. 1) Non mi è chiaro l'anno in cui Tommaso Battilana diventa direttore della zecca di Torino, lo stesso catalogo Gigante indica due date (sembra che si contraddica, ma magari c'è una spiegazione), quella del 1848 e quella del 1850. Fatto sta che in tutti i marenghi di Carlo Alberto, coniati fino al 1949, la "B" in scudetto di Battilana non compare. Compare in vece la "P" in ovale di Luca Podestà che fu il predecessore di Tommaso Battilana nella carica di direttore della zecca di Torino. 2) 1849 - Vittorio Emauele II ascende al trono del Regno di Sardegna. 3) I marenghi con l'effigie di Vittorio Emanuele II sono coniati dal 1850 al 1861 nelle zecche di Genova, Torino e Milano (Milano solo nel 1860). Nei marenghi del Regno di Sardegna coniati a Torino dal 1850 al 1861 compaiono in esergo a sinistra la testina d'aquila, segno della zecca di Torino, e la "B" in scudetto di Tommaso Battilana. Nei marenghi coniati a Genova compare invece, in esergo, l'ancoretta, segno della zecca di Genova, e la "P" in scudetto del direttore Giacomo Parodi. Nel marengo coniato a Milano nel 1860 compare la sola "M". 4) 1861 - Vittorio Emanuele II assume il titolo di Re d'Italia. 5) I marenghi con l'effigie di Vittorio Emanuele II re d'Italia sono coniati nelle zecche di Torino, Milano e Roma. 6) Il marengo di Torino. 6.1) Il marengo 1861 presenta in esergo a sinistra la "T" di Torino a destra la "B" di Battilana. 6.2) Ha termine la carica di Tommaso Battilana come direttore della zecca di Torino. Tommaso Battilana è l'ultimo di direttore di Zecca che abbia avuto il proprio segno sui marenghi. 6.3) I marenghi coniati a Torino dal 1862 al 1870 presentano in esergo la "T" corsiva di Torino e la "BN" corsiva della Banca Nazionale. 7) Il marengo di Roma presenta in esergo la sola lettera "R" di Roma. 8) Il marengo di Milano presenta la "M" corsiva di Milano e la "BN" corsiva della Banca Nazionale. Non conosco, purtroppo, chi ha diretto la zecca di Torino dopo Battilana, in ogni caso, come ho già detto, Battilana è l'ultimo il cui segno compaia sui marenghi. Il segno "BN" sta per Banca Nazionale nel Regno d'Italia che è istituto legato in qualche modo al Regno di Sardegna, forse per questo il suo segno compare solo sulle monete di Torino e Milano. Come è noto la Banca d'Italia nascerà dalla fusione di vari istituti nel 1893. Allego questo interessantissimo articolo per approfondimento che darà senz'altro ottimi spunti. Storia economica del Novecento1 punto
Questa classifica è impostata su Roma/GMT+01:00
Lamoneta.it
La più grande comunità online di numismatica e monete. Studiosi, collezionisti e semplici appassionati si scambiano informazioni e consigli sul fantastico mondo della numismatica.
Il network
Hai bisogno di aiuto?






copia.thumb.jpg.7cf94809541082e8333ebd0acb11e958.jpg)
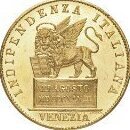




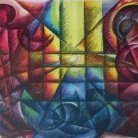


.thumb.jpg.0c713dd4d29897ec1aa5522233f464d8.jpg)










.thumb.jpg.1d3b56d02cc983aaeb9f4d6ee8eebe9a.jpg)