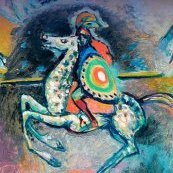Classifica
Contenuti più popolari
Elenco dei contenuti che hanno ricevuto i maggiori apprezzamenti il 06/07/25 in tutte le aree
-
Vi presento un 1 dollaro della Banca di Poyais del 1828. Cosa ha di interessante questa banconota? Seguite la storia e lo saprete! Il colonnello MacGregor, a Londra, nel 1820 annuncia di aver ottenuto, dal re George Fredric Augustus I, i territori del Principato di Poyas nel golfo dell'Honduras. Nel 1821 apre gli uffici della Legislazione di Poyais aLondra, Glasgow ed Edimburgo. Nel settembre del 1822 parte da Londra la prima nave di coloni con destino Poyais, i viaggiatori avevano scambiato sterline con dollari di Poyais (vedi fotografia) ad ottobre dello stesso anno Macgregor emette 2000 obbligazioni del Governo di Poyais in cambio di 200.000 sterline. A gennaio 1823 parte un'altra nave e, al posto di trovare le decantate ricchezze minerarie e agricole trovano i coloni della prima nave provati dalle malattie tropicali. Dopo un anno ritorneranno a Londra 47 persone su 240 partite. Il colonnello MacGregor "trasforma Payais da regno a repubblica" e riesce comunque a fare affari tra la Francia e Londra per 300.000 sterline in obbligazioni della "Repubblica". Tra un arresto e una denuncia il suddetto affarista riesce a piazzare altre 800.000 sterline di obbligazioni tra il 1828 e il 1837. Macgregor aveva inventato tutto: parlamento "tricamerale", coniato la moneta, disegnato mappe… ovviamente era un paese ricco di oro, argento, rame, frutteti… il futuro era laggiù! Storia tratta dal libro: "I maestri della truffa - Quando l'inganno è una questione di stile" Morelli - Schiavano Fotografie prese dai seguenti siti: https://auctions.stacksbowers.com/lots/view/3-5YHC1/honduras-bank-of-poyais-1-hard-dollar-161828-p-nl https://en.numista.com/catalogue/exonumia404385.html6 punti
-
Imitativa di Tetrico I, Antoninano. Al dritto si legge VI TET ovvero M TET. Nelle intenzioni dell'incisore la legenda doveva essere IIVIP TETRICVS ovvero IMP TETRICVS. Poi nella pratica molte lettere sono saltate. Si vede bene il profilo radiato e barbuto. Al rovescio una figura femminile andante a sx. Possibile degenerazione di una Vittoria dove il Raimondi palma, reso stilizzato, si è trasformato in un tridente. Il tondello sembra ricavato da una lamina tagliata a cesoie su due lati. Dato il peso e le dimensioni non si tratta di una imitativa tardiva, probabilmente è da ricondurre al 270/280 d.C. a ridosso della fine dell'impero gallico e/o nei primi anni successivi.4 punti
-
Il 1 gennaio 2026 la Bulgaria entrerà nell'unione monetaria, un risultato ambito da molto nel "paese più povero dell'UE" come spesso (e non del tutto propriamente) viene definita la Bulgaria. Qui si discuterà della fase di transizione dal lev all'euro, che in questo Stato sarà delicata non solo per le ben note speculazioni sui prezzi eseguite ovunque si sia passati all'euro, ma anche perchè la Bulgaria è soggetta da molto tempo a un pesante attacco russo di guerra dell'informazione, con diffusione massiccia di falsità su vari media, appoggio al partito nazionalista filorusso locale (con tanto di risse in parlamento) e manifestazioni pilotate. In ogni caso, per ora è stato stabilito che la fase di transizione fra le due valute durerà solo un mese, durante il quale gli ATM erogheranno solo euro. La transizione sarà supervisionata da più autorità, tra cui l'Agenzia delle entrate nazionali, la Commissione per la protezione dei consumatori, la Banca Nazionale Bulgara, la Commissione di vigilanza finanziaria e il Ministero della governance elettronica. La coniazione delle monete comincerà subito dopo la formalizzazione dell'ingresso da parte dell'UE, a luglio, e naturalmente prima del 2026 saranno messi in vendita gli starter kit. Questo è il sito governativo bulgaro d'informazione sull'euro e il passaggio all'euro: https://evroto.bg/3 punti
-
Martedì 10 giugno alle ore 20:45 al CCNM (Via Kramer, 32 Milano. Citofono SEIDIPIU') si terrà un incontro dove Soci del Centro saranno a disposizione per catalogare le monete a cui non siete riusciti a dare un'attribuzione certa, inoltre si potranno effettuare scambi di monete e banconote. All'incontro, per la tipologia della serata, possono partecipare tutti. Questo sarà l'ultimo incontro prima della pausa estiva, ci ritroveremo a settembre con i consueti due incontri mensili con conferenze ed incontri molto interessanti.3 punti
-
3 punti
-
Ciao buongiorno, Ferdinando II di Borbone è interessantissimo, sembra monotono e uguale ma seguendolo ti accorgerai che ogni moneta è diversa dall'altra anche nella stessa data e vedrai che presto o tardi ti prenderà sempre di più. Come testo di riferimento io ti consiglio il nuovo Manuale Magliocca è un testo unico nel suo genere. Un saluto Raffaele.3 punti
-
Buonasera @Carlo. che piacere rileggerti. Le Borboniche hanno fatto breccia nel tuo cuore. Adesso un 10 tornesi. Vedrai che col passare del tempo ti innamorererai sempre di più. Ottimo acquisto.3 punti
-
Buonasera a tutti, spinto dalla curiosità ho acquistato quella che dovrebbe essere una tessera mercantile. Riporto la descrizione fatta dalla casa d'Aste. Medieval PB Tessera (22mm, 3.94g). Central star; seven pellet-in-circle around. R/ Rosette. Sinceramente è la prima volta che ho la possibilità di tenerne una in mano. Devo dire che è piacevole dal vivo. Non ho idea di come catalogarla, di quale tipo di tessera si tratti e di quale città. Anche di che funzione avesse. Non ho testi ed in rete non ho trovato molto. Ora però mi piacerebbe saperne di più e per questo che chiedo il vostro aiuto. @Oppiano@Vici94 @margheludo Mi perdonerete se non taggo tutti. Cosa ne pensate? Saluti Alberto2 punti
-
Con il senno di poi (e forse per pareidolia) , pare in effetti di leggere qualcosa tipo V I da ore 9 del rovescio (anche se la forma non e' proprio quella di un quadrante😁). Ciao. Stilicho2 punti
-
Mi sentirei più preoccupato se il progetto di una casa fosse firmato da un Perito numismatico....😎 M.2 punti
-
Le informazioni vanno cercate PRIMA di acquistare. E ci vuole tempo per acquisirle. Creati un tuo database fotografico, ben ordinato che ti permetta di studiare le tipologie. Segui il mercato, solo così ti renderai davvero conto di cosa è davvero raro.2 punti
-
Si parla con troppa facilità della patina e della sua (ri)formazione, senza tenere minimamente conto di quanto lo storico della moneta, come ad esempio trattamenti impropri subiti (in questo caso sarebbe meglio parlare di “sevizie numismatiche”) influiscano (e ne compromettano) la sua formazione; non solo allungandone esponenzialmente la formazione, ma anche la sua omogeneità e gradevolezza. Il rame poi è ancora più delicato e suscettibile come metallo, infatti questo esemplare presenta anche vistose incrostazioni di cancro al rovescio che deve essere minuziosamente rimosso con estrema precisione. È già tanto se ripatinerà (e quando…) ma affermare che la patina diventerà pure bella mi pare un azzardo che implichi più fortuna del solito, come fare il passo più lungo della gamba, specie su un esemplare che, mi si perdoni per la sincerità ma credo di non disilludere nessuno, è messo “maluccio”, con un ritratto che è al limite per quanto riguarda il conservare la sua espressività. Carlo, chiedi in merito alla sua rarità… ma come giustamente tu stesso osservi: La teoria è una cosa; la pratica un’altra. Attento che tra le decimali del regno, e queste preunitarie, lo scarto tecnico è importante, e richiede studio e conoscenza del mercato. Detto in parole più povere, rischi di spendere più soldi che invece potresti investire in maniera più produttiva, come ad esempio più libri, cataloghi di collezioni storiche, o esemplari “meno rari” ma messi meglio qualitativamente. Insomma, non buttarti a capofitto negli acquisti: studia, osserva, confronta, cerca, ricerca e ricerca ancora, metabolizza quello che impari, e poi vedrai come la tua visione sarà più ampia, più chiara, e sopratutto più preparata davanti alle descrizioni dei venditori e alle rarità dei cataloghi2 punti
-
Personalmente la libererei dalla plastica,le monete vanno toccate nude, inoltre non si tratta di una moneta rara o in altissima conservazione (che io libererei comunque) quindi la perizia in bustina non le dona né valore né appeal... Comunque ribadisco che non vedo bulinature nei campi ma bisognerebbe averla in mano...2 punti
-
Tutti i nuovi macchinari furono inviati da Philadelphia nel dicembre 1845, e installati nella primavera successiva, ma sebbene la nuova struttura fosse ancora incompleta quello che più ritardava la ripresa della produzione era la mancanza di mattoni per la fornace, che arrivarono l'11 maggio 1846. Fu nominato un nuovo coniatore (il precedente era morto) che entrò in carica in agosto, e finalmente nell'ottobre 1846 le coniazioni poterono riprendere, utilizzando l'oro depositato poco prima dell'incendio. Quell'anno furono coniate 4.808 quarter eagles e 12.995 half eagles Qualche anno dopo, il 7 dicembre 1854, un nuovo incendio scoppiò sul tetto della Zecca, ma stavolta venne prontamente contenuto, e non si ebbero conseguenze. Questo diede però l'occasione al sovrintendente Cladwell per richiedere al Direttore della Zecca un nuovo tetto in metallo, resistente al fuoco Ancora una foto dell'edificio della Zecca di Charlotte, questa non è datata ma, a occhio, direi che non siamo molto lontani da quella del post precedente petronius2 punti
-
Cari Lamonetiani, anche il #12 di Quelli del Cordusio è stato completato. Ora non resta che controllare i testi affinché vengano eliminati errori, sviste ed ogni altra cosa che possa fuorviare la lettura prima della stampa definitiva. Si tratta di un numero corposo che ha superato in pagine il precedente #11: contiene 25 articoli, 13 briciole per 250 pagine circa. Dovrebbe andare in stampa a settembre ed essere distribuito gratuitamente l'8 nomembre al consueto incontro di Milano Numismatica. Per ora vi lascio con una visione d'insieme dello stesso:1 punto
-
Salve a tutti. Con questa discussione volevo oggi focalizzare la vostra attenzione su una rarissima tipologia monetaria coniata a Napoli nei primi anni del regno di Filippo III d'Asburgo (1598-1621). Senza frapporre ulteriori indugi, passiamo alle descrizioni. 1. D/ PHILIPP. III. DG. REX. ARA. VT. SI. Busto radiato, corazzato e drappeggiato volto a sinistra. Sotto, una croce tra due globetti. R/ MARGARI + AVSTR + CONIVXIT Busti dei sovrani Filippo III e Margherita d’Austria affrontati, posti su due cornucopie intrecciate. Tra di loro, nel campo, una corona reale. Sotto, 16.. · M. Pannuti – V. Riccio, p. 140, n° 9 (fig. 1). · Coll. Sambon 1897, p. 89, n° 1099 (tav. VIII del catalogo di vendita) – fig. 2. · G. Bovi, Le monete napoletane di Filippo III, in BCNN, anno LII, 1967, p. 22, n° 3 (tav. I, n° 3, proveniente dalla Coll. Catemario con un peso di 5,92 g.) – fig. 3 e 3 bis. · A. D’Andrea – C. Andreani – S. Perfetto, Le monete napoletane da Filippo II a Carlo VI, Castellalto (TE), 2011, p. 183, n° 23 (rarità: R4). Fig. 1. Immagine tratta da Pannuti-Riccio, p. 140. Fig. 2. Immagine tratta dal catalogo di vendita della Collezione Sambon del 1897, tav. VIII. Fig. 3. Immagine tratta dall'articolo di G. Bovi del 1967 in BCNN, tav. I (ex Coll. Catemario). Fig. 3 bis. In questa immagine sembra che la moneta ritratta sia la stessa già appartenuta alla Coll. Catemario pubblicata dal Bovi e qui riportata in fig. 3. 2. D/ PHILIPP. III. DG. REX. ARA. VT. SI. Busto simile al numero precedente. Dietro il busto, sigla comunemente interpretata come G. R/ Del tutto simile al numero precedente. · M. Pannuti – V. Riccio, p. 140, n° 9a. · Coll. Sambon 1897, p. 89, n° 1100. · G. Bovi, Le monete napoletane di Filippo III, in BCNN, anno LII, 1967, manca. · A. D’Andrea – C. Andreani – S. Perfetto, Le monete napoletane da Filippo II a Carlo VI, Castellalto (TE), 2011, p. 184, n° 24 (rarità: R4). · CNI XX, p. 178, n° 27 (esemplare della Coll. Sambon). Al momento, l’unico pezzo conosciuto di questa varietà fu esitato nell’asta Varesi XXXIII Utriusque Siciliae del 30 maggio 2000, p. 63, lotto n° 316 (fig. 4). Il medesimo esemplare, prima di approdare in questa recente asta, era appartenuto a Giulio Sambon e dalla sua ditta fu venduto nel catalogo della sua collezione a Milano nel 1897. Successivamente, si registrò un altro passaggio in asta Ratto del 5 maggio 1959 (lotto n° 353), per concludere poi in asta Varesi. Fig. 4. Immagine tratta dal catalogo d'asta Varesi Utriusque Siciliae. Come si evince dal titolo, questa interessantissima moneta napoletana dal valore di un tarì (ovvero due carlini), oltre alla rarità e all’importanza numismatica, riveste anche un rilevante significato storico, espresso attraverso l’iconografia del rovescio. Il diritto non rileva nulla di eccezionalmente importante, fatto salvo per la sigla G dietro il busto della variante qui descritta al n° 2, ma che avremo modo di approfondire di qui a breve. Volevo quindi soffermarmi in particolare sul rovescio. La legenda è già di per sé molto eloquente, ricordando il matrimonio tra Filippo III e Margherita d’Austria. Quest’ultima (1584 – 1611) era figlia dell’Arciduca d’Austria Carlo II di Stiria (1540 – 1590) e nipote dell’Imperatore del Sacro Romano Impero Ferdinando I (1556 – 1564). Non era certo di bell’aspetto: i ritratti dell’epoca ce ne tramandando un’immagine caratterizzata dal celebre prognatismo asburgico, tuttavia era di carattere mite, molto religiosa (alcuni l’hanno definita addirittura bigotta) e tutt’altro disinteressata agli affari politici e alle celebrazioni di corte. Nel 1599 sposò il Re Filippo III per procura, portando alla Corona spagnola una dote di 100.000 ducati, e di lì a poco intraprese il viaggio verso la penisola iberica, dove la sua unione regale doveva essere confermata nella capitale Madrid. Durante il suo viaggio verso la Spagna, il corteo austriaco fece tappa a Milano dove, per celebrare la sosta della nuova Regina spagnola, fu inaugurata, nell’allora Palazzo Ducale, la prima sala cittadina predisposta all’esecuzione dell’opera, il cosiddetto Salone Margherita. Alla corte spagnola, Margherita divenne una donna molto potente: ella era affezionata al consorte, così come anche lui esprimeva un sincero sentimento nei suoi confronti, ma non disdegnava l’intromissione, quando era necessario, negli affari di Stato. Il legame tra i due regnanti è ben illustrato su questa moneta: l’unione matrimoniale è simboleggiata dalle cornucopie che s’intrecciano. Questo simbolismo di pace, amicizia e concordia era già stato adoperato nel mondo classico su alcune monete romane sorprendentemente simili, nell’iconografia, a quella in oggetto (fig. 5 e 6, per fare alcuni esempi). Non escludo che l’incisore che curò l’esecuzione dei conii di rovescio per questi tarì napoletani non abbia preso spunto diretto da una di queste due monete romane, forse presenti nelle raccolte reali partenopee già messe insieme dall’epoca aragonese per volere di Re Alfonso il Magnanimo. Fig. 5. Sesterzio coniato a Roma a nome di Druso, figlio dell'Imperatore Tiberio, intorno al 22 - 23 d.C. Le due teste che sormontano le cornucopie sono quelle dei nipoti di Tiberio e figli dello stesso Druso: Tiberio Gemello e Germanico Gemello. RIC I, n° 42 (under Tiberius). Ex NAC 51, lotto 171. Fig. 6. Sesterzio dell'Imperatore Antonino Pio coniato a Roma intorno al 149 d.C. I due bambini le cui teste sono poste sopra le cornucopie sono T. Elio Antonino e T. Aurelio Antonino, i due figli del futuro Imperatore Marco Aurelio e di sua moglie Faustina II, nati proprio nel 149 d.C. RIC III, n° 857. Ex CNG Triton VIII, lotto n° 1142. La Regina dimostrò molto peso nella scelta dei ministri e dei cortigiani che circondavano il sovrano, decretando la caduta di quelli a lei sfavorevoli ed incentivando l’ascesa di coloro che si rivelavano fedeli non solo alla Spagna, ma anche all’Austria, suo Paese d’origine. Era lei, infatti, che spesso decideva che poteva avere contatti con il Re e chi invece veniva escluso da questo rapporto privilegiato. Filippo, dal canto suo, era felice, non senza una punta di opportunismo, di condividere con la moglie i pesi della politica, sia interna che estera. La politica filo-austriaca di Filippo III si intensificò a partire dal 1600, quando, sotto l’influsso della zia Maria Imperatrice del Sacro Romano Impero, figlia di Carlo V, e della figlia di lei, monaca, il Re iniziò ad appoggiare finanziariamente la fazione cattolica attraverso l’Arciduca Ferdinando II d’Asburgo, futuro Imperatore (1619 – 1637) in quella che passerà alla storia come Guerra dei Trent’anni. Alla morte di Margherita, il 3 ottobre del 1611, Filippo, profondamente addolorato per la perdita, non si risposò più. Riprendendo il discorso sul tarì in questione, esso fu coniato a Napoli nell’anno 1600, come dimostra anche la dicitura del numerale 16.. espresso sotto le due cornucopie al rovescio. Ad un anno di distanza, quindi, dal matrimonio tra i sovrani che si era tenuto solo l’anno precedente. Secondo un’ipotesi, sicuramente attendibile, avanzata dal Sambon in occasione della vendita della sua collezione nel 1897, a proposito di queste monete, esse vennero battute per una visita che i Re di Spagna avevano progettato a Napoli proprio per quell’anno, ma che non si realizzò mai. Questi tarì dovevano quindi essere gettati al popolo durante la cavalcata dei Re in visita alla città. In previsione di un simile evento, il nuovo Viceré Fernando Ruiz de Castro Conte di Lemos, insediatosi a Napoli nell’ottobre del 1599 con la moglie Catalina de Zùniga ed il figlio Pedro Fernàndez che gli succederà poi nella medesima carica, ordinò, oltre alla coniazione di queste monete, anche la costruzione di un nuovo palazzo (l’odierno Palazzo Reale in Piazza Plebiscito) per ospitare il Re in visita con la consorte. A seguito dell’annullamento del viaggio reale a Napoli, la costruzione della nuova residenza continuò, mentre molti dei tarì di questo tipo già coniati vennero ritirati dalla circolazione e rifusi per recuperare il metallo in Zecca. In circolazione ne rimasero pochissimi, come ad esempio l’unico esemplare noto descritto qui al n° 2, che risulta anche tosato e che quindi testimonia una discreta quanto movimentata attività di circolazione. Questo provvedimento potrebbe spiegare anche l’eccellente livello di rarità raggiunto ad oggi da questi particolari tarì: partiamo dicendo che solo un esiguo numero di esemplari sfuggì al ritiro ed alla fusione e, per quelli che restarono in circolazione, non tutti sono pervenuti fino ai nostri giorni, il che porta ad abbassare drasticamente il numero di pezzi sopravvissuti alle vicissitudini storiche e quotidiane intercorse in un così lungo arco temporale. Da un primo confronto dei conii dei diversi esemplari qui illustrati, risulta facile notare come per il rovescio fossero stati preparati meno conii rispetto al diritto: le somiglianze tra i conii di rovescio, infatti, sono più strette e calzanti rispetto a quelle dei conii di diritto (in alcuni casi sembra sia stato usato proprio lo stesso conio, ma è difficile giudicare anche a causa della conservazione dei pezzi), il che fa presupporre che furono preparati più conii di diritto, ma, a confronto, pochi, se non pochissimi, di rovescio. Passiamo ora, finalmente, a parlare della sigla G che compare dietro il busto al diritto dell’esemplare n° 2, come già detto, conosciuto, al momento, solo in quest’unico pezzo. Nel periodo in cui furono coniati questi tarì, ovvero nell’anno 1600, nella Zecca partenopea lavorava Giovanni Antonio Fasulo come Maestro di Zecca. Costui, un banchiere di origini napoletane, aveva già ricoperto questa carica a partire dal 1594, sotto Filippo II, continuando a mantenerla anche sotto Filippo III fino al 6 settembre del 1611. Egli siglava le monete con le proprie iniziali: IAF, seguendo una dizione latina “Joannes (o Johannes) Antonius”, e GF, ovvero “Giovanni Fasulo” seguendo invece una dizione volgare, possiamo dire, se vogliamo, in termini più recenti, italiana. Entrambe le sigle sono espresse in monogramma. Nello stesso periodo, come Maestro di Prova, lavorava, accanto al Fasulo, Gaspare Giuno (o Juno), attivo già dal 1591 e risultante in carica fino al 6 giugno 1609. Egli siglava le monete con la lettera G o con GI in monogramma. Ora, nei testi, come ad esempio il CNI XX, viene riportato in merito a questo tarì con sigla, che la lettera G indicherebbe il Maestro di Prova Gaspare Giuno, ipotesi, questa, che è ancora tutt’oggi prevalente nel pensare comune quando si parla di tale moneta. Io, però, ho dei dubbi al riguardo: il solo Maestro di Prova, che, a differenza del Maestro di Zecca non aveva la responsabilità dell’intera attività monetale e non sempre era tenuto a siglare le monete a differenza, invece, del suo superiore, avrebbe potuto apporre la propria inziale omettendo, invece, quella del Maestro di Zecca? In realtà, a livello amministrativo, era quest’ultimo che rispondeva della qualità del lavoro in Zecca e dei prodotti monetari che vi uscivano, non il Maestro di Prova. Dunque, è più credibile che la sigla G non appartenga in realtà a Gaspare Giuno, come creduto finora, ma sia in realtà quella del Maestro di Zecca, ovvero di Giovanni Antonio Fasulo, responsabile della Zecca e, quindi, anche della coniazione di questo tarì commemorativo. Ne deriva che la sigla non può essere letta semplicemente come G, ma come GF (anche secondo criteri stilistici), il monogramma di Giovanni Antonio Fasulo, così come avviene ad esempio in altri nominali napoletani dello stesso periodo dove si ritrovano sullo stesso tondello le sigle GF e G (cfr. il carlino coevo con aquila e legenda di rovescio EGO + IN + FIDE del tipo Pannuti – Riccio, n° 16a). Anche se ci fosse stata la seconda sigla di Gaspare Giuno, essa sarebbe apparsa, probabilmente, sotto il busto del sovrano (come, ad esempio, nel tipo Pannuti-Riccio, n° 9 sotto il busto vi era una croce tra due globetti), come nel predetto carlino, in una parte della moneta che risulta purtroppo tosata. Infatti, non compare nessun’altra sigla nei campi, così come non possiamo immaginare che, in una coniazione ufficiale, appaia solo la sigla del Maestro di Prova, mentre viene omessa (per quale ragione plausibile poi?) quella più importante del Maestro di Zecca che garantiva, appunto, la bontà della moneta. In conclusione, secondo la mia opinione, la sigla che fino ad oggi si è malamente letta come G andrebbe letta per quello che in realtà è, cioè il monogramma GF del Maestro di Zecca dell’epoca. Ipotizzando la presenza della sigla G di Giuno, essa si sarebbe trovata sotto il busto, una parte della moneta purtroppo ad oggi perduta. Tale teoria sarebbe confermata se uscisse un secondo esemplare con la sigla dietro il busto ma con la parte sottostante non tosata. Per le sigle ho fatto molto affidamento su quanto pubblicato da P. Magliocca in Maestri di Zecca, di Prova ed Incisori della Zecca napoletana dal 1278 al 1734, Formia 2013. Ma ora lascio la parola a tutti coloro che vorranno intervenire con le proprie impressioni, commenti ed ipotesi: spero che anche questa discussione possa suscitare il vostro interesse.1 punto
-
Buonasera a tutti, stasera mentre cenavo ho visto la pubblicità alla TV di una nota Industria conserviera, cosa mi ha colpito? Oltre chiaramente al prodotto che è molto utilizzato nelle nostre famiglie, mi ha colpito un affermazione, un chiaro " Fondata nel 1856" mi si sono raddrizzate le antenne Numismatiche, perché proprio stasera avevo deciso di scrivere nella discussione ed avevo scelto una delle mie Piastre 120 Grana di Ferdinando II Falso d'epoca millesimo 1856. Ovviamente credo non si possa fare pubblicità qui nel Forum, sono come da prassi, andato a documentarmi in merito all'industria e sono rimasto di stucco nell'apprendere che sia stata fondata a Torino e non a Napoli come avevo sempre pensato. Tra l'altro uno dei suoi vecchi stabilimenti è a pochi km da dove vivo in Campania. Come anche gli altri stabilimenti storici sono in Campania. Comunque per chi vuol saperne di più (partendo dai miei indizi) basta fare una piccola ricerca in rete, scoprirete che ha a che fare con l'unità d'Italia, oltre ad un importante innovazione conserviera che ha a che fare con Napoleone Bonaparte, insomma un bel intreccio storico/scientifico. Saluti Alberto1 punto
-
Il gioco non vale la candela. Avuto riguardo al valore, la spedizione potrebbe anche passare inosservata. Ma se cosi' non fosse, le potenziali rogne che potrebbe generare quella inconsapevole monetina "regalo"....supererebbero di gran lunga la soddisfazione di averla vinta. M.1 punto
-
Ho spostato la discussione nella sezione Questioni legali.1 punto
-
Ciao Nino,però la prora su quelle monete è diversa. Non potrebbe essere questa emidracma di Kios in Bitinia con nome del magistrato che non riesco a decifrare. Metto una lista. https://www.acsearch.info/search.html?term=Hemidrachm+kios+prora&category=1-2&lot=&date_from=&date_to=&thesaurus=1&images=1&en=1&de=1&fr=1&it=1&es=1&ot=1¤cy=usd&order=01 punto
-
1 punto
-
Hallo Ajax,I found a similar tetrobol of Philip5 of makedonia.you can try to compare head of menad/galley1 punto
-
Salve Paxcaesar,condividono la stessa frattura del punzone nella G ad ulteriore conferma della tua ipotesi1 punto
-
1 punto
-
Come sempre rimarrà anche questa un’altra giornata memorabile nel panorama numismatico nazionale, con il piacere di incontrare nuovamente di persona tantissimi appassionati e professionisti del settore. Imperdibile evento, ho già chiesto il giorno libero per essere anche questa volta uno dei fortunati partecipanti. Tante iniziative che coinvolgono anche i partecipanti, e soprattutto i giovani, che dovranno portare avanti la numismatica proiettandola verso il futuro e le nuove sfide del digitale e dell’intelligenza artificiale.1 punto
-
1 punto
-
Buondì mercatino e ciotola sa 50 centesimi.. mi mancava1 punto
-
Proseguiamo con una piccola escursione figurativa della Slovenia. Da tempi difficili... (occupazione italiana) (Trieste A e B) (Jugoslavia) ...a tempi decisamente migliori. (indipendenza - 7 luglio 1991) (ingresso nell'UE - 1 maggio 2004) (ingresso nell'unione monetaria) (ingresso nell'area Schengen) Oggi la Slovenia è apprezzata soprattutto per la sua natura... ...e per alcune sue specialità gastronomiche.1 punto
-
Hello @Ajax! Grazie mille per l'aiuto e per il tempo che hai dedicato alla mia domanda!1 punto
-
1 punto
-
Buongiorno,è un Ae3 Gloria Romanorvm.Dovrebbe essere Valentiniano I ma non sono sicuro al 100%. https://www.acsearch.info/search.html?id=132311511 punto
-
Salve dall'iconografia sembra costanzo 2 che trascina fuori per i capelli un barbaro dalla capanna.purtroppo non riesco a decifrare la legenda1 punto
-
Buongiorno Fabrizio, certamente. Asta ACM 32 dell’11 aprile 2024 Lotto 583: https://acm-auctions.bidinside.com/it/lot/23913/zecche-italianeznapolizferdinando-iv-/ Un caro saluto.1 punto
-
Buongiorno Raffaele @Raff82, è proprio che ogni moneta è diversa che mi manda in pappa! E quindi ho bisogno di districarmi. Grazie per il suggerimento del Magliocca, appena possibile lo acquisto. E aggiungo: mi rendo conto delle differenze tra quanto leggo da voi esperti sul forum rispetto a quanto ricontro sulla standardizzazione del Gigante che mi induce ad approfondire su un manuale specializzato, perché il poco che ho capito è che la zecca di Napoli tutto ha coniato tranne che monete standard.. 😁1 punto
-
Buonasera @Carlo., certamente ne vale la pena, non in alta conservazione, ma piacevole, tutta leggibile ancora e rara R2. Prezzo più che onesto, complimenti !1 punto
-
Ciao Alberto, sempre molto stringenti le descrizioni di questi oggetti da parte di Aphrodite (Lotto 1119 - Auction G8). Sinceramente, non saprei, ma -a mio avviso- questa tessera plumbea non è da ricondurre ad una tessera mercantile fiorentina. Un caro saluto.1 punto
-
Ciao,guardando bene potrebbe essere anche Caracalla o Elagabalo.. la moneta è abbastanza consumata per capire.Ti metto una lista per provare a identificarla. https://www.acsearch.info/search.html?term=Turreted+edessa+mesopotamia&category=1-2&lot=&date_from=&date_to=&thesaurus=1&images=1&en=1&de=1&fr=1&it=1&es=1&ot=1¤cy=usd&order=01 punto
-
Salve. Vedo solo ora questo rebus e la “reina” a me nota, oltre alla forma antica o poetica di “regina”, è un composto organico derivato dell’antrachinone, presente nelle foglie di rabarbaro, di senna e anche in alcuni licheni: Si presenta in cristalli aghiformi gialli, insolubili in acqua e poco solubili nei solventi organici. Apprendo dal rebus e dalla Treccani che reina sopravvive, spec. in Toscana, come nome del pesce detto comunem. carpa. Grazie rebus! apollonia1 punto
-
Buonasera, In my opinion: Sesino , Ranuccio II Farnese ( 1646 - 1694) , Ducato di Parma & Piacenza ref.nr: MIR 1046 / CNI 100 - 116 Saluti , Ajax1 punto
-
Per quasi tutte loro il valore è comunque quello dell'argento, con o senza cartoncino cambia gran poco... quindi fai quello che ti pare1 punto
-
Bellissima questa discussione, scoperta adesso! Con calma mi ascolterò tutti i brani proposti, mi porteranno indietro nel tempo a quando, nel lontano '97, tra le molte cose che ho intrapreso e non monetizzato, studiavo musica elettronica alla Civica Scuola di Musica di Milano. Bei tempi passati a smanettare con computer e mixer... 🥰1 punto
-
Buonasera a tutti, nuovo arrivato in Collezione Litra68. Rimpatriato dalla Germania, la Scuderia si espande. Intanto la descrizione della Casa D'Aste. Italy, Aquila. Ferdinando I d'Aragona (1458-1494). Æ Cavallo (19mm, 1.77g, 12h). Crowned head r. R/ Horse stepping r.; eagle before. MIR 88; Biaggi 120. Dal vivo si presenta integro, di piacevole lettura con qualche piccolo difetto ma che non ne compromette l'apprezzamento. Aspetto vostre gradite considerazioni. Saluti Alberto1 punto
-
25 articoli 13 briciole 250 pagine circa Un mix di contenuti, periodi storici, zecche varie tra autori giovani e più esperti con gli autori, che se vorranno, potranno raccontarci a Milano Numismatica il loro articolo.1 punto
-
Fuoco alla Zecca! Sabato mattina, 27 luglio 1844, sul presto. Un piccolo incendio, limitato a una sola stanza, fu scoperto mentre il Sovrintendente della Zecca, Green W. Caldwell, era a casa malato. Sarebbe stato abbastanza facile spegnerlo usando la riserva d'acqua per alimentare le caldaie, ma in assenza del "capo" nessuno prese l'iniziativa di farlo. E così, quasi l'intera struttura venne distrutta, la gran parte dei macchinari danneggiati Seguirono molte recriminazioni, ma non venne trovata nessuna spiegazione soddisfacente sulle cause dell'incendio. Il sovrintendente Caldwell sostenne che i suoi alloggi erano stati rapinati, e che il ladro aveva appiccato il fuoco per cancellare le sue tracce. Un inserviente di colore di nome Calvin venne trattenuto come sospetto, ma presto dovettero rilasciarlo per mancanza di prove. Quanto alla ricostruzione della Zecca, fu una cosa tutt'altro che scontata. C'erano stati molti oppositori alla sua creazione nel 1835, e la questione divenne ancora una volta politica. I minatori della regione incominciarono a perdere la pazienza quando videro che, ancora mesi dopo l'incendio, nessuna azione era stata intrapresa. Un'assemblea di minatori si riunì a Charlotte l'8 ottobre 1844 per presentare una richiesta unitaria di ricostruzione della Zecca, ma fu soltanto dopo le elezioni presidenziali di novembre, che portarono alla Casa Bianca James Polk, che il clima politico si rasserenò e si potè finalmente mettere mano al progetto. Ma la spesa non fu autorizzata fino al marzo 1845, e l'appalto assegnato il 16 aprile. Ed ecco spiegato perché, come abbiamo scritto in precedenza, nel 1845 a Charlotte non furono coniate monete E questo potrebbe spiegare anche il fatto che non esistono (o almeno non ne ho trovate) immagini della prima Zecca di Charlotte, se non fosse che è difficile trovarne anche della seconda. Non ne ho trovata nessuna contemporanea all'attività della Zecca, la più vecchia è questa, risalente al 1920, quando ormai a Charlotte le monete non si coniavano più da 60 anni Continua...1 punto
-
Pubblico altra banconota presa a Veronafil. Stavolta ho preso una 100 lire Barbetti azzurrina, è molto malmessa ma si tratta di una “Decreto”, dunque assai rara. L’ho trovata a così poco che non potevo in ogni caso non metterla in collezione. Effettivamente nonostante la conservazione, sta proprio bene insieme alla sua sorella maggiore “Fascio”. Come si sul dire “Chi si accontenta gode 😃”. Appena ho luce favorevole faccio foto più dettagliate1 punto
-
1 punto
-
1 punto
-
1 punto
-
Purtroppo è abbastanza comune in numismatica trovare testi che riportano informazioni senza indicare la fonte di provenienza. Tempo fa uno 'studioso', riguardo un dubbio espresso riguardo le informazioni riportate, quando gli ho fatto notare che non si capiva la fonte da cui aveva estratto queste informazioni, mi ha risposto: "C'è la bibliografia!" Ovviamente, così se metti 10 testi in bibliografia devo leggere migliaia di pagine per sapere dove sta quell'informazione (ammesso e non concesso che non se la sia inventata). La numismatica ha troppi studi con informazioni di dubbia provenienza, teorie che non vengono presentate come tali ma per verità assodate, interpretazioni fantasiose...1 punto
-
Quando citavo tra le peculiarità di questo "tesoretto" la particolare modalità di rinvenimento, in più nuclei, intendevo sottolinearne la singolarità tra i rari gruzzoli di analoga epoca e composizione. Mi spiego: il fatto che fosse composto da divisionali, tutto sommato, di valore medio basso, piuttosto raffezzonati tra le varie emissioni dell'epoca o di poco precedenti ne fa probabilmente uno spaccato del circolante bronzeo durante la guerra greco gotica. Penso anche che in quei frangenti non molti potessero permettersi del denaro sonante in tasca, sicuramente tra quei pochi vi erano i componenti le truppe dei re goti impegnate nella guerra contro i bizantini. Cosa voglio dire con questo? Che probabilmente non si tratta di un gruzzolo unitario sepolto in più tranches ma di più gruzzoli, di proprietari diversi che in un ristrettissimo arco di tempo hanno interrato una serie di piccoli accumuli, piuttosto analoghi come composizione, a causa di un frangente che li ha spinti a comportarsi nel medesimo modo in un medesimo luogo. Dunque il comportamento di queste persone, ripeto forse soldati goti, la tipologia dei piccoli accumuli, il fatto che verso la fine della guerra greco gotica il ritiro delle truppe Franche causò il rastrellamento e quindi la quasi totale scomparsa di qualsivoglia metallo pregiato dallo scenario italiano così creando un terminus post quem per il ritrovamento di torre S. Lorenzo, mi spinge a pensare che la causa di tale nascondimento fu un imminente scontro tra le truppe di Baduila e i bizantini spingendo così i soldati, incerti sull'esito della pugna, a nascondere alla bell'e meglio i loro magri averi. Questo comportamento è ampiamente attestato sui siti di vari campi di battaglia, uno su tutti, Teutoburgo, dove furono rinvenuti moltissimi gruzzoletti nascosti dai soldati romani incalzati dai germani di Arminio.1 punto
Questa classifica è impostata su Roma/GMT+01:00
Lamoneta.it
La più grande comunità online di numismatica e monete. Studiosi, collezionisti e semplici appassionati si scambiano informazioni e consigli sul fantastico mondo della numismatica.
Il network
Hai bisogno di aiuto?