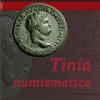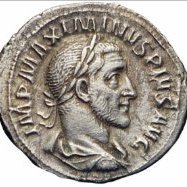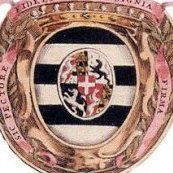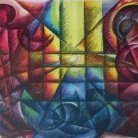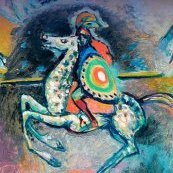Classifica
Contenuti più popolari
Elenco dei contenuti che hanno ricevuto i maggiori apprezzamenti il 07/25/25 in tutte le aree
-
3 punti
-
Buonasera a tutti, riesumo questa mia vecchia discussione perché grazie ad una operazione combinata a tre con gli Amici @Raff82 e @gennydbmoneysono riuscito a portare a casa un 9 Cavalli di Ferdinando IV del 1789, qualcuno potrebbe dirmi che ne ho già tre ma con questo credo di aver fatto Poker 😁. Il venditore lo giudicava MB sono d'accordo. Saluti Alberto3 punti
-
Buon Pomeriggio a tutti, in Francia fino all'Agosto del 1848 era ancora in vigore la complicata tariffa a scalare, che prevedeva diversi importi per le lettere a seconda del peso e della distanza. Il letterato Etienne Arago aveva compreso l'efficacia del nuovo sistema - il francobollo - che dopo l'Inghilterra era stato adottato in Svizzera, Brasile e Stati Uniti. La sua riforma, che doveva entrare in vigore il 1° Gennaio 1849, prevedeva una tassa uniforme di 20 centesimi entro i 7 grammi e mezzo di peso ( poi 40 centesimi sino a 15 grammi e 1 franco fino ad un etto ) per le lettere dirette ovunque in Francia, compresa l'Algeria, che era stata conquistata nel 1830. Per soddisfare le nuove tariffe si dovevano utilizzare i francobolli e le lettere affrancate avrebbero avuto la precedenza su quelle che non lo fossero state. Come quasi tutte le riforme, anche questa venne accolta all'inizio con diffidenza, ma in un paio d'anni s'impose per la praticità ed il bilancio delle poste transalpine migliorò nettamente. La nuova Francia repubblicana volle utilizzare un simbolo che ricordasse la nuova libertà riconquistata ed Arago decretò quindi la raffigurazione della "testa della liberta" Per raffigurare tale idea di libertà, fu prescelta dall'incisore capo della zecca di Parigi Jean Jacques Barre, Cerere - Demetra in greco - dea tutelare dell'agricoltura, come evidente riferimento alla base popolare e contadina della Francia repubblicana. Il volto realizzato da Barre riprendeva un'iconografia classica, con la testa cinta da un serto di spighe di grano ed un grappolo d'uva. Il 1° Gennaio 1849 vennero realizzati due valori : il 20 centesimi nero e l' 1 franco vermiglio. Cerere in francese si dice Cérès ed è con questo nome che i collezionisti d'oltralpe chiamano l'emissione. Il francobollo di ultimo acquisto ed oggi condiviso, è un valore di 1 franco - carminio scuro -, emissione di fine 1849 con annullo. Catalogo Unificato 6. Grazie.3 punti
-
confermo che per la mia esperienza, citando i negozi di numismatica quasi tutte le case d’asta mi hanno autorizzato. forse solo quelle non specializzate (es Pandolfini, etc..) hanno procedure diverse3 punti
-
3 punti
-
Nino, io non sottovaluterei le evidenze soprattutto se sono documentate da studi e pubblicazioni. il mondo contromarche è un mondo dove di certezze ce ne sono poche, tuttavia chi si è cimentato negli studi, Santelli e Campana, mi sembra abbiamo motivato con riscontri le loro ricerche con pubblicazioni che di fatto sono l unico riferimento a questo "mondo". Poi non scinderei le monete dai libri.... sono un unico argomento indivisibile...3 punti
-
Buongiorno condivido un ultimo acquisto,un martoriato sestante,vissuto,punti di corrosione dovuti dal tempo,difetto di fusione sul caduceo,traccia di patina ancora visibili,ma perfettamente identificabile e soprattutto non bulinato. 80 euro più diritti mi ritengo soddisfatto. ANONIME (C. 280 a.C.). Sestante per Roma. AE (g 48,93). Conchiglia; due globetti ai lati. Caduceo; due globetti ai lati. Crawford 14/5; Vecchi ICC, 30; HNItaly 272; RBW -. MB. Nr. Reg. 643/252 punti
-
Buongiorno a tutti! Vivo ormai nel Regno Unito da oltre dieci anni e, in questo periodo, sono riuscito a raccogliere diversi monetieri antichi. Si trovano con relativa facilità e, sorprendentemente, a prezzi molto più bassi rispetto a quelli che riscontravo in Italia: ad esempio, un bel monetiere con decine di cassetti (magari un po’ vissuto) si può acquistare senza problemi per meno di 100-150 sterline. Questa abbondanza riflette una diffusa passione collezionistica che, qui in Gran Bretagna, ha avuto un’enorme popolarità dalla seconda metà dell’Ottocento fino agli anni ’50 del Novecento, ma che si è quasi completamente estinta nel XXI secolo. Da appassionato di storia naturale, posso confermare che anche le cassettiere specializzate per entomologia, geologia, paleontologia (e così via) sono altrettanto comuni. Lo stesso vale per le collezioni ornitologiche, in particolare quelle di uova; oggi, naturalmente, vietate. Personalmente non sono mai stato un grande estimatore dei monetieri con scomparti rotondi, i cosiddetti “tipo inglese”. Proprio per questo, anche se con un po’ di fatica, ho cercato di raccogliere porta monete con scomparti più simili a quelli a cui siamo tutti più abituati, cioè di forma quadrata. Nei commenti a questa discussione pubblicherò le foto dei tre porta monete che possiedo e invito chiunque sia interessato a partecipare, condividendo il proprio metodo di conservazione delle monete o lo stile del proprio monetiere. Martin2 punti
-
Buonasera a tutti. Condivido questo 9 cavalli 1790 conio ibrido, appena entrato in collezione (e rientrato in patria) per sostituire il precedente, messo molto peggio. Mancanza totale di punti al rovescio, dopo C e 9 e, forse, "I" di Ferdinan ribattuta/corretta? Cosa ne pensate?2 punti
-
2 punti
-
Picciolo di Fermo emesso a nome di Francesco Sforza di Cotignola... direi tipologia con biscia coronata nel campo... https://numismatica-italiana.lamoneta.it/moneta/W-FRMFSC/6 Mario2 punti
-
Buongiorno a tutti, la Zanetta di Filippo III con "strano simbolo" è stata fatta visionare anche al Signor Pietro Magliocca per un suo autorevole parere... Vi aggiorno...2 punti
-
Ho provato a fare degli ingrandimenti e anche se le immagini sono quelle che sono si vede abbastanza chiaramente una parte della / che prosegue dopo essersi incrociata con \... Quindi,per me, nessun dubbio che sia una normale X...2 punti
-
2 punti
-
Servirebbero immagini nitide dei dettagli... Io comunque resto del parere che la X c'è ,con colpo che interessa la gamba sinistra tanto da farla sembrare tutt'al più una Y e non una \...2 punti
-
Quindi , perché si verificasse ciò, dovevano essere facilmente riconoscibili per il popolino e per chi era addetto al ritiro…. Ma questo si scontra con le affermazioni che fossero fatti con conii ufficiali e che , addirittura, i serrati siano stati riconosciuti, in certe occasioni, solo dopo una pulizia aggressiva…. come avrebbero fatto all’epoca a ritirarli e metterli fuori corso o sceglierli per un corso forzoso, se cosi identici e irriconoscibili dai buoni?2 punti
-
Buonasera a tutti, Condivido il mio modesto Carlino 1834 con"ciuffo ribelle" come quello postato da Rocco. Saluti2 punti
-
Non ho capito il discorso dei dentellati su quali contromarche dovrei esprimermi? il” sentito dire” a cosa si riferisce? I conii di dritto non sono identici, ma ricavati uno dall’altro2 punti
-
calma calma il follis da 40 nummi di Teodato dove è stato coniato ? Metlich (pag. 125 "Die Study of Theodahad folles") riporta testualmente: "... showing his personal features with his small moustache and his rather well fed appearance"... Gli ori riportano l'immagine convenzionale dell'imperatore (Zeno, Anastasio etc.) dove baffi e barba non ci sono o non sono distinguibili. Le siliquae battute a Roma per Odoacre, a nome di Zeno, mostrano il busto imperiale, convenzionale (senza barba/baffi), idem per Teoderico sotto Anastasio e Giustino. Ma per il bronzo i capi barbari si prendevano sicuramente maggiori libertà. Era il loro terreno di gioco dove potevano godere di una certa autonomia come ci mostrano le emissione dei sovrani goti successivi a Teoderico. Non dimentichiamo che il dominus assoluto era pur sempre l’imperatore d’oriente, il sovrano bizantino che tollerava i re goti solo se soggetti e Giustiniano non aveva esitato un secondo a mandare il suo esercito e uno dei generali piu’ capaci, Belisario, a rintuzzare l’espansione e le mire Gote compresa la riconquista di Ravenna che avvennd nel 540. Metlich a pag. 47 del suo 'seminal' work riporta un follis - per ROMA - a nome di Zeno ma con uno spettacolare ritratto baffuto e barbuto : un probabile restrike di un bronzo imperiale e certamente non il busto di Zenone Il ritratto che vediamo nei nummi di Odoacre battuti a Ravenna puo' essere a ragione considerato una rappresentazione veritiera del condottiero sciro. Idem per Teodato nel suo follis da 40 nummi non solo potentissimo messaggio di autodeterminazione del sovrano Goto in un taglio monetale ben piu' rappresentativo e popolare che le rarefatte emissioni auree, ma anche di una raffinatezza di esecuzione che a Roma non si vedeva dai tempi dei grandi bronzi imperiali. sono sempre piu' convinto che tali rappresentazioni lungi dall'essere imprecisioni esecutive o velleità di artisti incisori piu' o meno bravi, fossero volute dai sovrani per rendere piu' evidente la propria influenza attraverso il fortissimo mezzo di comunicazione che era la moneta ai tempi. # Che Tedoato nel famoso follis fosse raffigurato con i baffi non credo vi siano dubbi. Anche la neutrale wikipedia lo menziona nella descrizione che riporto sotto : Moneta di Teodato (534–536), coniata a Roma. È raffigurato con i baffi da barbaro.2 punti
-
Ora del secondo monetiere! (forse il mio preferito). Me lo aggiudicai su eBay.co.uk circa un anno fa per due spicci. Il vero problema fu il trasporto (ritiro a mano come unica opzione), essendo di un peso disumano per via della copertura in vetro di ogni singolo cassetto, e per via delle dimensioni tutt’altro che convenienti (lungo 1 metro e 50 circa). Logicamente, le dimensioni erano indicate in “feet”, motivo della mia sbadata sottostima della grandezza di questo mobile! Dopo uno sforzo disumano e l’aiuto di qualche amico son riuscito a portarmelo a casa. Monetiere in quercia anni ‘302 punti
-
Salve a tutti, appena arrivato, vi presento il mio primo pezzo . Vista e piaciuta.1 punto
-
DE GREGE EPICURI Oggi voglio mostrarvi questo bronzo di Salonina, uno degli ultimi arrivati. E' per la zecca di Saitta in Lidia, che non era rappresentata nella mia collezione; pesa 5,70 g. e misura 22 mm. Al D, busto a destra; si legge solo: ..NEINAC C... Al R, tempio tetrastilo, con figura al centro. Leggo solo: (E)AC...X e in esergo: ...ITTH... E' descritta nella collezione Winsemann al n.2643; BMC 74; GRPC Lydia 172. In parte simile anche alla Sear 4665, ma con scritte diverse.1 punto
-
Sono contento per te,so che lo cercavi da tempo e alla fine lo hai trovato... Adesso però andiamo avanti con un' altro obbiettivo...😉1 punto
-
1 punto
-
Fai bene a tenerla. La tua moneta avrà anche una storia in più da raccontare. Inoltre, non tutti conoscono la vera composizione chimica delle proprie monete. Un plauso anche alla casa d'aste. Non tutte si sarebbero comportate così.1 punto
-
Sì, si vede anche piuttosto bene devo dire. Aggiungerò le immagini anche del taglio1 punto
-
Grazie, ci provo. Aggiungerò le immagini del risultato1 punto
-
Grazie, effettivamente mi sembrava avere la base sdoppiata Mi spiace, ma non ci ho pensato 2 volte non appena l'ho vista, è davvero difficile anche solo trovarla in foto, con rilievi decenti. Comunque mi è capitato spesso di leggere messaggi bonari che riportano questo tipo di "furti" inconsapevoli, restituisce la misura di quanto siano specifici certi interessi e di come, alla fine, la cerchia sia sempre la stessa.1 punto
-
Concordo con @Carlo., anche per me autentica, intorno al quasi BB / BB. Usura accentuata su entrambe le date.1 punto
-
Ciao @sulinus, a vederlo in fotografia sembrerebbe originale, nell'ordine del qBB, in particolare a causa dell'usura che ha quasi cancellato l'anno (possibile anche una debolezza di conio, visto che altre parti della moneta sono meglio conservate). Non presenta particolari colpi (un piccolo colpetto al bordo ore 7) o graffi deturpanti. Stella su colletto e baffi usurati. Nel complesso ancora gradevole. Ultimamente in asta ne ho visto diverse paragonabili, esitate a 100-130 + diritti1 punto
-
Concordo con tutto quello che ha scritto @Antonino1951. Come valore starei intorno ai 10 Euro.1 punto
-
Bello e ha anche un colore fresco, il cerchietto in alto sa sx non so cosa segnali, un piccolo punto nero? forse un qualche cosa nell'impasto della carta, penso proprio niente di particolare, conosco alcune firme di periti Francesi, ma questa non la conosco e come sempre potrebbe essere la firma di un venditore , in questo caso Francese, buon pezzo da collezione, complimenti1 punto
-
oggi è stato emesso il "bellissimo e significativo" 2 euro belga dedicato al circuito di Spa.1 punto
-
1 punto
-
i bulgari manco sono entrati ufficialmente, che già hanno il programma dei due anni successivi1 punto
-
Buongiorno, il modulo per le assegnazioni inviato a suo tempo conteneva la sola 2 euro Aquino. Marconi è uscita ora.1 punto
-
confermo che non è il mio periodo, dovrei fare paragoni con calma, ma appena ho visto la foto avrei detto Costantino VII ... poi magari mi sbaglio....1 punto
-
Buongiorno, almeno io non saprei aiutarti ma così ad intuito credo sia un bronzetto romano del IV-V secolo, anch'io vedo una figura in piedi..1 punto
-
FO resta, L edile no = forestale di Leno. Buona giornata!1 punto
-
Buona sera, sono in discrete condizioni, direi BB+ la prima (senza strappo) e qBB l'altra, per via dello strappo profondo. La carta mi sembra ancora consistente, il piano di stampa è pulito e la conservazione naturale gli mantiene un bel rosso vermiglione al contrassegno. Il catalogo Crapanzano-Giulianini riporta un prezzo di 120€ x il BB, considerando che i prezzi di catalogo vanno di solito ridotti di un 30/50% azzarderei un valore di 80€ per la prima e 40/50€ per la seconda. La presenza dello strappo su una delle due mi lascia pensare che forse sarebbe meglio venderle separatamente perché difficilmente un collezionista vorrebbe tenere una coppia consecutiva con un difetto simile. Ma è solo una mia sensazione che qualcun altro potrebbe non condividere. Per i prezzi vediamo gli altri cosa dicono. Comunque belle, difficile trovarle in conservazione non trattata.1 punto
-
Tre nodi, retto, dà buca, restati, rana = treno diretto da Bucarest a Tirana. Buona serata!1 punto
-
Aggiungo qui una comparazione visiva tra il fiorino in oggetto e un genovino coevo, con alcuni elementi evidenziati per facilitare l’osservazione delle possibili corrispondenze. Si distinguono, in particolare, tracce compatibili con la cornice polilobata e parte della struttura architettonica tipica del diritto genovese, che sembrano riaffiorare sotto la coniazione del fiorino. Naturalmente non si tratta di una conclusione, ma di un invito al confronto: ogni osservazione, anche critica, sarà benvenuta.1 punto
-
Potrebbe sembrare ma non è, il conio con RES è unico, non ho visto altri conii con qsto tipo di errore, con questo non voglio dire che non ce ne siano altri,a Napoli tutto può essere. Ecco la RES,come si può notareil conio è diverso, ad esempio DEI nella piastra della discussione le lettere che la compongono sono tutte e tre attaccate nella mai sono leggermente staccate o comunque non così vicine.1 punto
-
1 punto
-
1 punto
-
no è Napoli 100%, l'unica cosa che non torna è il simbolo sotto il busto nel frattempo segnalo questo tornese passato sulla baia, caricato dal profilo di un negozio1 punto
-
Buonasera, confesso che neanch'io, come molti, ho resistito alla tentazione di acquistare la mia prima civetta... presa da Savoca, gr 6,8, mm 24. Ero molto felice della cosa ma quando mi è arrivata a casa, vedendola da vicino mi è venuto qualche dubbio. Posso chiedervi cosa ne pensate? In particolare è normale un simile bordo? Vi ringrazio anticipatamente...1 punto
-
1 punto
-
1 punto
Questa classifica è impostata su Roma/GMT+01:00
Lamoneta.it
La più grande comunità online di numismatica e monete. Studiosi, collezionisti e semplici appassionati si scambiano informazioni e consigli sul fantastico mondo della numismatica.
Il network
Hai bisogno di aiuto?