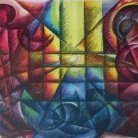Classifica
Contenuti più popolari
Elenco dei contenuti che hanno ricevuto i maggiori apprezzamenti il 08/22/25 in tutte le aree
-
Ultimo arrivo. Tallero coniato a Pisa. del 1595 esistono due tipi. Uno con la legenda al dritto a caratteri più spaziati (questo), di cui esistono ancora almeno 23 esemplari, l'altro, più comune, con caratteri più ravvicinati.8 punti
-
Buongiorno a tutti, eccomi con delle foto fatte da me (non so se possono considerarsi migliori di quelle inviatemi dal venditore). Come detto in precedenza mi farebbe piace un vostro parere sul grado di conservazione della moneta. grazie altra foto altra foto altra foto4 punti
-
Assolutamente no,a meno che non si tratta di monete estremamente rare e di valore... Oppure si può effettuare a fini di studio... L' anno scorso per un' esame metallografico su una moneta in rame mi sono stati chiesti 200 euro...4 punti
-
Buon Pomeriggio a tutti, oggi condivido con voi la mia prima moneta in collezione di San Marino - vecchia monetazione, si tratta di 1 lira del 1898 in argento, zecca di Roma, medio-alta conservazione, patina scura, rara da cataloghi ( tiratura 20.000 esemplari ). La moneta mi è giunta periziata, scusate per le foto. Grazie.3 punti
-
Ciao a tutti, visto che non avevo mai aperto una discussione nella sezione provinciale ho pensato di farlo condividendo con voi un "simpatico" bronzetto di Tito. Dopo i Giulio-Claudi i Flavi sono i miei preferiti, quando ho visto il faccione di Tito non ho saputo resistere, mi sono divertito a ricercare la zecca di coniazione (ci sono diverse Cesaree e questa proprio mi mancava 😀) e a capire il significato delle legende perché sia di greco che di monete provinciali sono completamente a digiuno. Ho scoperto quindi che la Cesarea in questione è in Turchia, l'odierna Kayseri, conosciuta anticamente come Cesarea di Cappadocia o anche come Eusebia, inizialmente ero stato ingannato da Eusebio di Cesarea che è nato si a Cesarea ma "Cesarea Marittima", che si trovava nel regno di Giudea e attualmente nello stato di Israele. Ho tentato di ricostruire le frasi tramite qualche ricerca, al rovescio ho scoperto che si nomina un certo Neratius Pansa al tempo legato provinciale in Cappadocia (questo era di aiuto per l'identificazione della giusta Cesarea) e Galatia, ho cercato alcune info su di lui, è menzionato principalmente in fonti epigrafiche che hanno permesso di ricostruire in parte il suo cursus honorum. Da queste si evince che è stato governatore della Cappadocia e della Galatia dal 77 all'80 quindi questo potrebbe variare e restringere il periodo di coniazione indicato di seguito nella descrizione della moneta. Ma veniamo appunto alla moneta: Tito, Bronzo, Cesarea Eusebia (Cesarea di Cappadocia), 69-79 a.C., RPC 1681 7.57g X 21mm, Bronzo D/ ΑΥΤΟΚΡΑT ΤΙΤΟC ΚΑΙ CΕΒΑΣΤΟC (Tito Imperatore e Augusto); Tito, testa laureata a destra. R/ EΠΙ/ΠΑΝCΑ/ΠPECBEY/TOY EY I (Sotto Pansa, anno 10); su cinque righe, all'interno di una GHIRLANDA Spero vi piaccia e di non aver scritto informazioni errate ma nel caso di sicuro mi correggerete, auguro a tutti una buona giornata, Matteo3 punti
-
Perdonami @tuttologo ma questo tuo atteggiamento non è accettabile. 1. il valore di una moneta dipende dalla conservazione. E' assai probabile che una moneta in buona conservazione valga 50 Euro. Se guardi il venduto vedi che i prezzi di vendita sono variabili. Il pezzo peggiore, venduto a 17 Euro, è in conservazione migliore della tua in cui non si legge nemmeno il valore, ossia non arriva alla conservazione MB. Qui i venduti su ebay: https://www.ebay.it/sch/i.html?_nkw=5+soldi+1675+genova&_sacat=11116&_from=R40&_sop=10&rt=nc&LH_Sold=1&LH_Complete=1 2. é cosa ben nota che i commercianti comprino per rivendere (lo chiamano commercio). Per cui probabilmente lo stesso commerciante pensa di venderla intorno ai 5-8 euro. Però è una vendita difficile. E' Difficile vendere monete in conservazione peggiore di MB, per cui dato che il commerciante assume il rischio che rimanga invenduta, ha valutato di comprarla al valore dell'argento. I soldi sono i suoi e ci fa quello che vuole. 3. é verosimile che il valore della tua moneta si aggiri proprio intorno a quanto detto sopra. Se proprio trovi l'interessato puoi venderla a 10 Euro, ma mi pare difficile. 4. Se ritieni di essere così bravo, vendila tu su ebay a 50 Euro, invece di criticare chi con competenza e pazienza ti aiuta e si becca pure degli insulti. 5. Sarebbe bene scusarti con la comunità. Capisco lo sfogo e la delusione, ma consiglio di modificare i messaggi di sfogo, che ritengo non accettabili.3 punti
-
Ho trovato tra le cose di mio nonno una scatoletta che sembra essere dello Stabilimento Jonhson di Miliano, all'intero ho trovato la medaglietta che ho postato: Come descrizione è molto simile ad: https://numismatica-italiana.lamoneta.it/moneta/W-ME64T/1 Ma il mio esemplare sembrerebbe argento, non sembra assolutamente oro2 punti
-
Buonasera a tutti, quest'ultimo salvo errori è il mio, fa sempre piacere rivederlo. Saluti Alberto2 punti
-
Credo che @tuttologo abbia tutti gli strumenti per valutare il valore della moneta in oggetto anche grazie all'encomiabile lavoro svolto da @Oppiano nell'illustrare i realizzi della stessa moneta negli ultimi anni. Realizzi che sembrano giustificare, anche in base a quanto detto nei vari interventi, la proposta del commerciante. Siamo felici che, nonostante tutto, @tuttologo sia riuscito a trovare un acquirente che l'abbia acquistata a 50 Euro, ben al di là del valore di mercato della stessa moneta nelle ultime aste. Procedo quindi con la chiusura della discussione, non prima di aver editato i contenuti offensivi verso la comunità numismatica e le relative risposte.2 punti
-
Si è dimenticato di scrivere che le monete sono autentiche "riproduzioni".2 punti
-
Mamma mia,non si può guardare,per non parlare del sesterzio di Traiano...2 punti
-
Bell'esemplare, ma si tratta in realtà di RPC II 1682. Le due monete sono quasi identiche, eccettuata una piccola differenza nella legenda del dritto: 1681 inizia con ΑΥΤΟΚΡΑΤωΡ ΤΙΤΟϹ, mentre 1682 con ΑΥΤΟΚΡΑ ΤΙΤΟϹ. Nessuna differenza tra le due al rovescio. 1681 è più rara.2 punti
-
Meravigliosa discussione. Ringrazio tutti i contributori. Per quanto mi sforzi @vitellio io ancora nutro dubbi sulla A terminale dell'esergo di Massimo. Ma I Would TO BELIEVE. E sono affascinato dalla teoria della zecca Tarragonense. Ringraziamo il caso che ha voluto che il "Titivillus numismatico" si accanisse proprio in quel punto per far discutere gli esegeti di numismatica.2 punti
-
2 punti
-
Mediamente (lo vedo anche su altri forum relativi ad altre cose che non sono numismatica) funziona così: in caso di ritardi, problemi, mancate comunicazioni o risposte a richieste, ecc. si comincia a dire peste e corna del venditore, si minacciano cause, qualcuno arriva addirittura ad invocare spedizioni punitive, class action, boicottaggi, ecc. Poi quando dopo un po' di ritardo arriva tutto, allora il giudizio diventa che non erano poi così male, sì un po' disorganizzati ma ok, lenti ma affidabili e via discorrendo ed i propositi bellicosi vengono seppelliti. Pazienza e buon senso sono le due cose che servono, due cose che già prese singolarmente sono merce rara, figuriamoci in coppia.2 punti
-
Riemergono tre statue ad Abu Qair (Alessandria d’Egitto): è la prima scoperta in 25 anni Ad Abu Qair, vicino Alessandria, sono stati recuperati tre imponenti reperti sommersi: una statua con i cartigli di Ramses II, un frammento di figura tardo-baltica e un nobile romano. L’operazione, seguita da autorità civili e militari, segna la più rilevante scoperta subacquea in Egitto dal 2001. Ad Abu Qair, a nord-est di Alessandria (Egitto), sono riemerse dalle acque del Mediterraneo tre statue di grande rilevanza storica. Si tratta della prima operazione di recupero subacqueo di questa portata in Egitto negli ultimi venticinque anni. Alla rimozione hanno assistito le principali autorità civili e militari del Paese, tra cui il ministro del Turismo e delle Antichità, Sharif Fathi, il governatore di Alessandria Ahmed Khaled Hassan Saeed, il comandante delle Forze Navali e il comandante della zona militare settentrionale. Le tre opere estratte comprendono una statua colossale in quarzo raffigurante Abu Houl, che porta i cartigli di Ramses II, una figura in granito appartenente a un personaggio non identificato dell’epoca tardo-baltica, danneggiata al collo e alle ginocchia, e una statua in marmo bianco che rappresenta un esponente della nobiltà romana. La rimozione è avvenuta sotto ampia copertura mediatica, con la presenza di ambasciatori e consoli stranieri, oltre a rappresentanti del Consiglio Supremo delle Antichità e dell’Autorità Generale Egiziana per la Promozione del Turismo. Le statue recuperate ad Abu Qair, vicino Alessandria d’Egitto. Foto: ©Ministero del Turismo e delle Antichit Il ministro Fathi ha espresso riconoscenza alle Forze Armate, alla Marina e all’Autorità di Ingegneria militare per la collaborazione nelle operazioni di ricerca e recupero. Ha inoltre sottolineato il sostegno politico ricevuto dal settore archeologico, indicandolo come un elemento determinante nella salvaguardia dell’identità culturale nazionale. Secondo il ministro infatti, l’Egitto continuerà a rispettare le linee guida della Convenzione UNESCO sul patrimonio culturale sommerso, mantenendo parte dei reperti sul fondale marino e trasferendone altri in superficie seguendo criteri scientifici e regolamenti rigorosi. Il governatore di Alessandria, Ahmed Khaled Hassan Saeed, ha evidenziato invece il valore della scoperta come restauro di una parte della storia d’Egitto, collegandola al processo di trasformazione urbana in corso nella regione. Ha inoltre richiamato i progetti infrastrutturali in atto, tra cui la metropolitana e lo sviluppo del porto di Abu Qair, descritti come elementi chiave per la crescita economica e la valorizzazione del territorio. Anche il segretario generale del Consiglio Supremo delle Antichità, Mohamed Ismail Khaled, ha rimarcato l’importanza del sito. Abu Qair, ha ricordato, rappresenta un’area archeologica di eccezionale rilievo, già interessata da precedenti campagne di ricerca. L’operazione attuale giunge a venticinque anni dall’ultima grande attività di recupero subacqueo, successiva alla firma nel 2001 dell’accordo con l’UNESCO per la protezione del patrimonio sommerso. Le statue recuperate ad Abu Qair, vicino Alessandria d’Egitto. Foto: ©Ministero del Turismo e delle Antichità Le indagini più recenti hanno confermato la presenza di strutture stabili rimaste a lungo sommerse, probabilmente a causa di fenomeni geologici o terremoti che ne provocarono lo sprofondamento sotto il livello del mare. Secondo i dati raccolti, il sito corrisponderebbe a una città di epoca romana, completa di edifici, templi, cisterne idriche, vasche per l’allevamento ittico, un porto e banchine. Alcuni studiosi ritengono possa trattarsi di un’estensione della città di Canopo, di cui resti significativi erano già stati rinvenuti nella stessa zona. La stratificazione del sito ha restituito testimonianze riferibili a diverse fasi storiche, dall’epoca faraonica a quella baltica, romana, bizantina e islamica, delineando una continuità di insediamenti che rende Abu Qair uno dei principali centri di studio per l’archeologia subacquea. Le ricerche condotte hanno permesso anche il ritrovamento di un’ampia gamma di reperti: anfore recanti bolli commerciali e date di produzione, resti di una nave mercantile con un carico di frutta secca e una bilancia in rame per la pesatura, statue reali e figure di Oushabti, ancore in pietra, monete risalenti alle epoche romana, bizantina e islamica, oltre a ceramiche, piatti, vasche da allevamento e una passeggiata marittima lunga 125 metri. Le statue recuperate ad Abu Qair, vicino Alessandria d’Egitto. Foto: ©Ministero del Turismo e delle Antichità Le autorità egiziane hanno dunque annunciato che le ricerche proseguiranno nei prossimi mesi e che ulteriori reperti, tra cui una nave archeologica, potrebbero essere presentati una volta completate le fasi di esplorazione e studio. La prospettiva è quella di un ampliamento delle conoscenze sul patrimonio subacqueo di Alessandria, in un contesto che resta ancora in gran parte inesplorato. La scoperta di Abu Qair si inserisce all’interno di un programma nazionale di valorizzazione del patrimonio sommerso, promosso dalle istituzioni egiziane e sostenuto da diversi enti internazionali. L’obiettivo è duplice: da un lato la conservazione di testimonianze storiche uniche, dall’altro la loro integrazione nella strategia di sviluppo turistico del Paese. Secondo i dati forniti dal ministero del Turismo, nel corso dell’ultimo anno l’Egitto ha accolto circa 15,8 milioni di visitatori, con l’intenzione di incrementare ulteriormente questi numeri attraverso una diversificazione dell’offerta culturale. https://www.finestresullarte.info/archeologia/dal-mediterraneo-riemergono-tre-statue-ad-abu-qair-prima-scoperta-in-25-anni2 punti
-
2 punti
-
Buongiorno a tutti! Partendo da una delle mie ultime acquisizioni, vorrei oggi portarvi indietro a quei turbinosi anni intorno all’anno Mille, anni passati alla nostra memoria scolastica come di apocalittica attesa della fine del mondo, nonostante probabilmente buona parte della popolazione non sapesse che stavano passando mille anni dalla nascita di Cristo… anni pur tuttavia turbolenti e densi di avvenimenti per il Regnum Italiae… anni che videro l’ascesa, il dominio e la caduta di Arduino d’Ivrea, ultimo vero re del Regnum Italiae. Arduino nasce forse intorno al 955 da Dadone, comes mediolanensis e noto possidente “del” comitatus di Pombia. I documenti sono avari di particolari e ricchi di ambiguità: da ciò che si legge nelle carte d’epoca Dadone poteva essere esponente di una famiglia nobile della grande città lombarda, forse semplicemente possessore di terreni in quel di Pombia o forse proprio Comes di quel comitato, ma non è dato di saperlo con certezza. Ciò che traspare, in ogni caso, è che suo figlio non fa parte della dinastia anscarica che aveva dominato la grande marca di Ivrea per buona parte del X secolo. Quando intorno al 990 Arduino riceve l’investitura a marchese d’Ivrea, dunque, non assurge a tale incarico per motivi dinastici, ma riceve un ufficio per chiamata imperiale da parte di Ottone III probabilmente dopo essersi distinto come funzionario efficiente, o forse per meriti militari.2 punti
-
premesso che andando nel discorso stilistico è più facile cadere in impressioni personali che certezze, per quanto mi riguarda il raffronto tra i due pezzi è stato il primo elemento che mi ha fatto dubitare e approfondire il discorso: la costruzione delle lettere è diversissima, la spaziatura, i volumi del volto, il busto e il tratto di incisione mi sono parsi molto diversi... Quanto alle sigle di zecca di sono quasi sempre le prima : AQ per Aquileia; TR per Treviri; BA per Barcino; AMB per Ambianum; AR per Arelate KART o K per Kartago C o CONS per constantinopoli CYZ per Cyzico H o HERAC per Heraclea LVG per Lugdunum N o NIK per Nicomedia OST per Ostia SER per Serdica SIR o SIRM per Sirmium SISC per Siscia TEs o THES per Tessalonica ( per verità anche TS T per Ticinum anche i citati da te Londinium e Roma hanno abbondantemente LON e R e ROM etc. Per Ravenna noterei che è una zecca che inizia molto dopo le altre citate, se non vado errato nella prima metà V secolo e comunque ha anche RAV RAVE etc. Insomma, con le debite eccezioni la stragrande maggioranza è data dalla versione delle prime lettere senza salti Ma.... nessuna da ambiguità tra due zecche : TR è per Treviri da sempre... non penso possa essere duplicata per Tarraco.....( un po' come il concetto delle sigle automobilistiche in Italia ) Quanto a CS per Cesaraugusta...... mah..... non saprei se scioglierla così ...ma in quella siliqua sembra addirittura esserci un punto tra C e S.... Rimane un punto al momento ineludibile : quella non sembra una R (per i motivi sopra esposti) guarda nella seconda siliqua di Costante quanto è diversa ( cfr. foto sotto) La vedi la incisura tra lo stelo verticale e l'arco nella R ? Nella siliqua di Massimo non sembra proprio esserci ( cfr. foto 1 Costante e foto 2 Massimo)2 punti
-
Non è certo, questa, una moneta splendida: alla profondità dell’impronta delle lettere, ben impresse, fa da contraltare un’uniforme usura che appiattisce quasi ovunque la loro superficie, con aree di marcato rimaneggiamento proprio sulle lettere del quadrigramma “ARDO”… la “D” presenta quasi delle “escavazioni” con strisciate parallele del metallo, la “R” presenta dei profondi segni di graffiamento che la sfigurano rendendola poco riconoscibile… Sul margine del tondello, ad ore 5 del diritto un colpo ha generato una profonda indentatura del bordo della moneta, che si insinua a ridosso della “S” della legenda pur senza alterarne la leggibilità ma che ruba sostanza metallica alla moneta impedendole di arrivare al grammo di peso… al rovescio, invece, ad ore 8-9, dal margine esterno si insinua verso il centro una frattura del tondello esile e non pregiudizievole per la sua integrità, ma ben evidente… infine, una brunitura ad ore 10-11 del rovescio evoca quasi l’impressione che la moneta sia stata saggiata col fuoco… È, questa, una moneta che ha “vissuto”, ha circolato, è stata passata di mano in mano testimoniando ai suoi fruitori un potere che cercava di affermarsi anche offrendo un mezzo per la vita quotidiana, per gli ingranaggi dell’economia. È una moneta che parla di un potere non scontato, ma che cerca di legittimarsi un morso alla volta, strappando un giorno dopo l’altro ai suoi contendenti.2 punti
-
Buongiorno a tutti gli amici del forum. Ho cercato questa moneta per un po' e finalmente ho trovato un esemplare abbastanza buono. del periodo Tokugawa . Si tratta di un Hōei Tsūhō, una moneta costituita in bronzo dal diametro di 37,5 mm, dal peso di 2.5 monme (9,37 grammi). Dedico questa moneta a @Kojiki ,appassionato della cultura giapponese.1 punto
-
Buongiorno a tutti, scrivo per chiedere un consiglio di lettura: la visita ad alcuni medaglieri di musei abruzzesi (in particolare quelli di Chieti e Corfinio) ha acceso una certa curiosità nei confronti delle monetazioni centroitaliche e magnogreche, che finora ho sonoramente snobbato nel mio percorso numismatico, sia sul fronte dello studio che del collezionismo. Tempo permettendo, vorrei quindi approfondire un po' il tema e farmi una minima base su queste zone: in particolare, sono interessato all'ambito italico - peninsulare più che alle emissioni siciliane e puniche, e al periodo del IV-II secolo più che all'epoca arcaica-classica. Dopo un minimo di ricerca e lettura del forum, credo di aver identificato come testi principali HN Italy del 2001 e le Monete dell'Italia antica di Catalli: confermate? Escludendo l'aspetto linguistico (sono un lettore fluente in inglese) e quello della reperibilità (ho visto che HN è consultabile online, mentre il Catalli è recuperabile attraverso biblioteche locali della mia zona), mi chiedevo quali fossero i punti di forza per cui preferire l'uno o l'altro dei due volumi come lettura iniziale. Ho anche visto che esistono diversi libri specifici dedicati a singole aree e monetazioni, a cui potrei in caso passare in un secondo momento per eventuali interessi specifici (area campana, Reggio, Puglia...). In particolare, ho notato che, oltre ai vari studi di taglio accademico, ci sono diversi volumetti editi dalle edizioni D'Andreasu alcune aree e zecche (Daunia, Messapia, Teate..): che taglio hanno? Sono approfondimenti / complementi validi o liste-prezziario? Al momento, il mio interesse è soprattutto di taglio scientifico-letterario più che collezionistico, anche se non escludo di poter acquistare qualche pezzo, prima o poi.. mi è però parso di capire che nel settore magnogreco girino diversi falsi: vale solo per i grandi pezzi di età arcaica e per la Sicilia o anche per zecche e nominali più modesti, ad esempio i bronzi di Arpi, Cales o simili? Vi ringrazio in anticipo1 punto
-
Salve, Ho un dubbio circa il segno di zecca su questo grosso. Sul CNI il segno 17 rappresenta uno scudo liscio con crescente al centro, ma qui lo scudo è crociato. Non ho il Toderi né altri testi come il MIR per controllare. O forse è solo che la moneta ha circolato poco, mentre magari quelle con segno 17 nella collezione reale erano più usurate ed il dettaglio dello scudo crociato è sfuggito ai catalogatori? Grazie1 punto
-
1 punto
-
A proposito dello Stabilimento. “Profilo storico Le origini della società risalgono al terzo decennio dell'Ottocento, quando l'inglese Giacomo Johnson impiantò nell'attuale area di corso Venezia un laboratorio nel quale venivano realizzati bottoni e stemmi in metallo stampato. Alla morte del fondatore l'attività venne proseguita dal figlio Stefano che dette maggiore impulso alla produzione di medaglie e contemporaneamente modificò la ragione sociale in "Stefano Johnson - Fabbrica di medaglie". Nel 1860, dopo che l'impianto si era trasferito nello Stradone di S. Angelo, la sede venne trasferita in corso di Porta Nuova n. 15. Negli anni seguenti la produzione di medaglie continuò ad incontrare i favori di un pubblico composto da associazioni, enti pubblici e privati, ordini religiosi ed esponenti delle nobili casate ambrosiane. Nel 1880 alla scomparsa di Stefano, suo figlio Federico - entrato nella ditta quattro anni prima - prese in mano le redini dell'impresa, ponendo in essere una politica di consolidamento e di trasformazione che avrebbe impresso una svolta all'intero complesso aziendale. In particolare procedette all'acquisto degli stampi della Zecca di Milano (cessata nel 1878) e iniziò un lungo processo di ammodernamento dei macchinari che si sarebbe concluso nel 1911 con l'inaugurazione di un nuovo stabilimento. A quella data anche la produzione si era via via orientata verso medaglie commemorative di fatti d'armi e di uomini illustri impegnati nello sviluppo industriale e nella gestione pubblica, a cui si univa l'inaugurazione di una fonderia artistica per opere di grandi dimensioni e quella di un grande salone adibito a museo presso la sede dello stabilimento. Con lo scoppio del primo conflitto mondiale e in seguito alle numerose commesse statali, la produzione si concentrò ulteriormente sui fatti militari per poi essere costretta ad assecondare il gusto imperante durante il periodo fascista. Nell'agosto del 1943 l'impianto sociale subì danni ingenti provocati dai bombardamenti, che costrinsero Stefano Johnson, figlio di Federico, ad interrompere quasi totalmente l'attività per un triennio. Negli anni seguenti, Cesare, figlio di Stefano, provvide a riavviare l'impresa; nel 1949 la sede venne stabilita in piazza S. Angelo n. 1, nel 1958 venne aperto il nuovo impianto di Baranzate di Bollate, alle porte di Milano. Nei decenni seguenti l'attività della società è proseguita nel rispetto di una tradizione che ha sempre visto l'azienda confrontarsi con i migliori artisti del settore e questo in parallelo alla costante ricerca delle soluzioni tecniche più all'avanguardia.” [da: https://www.lombardiabeniculturali.it/archivi/soggetti-produttori/ente/MIDB00184D/]1 punto
-
1 punto
-
1 punto
-
è in bassissima conservazione , con dei graffi, vale il peso del metallo1 punto
-
1 punto
-
Suona il citofono , è il corriere , gli dico arrivo arrivo subito e nel frattempo gli apro il cancello ...esco e non c'è messo ,tranne il pacco nell'erba in giardino ..1 punto
-
Ciao @miza, ti ringrazio. Infatti il cartellino della perizia riporta quasi FDC. Potrei anche togliere la moneta dai sigilli, tanto è ben patinata.1 punto
-
E' stato IL MAGISTRATO a mettere tutto a posto. In realtà era un inviato dell'Alto dei Cieli che il Vaticano aveva chiamato pregando, mentre il Maligno cercava di farlo passare per membro delle Forze del Male.1 punto
-
Quando vedi che un pacco parte, ed ogni giorno si fa dentro-fuori dal magazzino per settimane, poi lo vedi addirittura "consegnato" (ed ovviamente non lo hanno consegnato a te), chiami per chiedere spiegazioni e non ottieni alcuna risposta soddisfacente beh, hai tutto il diritto di incaxxarti, specie se hai fatto ordini di diverse centinaia di euro, altro che pazienza e buon senso... Certo alla fine tutto è bene ciò che finisce bene, ma di sicuro il primo approccio alla nuova e "democratica" modalità di vendita ha fatto acqua da tutte le parti... Ora che lo sappiamo, la prossima volta saremo meno "impazienti" e con "più buon senso"1 punto
-
1 punto
-
1 punto
-
In FDC è un opera d'arte ma anche cosi in mano è una gran bella soddisfazione. Complimenti.1 punto
-
1 punto
-
Il Toderi utilizza le tavole del CNI e non descrive esemplari con il segno 17 né altri esemplari con segno simile al tuo. Mario1 punto
-
Propio questa volevo mostrarvi,e appena entrata in collezione il peso pero e 54,5 Hai ragione,purtroppo queste monete hanno prezzi proibitivi in discreta qualita,questa secondo me e ben legibile anche se deturpata,presa a poco comunque1 punto
-
il pensiero cè stato ed è stato gradito. Come hai ben detto il bollo viola Università degli Studi di Perugia non è postale ma interno dell'Università , mentre il bollo annullatore non è un TR (Tondo Riquadrato) ma un Guller , magari fosse stato un TR nel 1924 sarebbe stata una data tardissima, grazie comunque per il post della mia Perugia1 punto
-
Da Cesarea di Cappadocia, un esemplare di dracma al nome di Tiberio, con al diritto sua testa laureata ed al rovescio raffigurazione della Libertà . Sarà l' 11 Settembre in vendita Gorny&Mosch 313 al n. 165 .1 punto
-
1 punto
-
Un oscuro personaggio che qualcuno vide aggirarsi fra i Palazzi del Potere arrivò a provocare ulteriore inaspettata confusione. Nessuno sapeva chi fosse nè tanto meno che ruolo avesse nella lotta per la liberazione degli ostaggi... alcuni sospettavano addirittura che fosse una figura inventata da maligni nel tentativo di depistare le indagini in corso nel Triangolo della morte Svizzera-Vaticano-UE. Non sapendo nemmeno che nome avesse questo individuo tutti lo chiamavano... il Magistrato1 punto
-
@NoNmi4PPLICO Ciao e grazie per la risposta. Sono andato a ricercarla e ho notato anche che si tratta di una moneta con altre dimensioni rispetto a questa riproduzione 10 Dollars (Indian Head - With motto) - United States – Numista . Ti ringrazio anche per la spiegazione dell'immagine, mi rincuora sapere di non aver detto completamente un cavolata. In effetti avevo letto qualcosa sul web in riferimento alla statua della libertà senza piu' ritrovarlo.1 punto
-
Vi presento allora il denaro meno raro di Arduino, il denaro pavese al titolo di “Ardohinus regem”/“Imperator”: Peso 0,96 g - Diametro 16,0 x 17,0 mm È anche con questo mezzo che Arduino fa propaganda e si presenta come legittimo sovrano. Al diritto, troneggia nel campo il quadrigramma “ARDO”, che riecheggia sì graficamente le lettere “OTTO” dei precedenti denaro ottoniani, quasi a voler rimarcare la continuità del potere e dunque la sua legittimità, ma che è anche inizio del titolo “ARDOHINUS REGEM” che prosegue poi nella legenda, con un’insolita declinazione all’accusativo del titolo regio. L’”imperator” al verso potrebbe invece essere visto come una semplice ripresa dei precedenti denari ottoniani… Eppure, non dobbiamo dimenticare che la corona del Regnum Italiae dava il diritto al proprio possessore di accedere al soglio imperiale… In fondo, già sotto Ottone III, secondo la cronologia scaturita dal ripostiglio dell’area Galli-Tassi, pur non essendoci un “imperator” incoronato in carica, le monete a legenda “inclita civita” al rovescio presentavano l’”imperator” al diritto, quasi un preludio alla futura incoronazione del puer già designato dal lignaggio; ed anche per il successivo Enrico IV di Franconia, incoronato imperatore soltanto nel 1084, non abbiamo motivo per datare la sua monetazione, rigorosamente recante il titolo “imperator”, solo a dopo tale evento. Completa l’iconografia della moneta l’ormai immancabile “PA/PA/I” su 3 righe, ancora una volta come nella ormai consolidata tradizione ottoniana.1 punto
-
Sarà un occasione per conoscere di persona Amici virtuali e non...e tanti operatori da cui ho acquistato in questi anni di collezionismo. Ci vediamo sabato mattina!1 punto
-
Panta rei... tutto scorre... ed il rivolo che scende gorgogliando si trasorma in rivo canoro e poi in fiume:1 punto
-
QUANDO A ROMA GOVERNAVANO I RE In origine, a Roma si diffuse l’idea che anziché barattare le merci fra loro, fosse più utile scambiarle con un bene prezioso e durevole; nacque così l’idea di barattare il bronzo con le merci. Questa cosa la sappiamo per quattro motivi: perché è stato così in tutte le civiltà di cui si hanno notizie (seppure usando beni-rifugio differenti: argento, conchiglie, etc.); perché ce lo riferisce Plinio (“rudi usos Romae”); perché ne resta memoria nel diritto romano, che prevede una serie di accordi compiuti “per aes et libram” (letteralmente “per mezzo del bronzo e di una bilancia”, ossia quindi “pesando il bronzo ricevuto in cambio”); e, infine, perché ci sono importanti testimonianze archeologiche, dato che sussistono diversi casi in cui i pezzi informi di bronzo sono stati rinvenuti insieme a monete vere e proprie. Interessantissimo, in proposito, è il deposito votivo scoperto nel 1852 a Vicarello e ora parzialmente ricostruito nei sotterranei del Museo Nazionale Romano: infatti, si trattava di un pozzo dove i fedeli gettavano una moneta (come oggi si fa a Fontana di Trevi) e lo strato più basso era composto da pezzi di bronzo informe; subito sopra di essi c’erano monete del tipo “aes grave” (di cui si dirà nel prosieguo), a testimonianza che i pezzi informi avevano effettivamente una funzione di tipo monetale ed erano in uso prima dell’aes grave. Per questo tipo di proto-moneta si usa oggi il termine di aes rude (sulla base del citato passo di Plinio, “rudi …”); il suo utilizzo è attestato in contesti archeologici databili dall’VIII secolo a.C. (forse, addirittura dall’XI) sino al IV. Quando Romolo fondava Roma, gli scambi si facevano con l’aes rude. Fra i pezzi di bronzo rinvenuti in contesti archeologici alcuni non sono informi, ma presentano forme ben precise, di natura geometrica (gocce, barre, lingotti, dischi, etc.) o naturalistica (ghiande, astragali, etc.). Non c’è alcunché di strano: se il bronzo veniva scambiato a peso, ben si poteva utilizzare anche metallo dotato di una forma, magari anche per immagazzinarlo meglio. Peraltro, fra quelli di forma geometrica, molti risultano frammenti, ossia sono stati tagliati (a caldo) per ottenere lo specifico peso di cui c’era bisogno. Alcuni studiosi usano la locuzione (inventata) aes formatum per distinguere queste proto-monete da quelle informi, ma sono solo un tipo di aes rude. È importante fare una precisazione: qualunque pezzo di bronzo poteva essere scambiato a peso, per cui oggi c’è un unico modo per distinguere un vero aes rude o formatum da un qualunque altro pezzo di bronzo, ossia ritrovarlo in un preciso contesto archeologico (come a Vicarello); poiché tuttavia i reperti archeologici non possono essere liberamente venduti, ne consegue che non c’è alcun modo di sapere se i pezzi in bronzo venduti da negozi e case d’asta siano effettivamente aera ruda o meno. Si possono inserire in collezione al fine di “riempire un vuoto”, ma occorre sapere che non c’è alcuna possibilità di avere certezza che siano antichi e, quand’anche lo fossero, di sapere se siano stati veramente scambiati a peso (e quindi effettivamente utilizzati come aera ruda) o fossero solo residui di fonderia. Un discorso a parte deve essere fatto per molti oggetti a forma di conchiglia, spesso in piombo e talvolta in bronzo, che vengono rinvenuti in scavi archeologici (databili ai secoli VI-III a.C.) eseguiti nella Pianura Padana e nell’area governata dagli Etruschi. Alcuni studiosi (ad esempio Franco Pezzi, Conchiglie di piombo, Mantova 2010) ipotizzano che siano proto-monete (e, quindi, aes formatum), ma altri non sono d’accordo e propongono che si tratti di oggetti votivi (spesso presentano un forellino di sospensione; la conchiglia simboleggiava la vulva, quindi la fecondità), oppure proiettili asimmetrici per le fionde o ancora pesi per le bilance. L’ipotesi più probabile è che si trattasse di decorazioni o paracolpi per utensili fittili, cui venivano saldate con mastici, argilla o di piombo fuso (spesso infatti presentano tracce di terracotta sulla faccia piatta), oppure di piedini per pentole metalliche. Comunque sia, nulla esclude che le conchiglie in bronzo venissero anch’esse scambiate a peso, come aes formatum, quando occorreva. ________________________________________ A partire da una certa data, ai pezzi di aes rude e formatum cominciano ad aggiungersi altri, che recano un segno inciso nel metallo. Si parla al riguardo, sulla base del citato brano di Plinio, di aes signatum; sotto questo nome si distinguono, tuttavia, tre categorie di oggetti abbastanza differenti. La prima categoria è composta pezzi di bronzo sostanzialmente informi, che recano tuttavia una o più contromarche (cioè, disegni elementari o lettere incise nel metallo). I più diffusi, rinvenuti sia in varie località dell’Italia centrale sia nei Balcani, presentano due contromarche sulle facce contrapposte, una costituita da un punto centrale e 4 raggi che se ne dipartono, l’altra da un arco di cerchio; si ritiene che raffigurino rispettivamente il sole e la luna. Haeberlin, importante numismatico tedesco del XIX secolo, dopo aver esaminato numerosi esemplari di questa tipologia di aes precisa che su altri pezzi esistono anche le combinazioni sole/nulla, sole/sole e luna/luna. Una seconda categoria, molto interessante, è quella del cosiddetto “ramo secco”. Si tratta di lingotti di bronzo a forma di parallelepipedo schiacciato, di peso variabile e fattura grezza, che recano un'immagine in rilievo somigliante a un ramo privo di foglie (più raramente sono presenti altri segni, altrettanto grezzi: lisca di pesce, clava, delfino, crescente lunare), la cui esatta natura è tuttavia discussa (secondo alcuni autori sono un espediente tecnico per far fuoriuscire i gas durante la fusione, oppure segni utili a facilitarne la frammentazione). I lingotti con “ramo secco” sono stati rinvenuti in tutta la penisola e in Sicilia, interi o (più spesso) tagliati in frammenti; quelli interi hanno pesi compresi fra 0,8 e 2,1 kg. Il fascino del “ramo secco” è quello di costituire un oggetto sicuramente utilizzato a Roma (esemplari sono stati infatti rinvenuti in scavi eseguiti in città) e sicuramente databile all’epoca in cui i re governavano sull’Urbe: infatti, un frammento di 0,425 kg rinvenuto presso il santuario di Bitalemi (Sicilia), in uno strato sigillato databile al periodo 570-540 a.C.[1], dimostra l’esistenza di questi manufatti nel VI secolo a.C. Una terza categoria di aes signatum è costituito da un altro genere di lingotti di bronzo, che si distinguono dai “ramo secco” per una iconografia più varia ed elaborata, una forma più definita, un peso più leggero ma anche più omogeneo (tra i 1,8 e 1,2 kg), definiti correntemente “quadrilateri”. A differenza dei “ramo secco”, sono molto rari. Gli studiosi sono concordi nel ritenere che siano stati prodotti a Roma (un tipo presenta anche la legenda “ROMANOM”, forma arcaica per Romanorum); Crawford, inoltre, è convinto che avessero funzione monetale, per cui li elenca nel RRC. Giova comunque precisare che altri studiosi non sono così sicuri che i quadrilateri fossero monete, sebbene indubbiamente alcuni siano stati rinvenuti in ripostigli[2] (a Santa Marinella, La Bruna, Ariccia) assieme a esemplari di aes grave. Ci si potrebbe chiedere, a questo punto, se uno dei tipi di aes formatum noti possa essere quello di cui parla Plinio, inventato da Servio Tullio (che avrebbe regnato dal 578 al 535 a.C.), e permetta così di affermare che la moneta, a Roma, è nata nel VI secolo a.C.; la risposta, tuttavia, sembra essere negativa. In primo luogo, se quella testimonianza fosse attendibile la prima moneta romana dovrebbe essere stata un lingotto con pecora, ma un simile lingotto non è stato rinvenuto (il che ovviamente rende improbabile, ma non impossibile, che sia esistito). I lingotti romani che ci sono pervenuti - ossia i quadrilateri -, peraltro, sono molto posteriori all’epoca regia, probabilmente dell’epoca compresa fra la fine del IV secolo a.C. e gli inizi del III, come dimostrano i ripostigli[3], la legenda ROMANOM (che, ancorché arcaica, appare molto posteriore al Latino di epoca regia, attestato dal lapis niger e dalla fibula praenestina) e la circostanza che un tipo rechi l’elefante (animale ignoto ai Roma prima della guerra contro Pirro, iniziata nel 280 a.C.). Certo, il “ramo secco” esisteva già all’epoca di Servio Tullio, ma non è affatto sicuro che avesse uno scopo monetale (è stato rinvenuto in contesti votivi a Bitalemi e a Terravecchia di Grammichele, ma qualunque oggetto d'arte o di valore, non solo le monete, può costituire l'offerta a un dio) e comunque la sua ampia diffusione fa ritenere che non fosse un manufatto esclusivamente romano (Roma, ai tempi di Servio Tullio, esercitava la sua influenza politica e commerciale su un territorio molto più piccolo). Il passo di Plinio non può quindi essere accettato alla lettera; probabilmente non è vero che la moneta, in Italia, sia stata inventata da Servio Tullio. ________________________________________ Come detto, varie civiltà arcaiche usavano un sistema proto-monetale consistente nel baratto tra le merci e un metallo prezioso; la moneta vera e propria nacque quando alcune autorità statali decisero di far punzonare questi metalli, per garantirne il peso (e quindi il valore) e velocizzare, così, i commerci (perché diveniva inutile pesare il metallo). Questa evoluzione si verificò dapprima in Cina (tra l’VIII e il VII secolo a.C.), poi, in modo separato e indipendente, in Asia Minore. Qui infatti era tradizione scambiare le merci con palline di elettro (una lega di argento e oro); a un certo punto (secondo la tradizione, nel VI secolo a.C., a opera di Creso re della Lidia; secondo gli studiosi moderni prima, attorno alla metà del VII secolo a.C.) i governanti cominciarono a far punzonare queste palline, che presentavano quindi un segno “in incuso” (cioè incavato, rispetto alla superficie della moneta). Poco dopo si cominciò ad apporre un segno anche sull’incudine e nacque, così, la tecnica della coniazione; inoltre, furono prodotte anche monete d’argento, oltre che di elettro. La moneta ricosse subito un grande successo; tutte le città greche dell’Asia Minore cominciarono a produrla e a diffonderla, attraverso la loro fitta rete di contatti commerciali, in tutto il mediterraneo, occidente compreso. Tornando alla Roma arcaica, sembra strano che all’epoca dei re dentro l'Urbe non si usassero monete (come si vedrà in seguito, le prime monete romane, aes grave e monete romano-campane, sono probabilmente databili alla fine del IV secolo a.C.) e ci si limitasse a ricorrere al baratto fra le merci e il bronzo a peso (aes rude e formatum). Si ritiene, infatti, che il tempio eretto nel Foro Boario nel 495 a.C. (l’Ara massima di Ercole) non fosse altro che la monumentalizzazione di un altare preesistente (e, quindi, risalente all’epoca regia), dedicato a una divinità locale assimilata al fenicio Melqart, protettore dei mercanti; sarebbe quindi questa una testimonianza indiretta che in quel luogo in epoca antichissima, addirittura prima della fondazione di Roma, esistesse un sito di scambio fra merci portate dai mercanti fenici e prodotti locali, ma è tuttavia difficile immaginare l’esistenza di scambi commerciali di portata addirittura internazionale senza l’utilizzo di un qualche genere di moneta. Per queste ragioni, uno studioso[4] ha ipotizzato che la Roma arcaica non abbia emesso proprie monete perché utilizzava proprio monete greche arcaiche; non c’è alcuna prova archeologica al riguardo, però c’è un importante indizio. Infatti, tra il 1862 e il 1867 sono stati rinvenuti una serie di ripostigli di piccole monete di tipo ionico, risalenti al VI-V secolo a.C., a Morella e Pont de Molins (in Spagna), Auriol[5] (presso Marsiglia, città fondata dai Greci) e Volterra, città etrusca; ciò dimostra che gli Etruschi utilizzavano monete greche. Siccome a Roma, nel VI secolo a.C., dominava una stirpe etrusca (i Tarquini), è molto probabile che monete analoghe siano state utilizzate anche nell’Urbe. NOTE [1] Si definisce “sigillato”, in archeologia, uno strato di terreno che appare chiaramente separato dagli strati sovrastanti (generati da eventi o attività successivi), senza interruzioni o intrusioni (causate da riutilizzo del terreno, erosione, contaminazione o distruzione) che potrebbero averne alterato il contesto originario. Gli oggetti rinvenuti in uno strato sigillato sono sicuramente databili all’epoca dello strato. Su questi scavi ha scritto Piero Orlandini in “Annali dell'Istituto Italiano di Numismatica”, 1965-1967. [2] È molto frequente trovare gruppi di monete duranti gli scavi, perché nell’antichità nasconderle era un modo per conservare i propri risparmi; tali gruppi sono oggi definiti “ripostigli” o “tesoretti”. [3] È bene notare, tuttavia, che i ripostigli, anche quando possono essere datati con relativa sicurezza (come negli strati sigillati), forniscono solo indizi e non certezze sull’epoca di emissione delle monete, perché non si sa per quanto tempo esse abbiano circolato prima di essere state nascoste. [4] Amisano, La storia di Roma antica e le sue monete, vol. 1, 2004. [5] Siccome il rinvenimento di Auriol è il più numeroso (circa 2.130 monete), si parla al riguardo di “monetazione tipo Auriol”. ILLUSTRAZIONI Esposizione di aes del Museo nazionale Romano. Al centro, frammenti di aes rude raccolti in una bilancia. In alto, due quadrilateri, RRC 4/1 (con pegaso e ROMANOM) e RRC 7/1 (con raffigurazione di uno scudo). A destra, un “ramo secco” Ricostruzione del deposito di Vicarello, dal Museo Nazionale Romano Ramosecco del Museo Civico Archeologico "A.C. Simonini" Il "ramosecco" rinvenuto a Bitalemi Monetazione "tipo Auriol" rinvenuta a Volterra1 punto
-
PREMESSA Un amico, del tutto profano in materia numismatica, mi ha chiesto perché la monetazione romana repubblicana mi affascini tanto. Ho deciso allora di scrivere queste poche righe pensando a lui, a come spiegargli la mia passione. Questo non è quindi un trattato di numismatica, e men che meno di storia. Contiene sicuramente approssimazioni, probabilmente imprecisioni, forse errori. La scelta degli eventi narrati e delle monete che li illustrano è del tutto arbitraria e priva di una vera logica. Questo è un racconto, un tentativo di comunicare emozioni: le emozioni che promanano dalle monete repubblicane, per chi ama il ricordo di quei sette secoli in cui la città di Roma creò, dal buio della preistoria italica, la storia stessa dell'Occidente. INTRODUZIONE La storiografia romana antica è carente e contraddittoria in materia di monetazione. L’unico riferimento alle origini è un passo di Plinio[1], in cui si afferma che “Servius rex primus signavit aes. Antea rudi usos Romae Timaeus tradit. Signatum est nota pecudum unde et pecunia appellata” (“Il re Servio [Tullio] per primo segnò il[2] bronzo. Timeo[3] riferisce che a Roma, in precedenza, era in uso il[4] [bronzo] rude[5]. [Il bronzo] fu segnato con un’immagine di pecore e perciò [le monete] furono chiamate «pecunia»”). Questo passo è tuttavia ritenuto attendibile solo in ordine al fatto che venisse usato bronzo rude e poi segnato, mentre il riferimento a Servio Tullio è oggi ritenuto leggendario. La moneta più importante della storia di Roma, che continuò a essere emessa per molti secoli e si diffuse in tutto il mondo antico, fu il denario, moneta in argento. La data di introduzione del denario è molto dibattuta, come si vedrà; anche riguardo a essa abbiamo due testimonianze di Plinio[6], che però non aiutano perché sono molto oscure e parzialmente contraddittorie. La prima testimonianza afferma “Populus Romanus ne argento quidem signato ante Pyrrhum regem devictum usus est” (“Il popolo romano neppure usò argento segnato prima della sconfitta del re Pirro”, avvenuta nel 275 a.C.). La seconda invece riferisce che “Argentum signatum anno urbis CCCCLXXXV Q. Ogulnio C. Fabio coss. quinque annis ante primum Punicum bellum. Et placuit denarium pro X libris aeris valere” (“L’argento [fu] segnato quando erano consoli Quinto Ogulnio e Gaio Fabio, nell’anno 485 della città, cinque anni prima della prima guerra punica. E si decise che il denario avesse valore di 10 libre di bronzo”; l’anno indicato è il 269 a.C.): si noti che le due frasi, quella sull’ “argentum signatum” e quella sul “denarium”, sono giustapposte; considerato che l’opera di Plinio è estremamente sintetica, non è detto che egli parli in entrambre della stessa moneta. A partire da un certo anno in poi si verificò a Roma un fenomeno unico nella storia antica (e forse anche moderna): l’iconografia[7] dei denarî cambiava ogni anno; la città che dominava ormai il mondo poteva infatti permettersi il lusso di emettere migliaia di monete differenti e nessuno, nel suo vasto impero, dubitava che quei dischetti d’argento provenissero dall’Urbe. Questa mutevolezza si spiega con la volontà dei nobili che prestavano la loro opera come monetieri (ossia la magistratura preposta all’emissione delle monete, in Latino “tresviri aere argento auro flando feriundo”, “tre uomini responsabili di fondere e battere bronzo, argento e oro”), di utilizzare le immagini impresse sulle monete per fare pubblicità alla propria gens (e quindi, indirettamente, a sé stessi). Questa situazione ha portato gli studiosi moderni a cercare di indovinare l’anno esatto di emissione di ogni moneta (tenendo conto che in uno stesso anno potevano esserne emesse anche più di una); non c’è alcuna sicurezza su queste datazioni, però sono state ottenute incrociano una serie indizi[8] e pertanto si possono ritenere abbastanza indicative, per il periodo più antico (fine del IV e III secolo a.C.), e sostanzialmente attendibili, per quello più recente (II e I secolo a.C.). Questi sforzi sono stati raccolti e compendiati da Michael Crawford in un’opera fondamentale, Roman Republican Coinage, edito nel 1974, in cui egli elenca tutte le monete note al suo tempo (alcune, rarissime, sono state scoperte dopo[9]), le raccoglie in “serie”, assegna loro un numero di elenco e ne propone la datazione. Quindi, quando si trova scritto nei testi di numismatica “RRC 100/1” oppure “Cr. 100/1” significa “la moneta che Crawford, nel libro «Roman Republican Coinage», elenca come la n. 1 della serie n. 100”. ________________________________________ Esistevano nell’antichità due tecniche per produrre le monete, fusione e coniazione. Nella fusione, l’immagine della moneta viene riprodotta in negativo all’interno di uno stampo (di terracotta o, in epoca moderna, di materiali sintetici), dopo di che viene fatto colare il metallo fuso all’interno dello stampo; quando il metallo si raffredda viene aperto lo stampo e se ne estrae la moneta. I disegni che nell’antichità si potevano ottenere con questa tecnica erano, tuttavia, molto molto grezzi. Nella coniazione, invece, l’immagine della moneta viene riprodotta in negativo sulla faccia di un’incudine e su quella di un martello, detto “martello di conio” o anche solo “conio”. A questo punto si appoggia sull’incudine un dischetto di metallo riscaldato, detto “tondello” (preparato prima, per fusione) e lo si batte con forza con il martello, imprimendovi così il disegno. La coniazione, a differenza della fusione, permette di realizzare monete con disegni piccolissimi e precisissimi. Osservando le differenze nei disegni delle singole monete (dovute al fatto che i conî venivano incisi a mano), si può oggi distinguere quali di esse provengono dallo stesso conio e, quindi, calcolare quanti conî sono stati usati per produrre i pezzi giunti fino a noi. Supponendo che ciascun conio di rovescio venisse sostituito, a causa dell’usura, dopo che erano state battute (secondo le diverse opinioni degli esperti moderni) da 10.000 a 30.000 monete (un po’ meno per quelli di dritto, maggiormente esposti all’usura), si può oggi stimare il volume di emissione di una moneta; talvolta, ammonta a milioni di pezzi. Quando si illustrano le due facce di una moneta, ci si riferisce a esse come “dritto” e “rovescio”. Nelle monete coniate, il rovescio è la faccia risultante dal colpo di martello, il dritto quella appoggiata sull’incudine. Siccome inoltre i Romani avevano l’abitudine di raffigurare spesso, al dritto, la testa di un dio (e in seguito quella dell'imperatore), si parla di “dritto” anche per le monete fuse, con riferimento alla faccia su cui è presente tale testa. ________________________________________ Viene naturale chiedersi, a questo punto, quanto valevano le monete romane? Possiamo farcene un’idea con riferimento alla metà del II secolo a.C. Polibio infatti narra (II, 14, 35) che in Gallia Cisalpina, ove egli si recò fra il 151 e il 150, “un medimno siciliano di frumento costa per lo più 4 oboli, uno d’orzo 1 obolo e un metrete di vino costa quanto un medimno di orzo”; egli stesso riferisce che l’obolo, moneta di tradizione greca, era cambiato per 2 assi romani. Considerato che un medimno (misura di capacità corrispondente a 51,8 l) poteva contenere circa 40 kg di grano mentre il metrete era paro a 39 l, si ricava che con una asse si potevano comprare 5 kg di grano o 20 l di vino. Si capisce tuttavia, dal resoconto di Polibio, che egli riteneva questi prezzi estremamente bassi; supponendo che a Roma essi fossero circa 5 volte più elevati[10], ne consegue che con un asse si potesse comprare 1 kg di grano oppure 4 litri di vino (non pregiato). Si può quindi affermare che a metà del II secolo a.C. un asse valeva circa 4 €[11]; per quanto riguarda il denario, non sappiamo se all’epoca fosse cambiato a 10 o 16 assi (ci fu una riforma, proprio in quegli anni), per cui poteva valere da 40 a 65 €. Ovviamente, prima di tale data l’asse valeva di più, in seguito invece di meno (perché ci fu un costante fenomeno di svalutazione, nei secoli). Sappiamo che un secolo dopo, ossia alla metà del I secolo a.C., i braccianti di Pompeo ricevevano da 5 a 16 assi al giorno. NOTE [1] Naturalis Historia, XXXIII, 3, 13. [2] Nel senso di “fece apporre un segno al”. [3] Storico di cui non ci è pervenuta l’opera. [4] Letteralmente: “riferisce gli utilizzi in precedenza, a Roma, del”. [5] Nel senso di “grezzo”. [6] Naturalis Historia, XXXIII, 42 e XXXIII, 44 [7] In numismatica, per “iconografia” o “tipologia” si intende la scelta dei “tipi”, ossia dei disegni riportati sulle due facce delle monete. [8] Fra cui: i risultati archeologici (se una moneta è rinvenuta nelle rovine di un tempio distrutto nell’anno X a.C., deve essere precedente; se due monete sono rinvenute assieme e una è nuovissima, l’altra molto usurata, è probabile che la seconda sia stata emessa prima); il peso (nei secoli, il peso delle monete è diminuito sempre più); l’identificazione del monetiere (se una moneta è firmata “Pinco Pallo” e sappiamo che un certo Pinco Pallo è stato console nell’anno X, supponendo che sia la medesima persona se ne ricava che possa essere stato monetiere alcuni anni prima di X); il significato delle immagini (una moneta che inneggia alle vittorie di Silla non può essere stata emessa quando a Roma governavano i seguaci di Mario). [9] Tutte le monete repubblicane oggi note possono essere visionate nell’archivio al link https://numismatica-classica.lamoneta.it/. [10] A conferma di questa supposizione rileva la notizia per cui, poco dopo il 124 a.C., la lex frumentaria di Gaio Gracco impose di riabbassare i prezzi del grano (che, nel frattempo, erano aumentati) a 6 assi al modio; considerato che un modio (circa 8,75 litri) poteva contenere circa 7 kg di grano, si ricava che Gracco fece riabbassare i prezzi a 1 asse per 1,15 kg. [11] Solo per dare un’idea, dato che un conto esatto imporrebbe di conoscere il prezzo di un ampio paniere di prodotti.1 punto
-
Buonasera a tutti, Pareri su questa moneta che ho recentemente aggiunto alla collezione?1 punto
Questa classifica è impostata su Roma/GMT+01:00
Lamoneta.it
La più grande comunità online di numismatica e monete. Studiosi, collezionisti e semplici appassionati si scambiano informazioni e consigli sul fantastico mondo della numismatica.
Il network
Hai bisogno di aiuto?